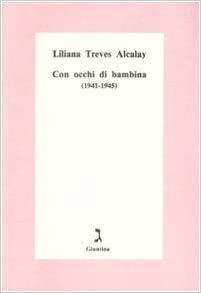File:1994 Treves.jpg
1994_Treves.jpg (201 × 293 pixels, file size: 4 KB, MIME type: image/jpeg)
{it} Liliana Treves Alcalay. Con occhi di bambina, 1941-1945. Firenze: Giuntina, 1994.
Abstract
- Review, by Sara Valentina Di Palma:
Già il titolo in sé è espressivo per comprendere la prospettiva: come la testimone afferma nella premessa (p. 12), si tratta de “La storia dei miei primi cinque anni di vita visti con occhi di bambina”. In un’intervista a Sara V. Di Palma (11 ottobre 2000), Liliana afferma che Nel momento in cui ho dovuto scrivere [per il libro] è stato proprio come un ripiombare o un ritornare volutamente a quei momenti. Quello mi ha ancora di più fatto venire a galla certe sensazioni. […] cercavo di concentrarmi, di ritornare bambina, innanzi tutto perché volevo scrivere con quel linguaggio, e poi perché volevo ri-sentire le mie sensazioni. E le ho sentite, era una cosa incredibile come ho rivissuto queste fasi di incredulità, di rabbia contro gli adulti, di timidezza dopo, di non saper parlare. […] è stato un processo di riflessione, ma poi proprio di riascoltare e di ri-sentire le sensazioni di una volta. La scelta di scrivere ‘con occhi di bambina’, con il linguaggio infantile, è stata voluta: lo volevo fare come una testimonianza per i bambini.
Nata nel 1939, Liliana ha quattro anni quando, dopo l’8 settembre 1943, la famiglia decide di nascondersi. Il suo primo contatto con la guerra è molto confuso e vago. Durante l’intero periodo della persecuzione, la bimba viene tenuta all’oscuro degli eventi, nel tentativo forse di proteggerla e di non gravarla con un peso eccessivo, sebbene il suo straniamento e la sua incomprensione degli adulti aumentino a dismisura.
Come accade a Donatella Levi, anche Liliana assiste sgomenta alla debolezza paterna di fronte alla paura che alla sua bambina e al resto della famiglia possa accadere qualcosa di terribile, e analogo è lo sgomento provato per l’assunzione di un nuovo nome, elemento di disturbo psicologico.
Assai diversa è invece l’esperienza, centrale nella testimonianza, della fuga in Svizzera: non si tratta della fine delle sofferenze, ma anzi di un nuovo doloroso capitolo. Liliana è infatti costretta, similmente a molti bambini nascosti presso altre famiglie nei territori occupati dal nazismo, a cambiare di continuo sistemazione senza riuscire ad adattarsi, sballottata da una casa all’altra dove la attendono persone non sempre affettuose e disinteressate. È il terzo luogo dove Liliana è mandata, a causarle la sofferenza più grande: ospitata da tre sorelle che l’hanno accolta solo per usufruire delle sue tessere annonarie e che le mostrano apertamente indifferenza e disprezzo, Liliana è privata dei beni che le spettano e inizia a deperire; a ciò si aggiunge lo sprezzante antigiudaismo cattolico delle tre zitelle che la puniscono perché non fa il segno della croce, non va a messa e appartiene al popolo degli uccisori di Cristo. Le vessazioni subite, ottengono in realtà l’effetto contrario, vale a dire il rafforzamento dell’identità ebraica della piccola, la quale non cede al ricatto di dover fare il segno della croce e ogni sera recita lo Shemà come raccomandatole dalla madre.
La liberazione significa dunque, per Liliana, non tanto la fine della guerra, quanto la fine della disperazione, con l’arrivo dei genitori e dei fratelli che la portano via dalla casa delle tre zitelle.
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| current | 14:50, 9 September 2020 |  | 201 × 293 (4 KB) | Gabriele Boccaccini (talk | contribs) |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following page uses this file:
- Italian Jewish Studies--1990s
- Italian Jewish Studies--Italian
- Holocaust Children Studies--1990s
- Holocaust Children Studies--Italian
- Holocaust Children, 1939 (subject)
- Holocaust Children, Italy (subject)
- Holocaust Children, Italy, Memoirs (subject)
- Holocaust Children, Memoirs (subject)
- Memoirs, Jews Italy (subject)
- Hidden Children (subject)
- Hidden Children, Italy (subject)
- Switzerland from Italy (subject)
- Holocaust Refugee Children, Switzerland (subject)