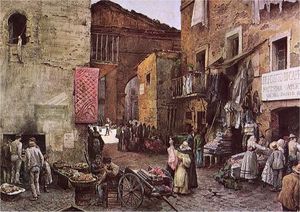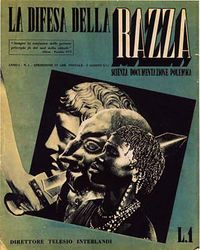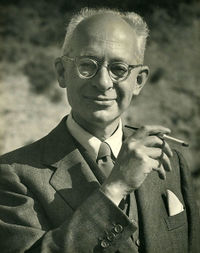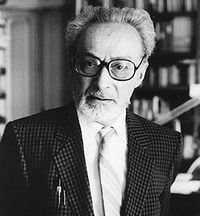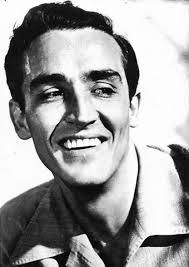User talk:Gabriele Boccaccini
Cristo unica ed inclusiva via di salvezza: il Paolo ebreo e il Paolo luterano.
Gabriele Boccaccini, University of Michigan
La critica del "Paolo luterano" sembra essere uno degli elementi principali della nuova ricerca su Paolo tutta tesa - sia pure con prospettive diverse - alla riscoperta della sua ebraicità. Talora la critica è presentata con toni così accesi e radicali da sembrar impedire ogni dialogo, al punto da configurasi - nelle parole di Eric Noffke - quasi come una missione di damnatio memoriae (o di cancel culture, come oggi si usa dire) volta a cancellare tutto quanto si è detto e sostenuto nella ricerca storica e teologica su Paolo negli ultimi 500 anni, dalla Riforma in poi. Sembra che non ci sia spazio se non per una decisa presa di posizione a favore o contro: o Lutero (e Agostino prima di lui) avevano totalmente ragione nella loro comprensione di Paolo o si erano totalmente sbagliati.
In effetti, se per Paolo luterano si intende il Paolo nemico e distruttore dell'ebraismo e della legge mosaica, promotore di una religione di grazia agli antipodi del legalismo giudaico, allora la ricerca contemporanea rappresenta un radicale cambio di rotta e un punto di non ritorno rispetto alla tradizione esegetica luterana, predominante in ambito storico e teologico fino agli anni Ottanta del Novecento. [1] Rivendicando l'ebraicità di Paolo la ricerca contemporanea ha completamente rigettato l'immagine tradizionale del Paolo convertito, ricollocando la sua figura come ebreo del I secolo e partecipe del dibattito tra le varie componenti giudaiche del Secondo Tempio e quindi anche al centro dell'odierno dialogo ebraico-cristiano.<> Segal, Byarin, Pesce </ref> Non potrebbe essere altrimenti: al tempo di Paolo il cristianesimo non esisteva ancora come religione separata dall'ebraismo ma come movimento messianico ed apocalittico all'interno del giudaismo. Paolo - come lui stesso rivendica con forza nei suoi scritti - non fu un apostata: nacque, visse e morì ebreo. La rivelazione di cui Paolo fece esperienza sulla via di Damasco cambio' certo radicalmente la sua percezione del giudaismo e la sua collocazione all'interno di esso ma in nessun modo dovrebbe essere definita come una "conversione" e un abbandono della religione di Israele. In questo senso, si', il Paolo ebreo è in un'opposizione irreconcilable con il Paolo luterano.
Se si guarda invece ai principi fondamentali che usualmente sono associati al Paolo luterano (sola gratia, sola fides, solus Christus), la situazione si presenta molto più complessa e sfumata. In alcun casi si potrà addirittura concludere che alcuni dei principi luterani ne escano finanche rafforzati, pur all'interno di una nuova prospettiva.
Sola gratia
Tra i principi luterani questo e' quello che esce più solidamente confermato dalla critica contemporanea. Anzi la grazia emerge sempre più nell'opera di storici e teologi contemporanea come il centro stesso della teologia paolina.
Ciò che la ricerca contemporanea sul Paolo ebreo ha contestato a Lutero non è che la salvezza è per sola gratia ma che cio' debba essere affermato come caratteristica distintiva del cristianesimo in contrapposizione al giudaismo come religione "legalistica" fondata delle opere. Questo e' cio' che la New Perspective di Stendahl and Sanders ha con forza affermato, sulla scia di critiche gia' espresse da studiosi come Claude Montefiore o George F. Moore. Lutero aveva del giudaismo una percezione profondamente errata che gli impediva di vedere nel giudaismo stesso una religione fondata sulla grazia e quindi la radice e l'ispirazione stessa della visione paolina. Al principio di ogni opera buona vi è sempre il dono di Dio che si e' manifestato a tutti gli uomini attraverso l'atto creativo e al popolo ebraico in particolare attraverso l'alleanza sinaitica. La legge naturale e la Torah mosaica sono la risposta degli uomini e delle donne a questi doni. La nuova alleanza in Cristo annunciata da Paolo segue lo stesso schema: è un dono di grazia che esige la risposta umana. La struttura del pensiero paolino (del nuovo patto in Cristo) è e rimane ebraica nella sua sostanza, come indicato con forza da E.P. Sanders.
A chi era allora rivolta la polemica paolina? Già Montefiore e Sandmel avevano indicato che la polemica di Paolo non fosse contro il giudaismo ma contro una sua versione deformata e ellenizzante e che in fondo Paolo rivelasse solo una conoscenza molto superficiale del giudaismo dei rabbini. E' quanto sembra essere suggerito anche da Sanders che indicava in 4 Ezra la prova dell'esistenza di una possibile deriva legalistica del giudaismo, che si sarebbe contrapposta in modo assolutamente inconciliabile a quello che egli definiva la forma condivisa del giudaismo (common Judaism) basata su principio del "nomismo dell'alleanza', fondato sulla grazia. La polemica paolina tuttavia sembra avere caratteri generali e non essere limitata solo a contestare una ristretta frangia di radicali che avrebbero reinterpretato l'alleanza sinaitica in termini legalistici.
Una seconda ipotesi che e' quella recentemente richiamata da Eric Noffke. Paolo sarebbe l'espressione di un giudaismo apocalittico antinomista. E' vero che l'enochismo ci offre l'esempio di una tradizione giudaica dove la legge non ha la centralità che ha in altre forme di giudaismo, ma non abbiamo nessuna evidenza che gli enochici non seguissero le norme della legge mosaica (a cominciare dalla circoncisione). L'indifferenza nei confronti della legge mosaica non nasce in loro da un rigetto di essa, quanto piuttosto dalla convinzione che essa non rappresenti un rimedio al problema che per loro era centrale, vale a dire il dominio del male nel mondo.
L'episogio della conversion di Izate e' talora citato impropriamente come un testo che tratta della salaezza di Isate, mente al centro del testo e' la discussione della modalita' della sua conversione. Il tema non e' cio' che egli debba fare per essere slavo ma cio' che egli debba fare per unrsi al giudaismo.
Per un ebreo del Secondo Tempio esistono due distinte vie di salvezza che sono entrambe doni della grazia di DIo: il dono dell'ordine creativo che esige l'obbedienza alla legge naturale e il dono dell'aleeanza per Israele che comporta l'obbedienza della legge mosaica. Nel giudizio finale tutti gli uomini e le donne saranno giudaicati ma secondo leggi diverse, perche' essi sono stati inclusi dalla grazia divina nella salvezza secondo doni diversi: quindi i gentili saranno giudicati secondo a legge naturale, mentre gli ebrei lo saranno secondo la legge mosaica.
Izate, re di Adiabene, e' un gentle, quindi sara' salvo se vive con giustizia secondo natura, esistono infatti giusti tra le nazioni. Potranno esser pochi ma ci sono. Izate pero' vuole unirsi in modo piu' completo al giudaismo. Per il primo "missionario" che incontra, Anania (un giudeo ellenista?) e' sufficiente che egli diventi un timorato di Dio. "Il re, aggiunse, poteva venerare Dio senza essere circonciso, se veramente intendeva aderire al giudaismo, poiché era questo che contava molto, più della circoncisione". Non dunque per essere salvi, ma per "aderire al giudaismo" come religione del cosmo non importa circoncidersi e seguire gli obblighi della legge mosaica, e' sufficiente seguirne il significato perche il fine della legge e' lo stesso, vivere secondo natura. E cosi' Izate fa, rinunciando all'idolatria e seguendo gli obblighi dei timorati di Dio, diventandoa tutti gli effetti membro di qulla religione universale che per Filone e' il giudaismo, di cui gli ebrei sono per nascita i sacerdoti, mentre i gentili ne sono membri "laici".
Per il secondo "missionario" invece, "che aveva fama di essere estremamente severo sulle patrie leggi, Eleazaro (un fariseo?) questo potra' forse anche eseere sufficiente alla salvezza del gentile Izate ma non e' sufficiente alla sua conversione, in quanto non lo rende membro della religione d'Israele. Occorre la circoncisione e con essa viene l'obbligo di seguire tutti i comandamenti della legge mosaica.
L'episodio non testimonia dunque dell'esistenza di un giudaismo antinomista. Il punto e' che per gli ebrei ellenisti il giudaismo e' la religione del cosmo e quindi al gentile non occorre diventare "ebreo" (proselita) per unirsi ad essa ma basti farlo da timorato di Dio. Per altri invece, il giudaismo e' la religione del popolo ebraico e l'unico modo di unirsi ad esso per un gentile e' di diventare ebreo facendosi "proselita". Nessuno dei due gruppi ipotizza un giudaismo antinomista, nessuno mette in discussione il fatto che quanti per nascita siano ebrei non dovrebbero essere circoncisi, anzi ribadiscono che chi e' circonciso (per nascita o per scelta di farsi "proselita") e' tenuto ad obbedire alla legge mosaica. Lo stesso Paolo si pone su questa linea ("Chiunque si fa circoncidere ... e' obbligato ad osservare tutta quanta la legge", Gal 5,3).
Anche Paolo si colloca nella prospettiva anti proselitistica del giudaismo ellenistico ma in maniera ancora piu' radicale, affermando che nella lettera ai Galati che i gentili battezzati (incirconcisi) non dbbeano essere spinti a fasi Proseliti, ma in virtu del loro battesimo sono innestati nell'olivo di Israele come parte integrante del popolo di Dio, al pari dei membri circoncisi. Paolo afferma che questa sua posizione fu condivisa anche "dalla persone piu' ragguardevoli" della comunità cristiana di Gerusalemme, come provato dal fatto che "neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere" (Gal 2,3).
Come afferma mark Nanos: il problema non è se i credenti in Cristo di origine ebraica possano continuare a circoncidere i loro figli, ma piuttosto se dei pagani convertiti debbano assumere nella carne il marchio dell’appartenenza ad Israele
In Paolo e' presente una polemica accesa verso altri gruppi e movimenti giudaica del suo tempo ma tale polemica in alcun modo vuole condurre ad una prospettiva antinomista. L'affermazione che la salvezza e' per grazia non implica nel giudaismo (e in Paolo) un rigetto delle opere.
«Non si pensi di fondare la santità sulle opere, la santità va fondata sull'essere, giacché non sono le opere che ci santificano, siamo noi che dobbiamo santificare le opere. Per sante che siano le opere, esse non ci santificano assolutamente in quanto opere, ma, nella misura in cui siamo santi e possediamo l'essere».
Meister Eckhart
Due conseguenze iportnat nella definizione diel principio d sola gratia. Recupero dell'azione delle opere come risposta alla grazia ricevuta.
non ha nulla a che vedere con quella «grazia a buon mercato» con- tro cui si scagliava Dietrich Bonhoeffer21. come dice John Barclay, [2] il ricevimento di questo dono si deve esprimere necessariamente in gratitudine, obbedienza e cambiamento di vita. Questa grazia è gra- tuita (senza precondizioni) ma non a buon mercato (senza aspettative o obblighi). coloro che l’hanno ricevuta devono rimanere in essa, le loro vite trasformate da nuovi abitudini, nuove disposizioni e nuove pratiche di grazia. Il dono in sostanza non puo' rimanere senza contraccambio.
La posizione di Barclay in fondo non e' che un recupero dell'autentica posizione agostiniana e luterana (forse "dimenticate" nella tradizione esegetica che a loro si rcihiamache non intendeva affatto sminuie il valore delle opere di giustiazia e di carita' verso il prossimo ma solo ricordare cnhe esse bvengono come risposta alla grazia ricevuta.
The good works come forth in response to the grace of God enacted in a Christian life. It is through these works that the proper Christian response to justification can be seen--in true love for one's neighbor, this action not being motivated by self-gain but through the example of Christ. It is this expression of the outward nature, the 'outer man," which must be mastered and directed in daily intercourse with the rest of human society. This is done through the joyful acceptance by the inner nature of the grace of Christ in which 'it is his [the Christian's] one occupation to serve God joyfully and without thought of gain, in love that is not constrained' (p. 17).
A Treatise on Good Works by Dr. Martin Luther, 1520
9 Lutero. Libertà del cristiano 1520
XXIII sezione:
“Buone, pie opere non fanno mai un uomo buono e pio; ma un buono, pio uomo fa buone, pie opere” (p. 54) “Come ora gli alberi devono essere prima dei frutti e i frutti non fanno gli alberi né buoni né cattivi, ma gli alberi fanno i frutti; così l’uomo dev’essere già pio o malvagio nella sua persona prima di fare buone o cattive opere; e le sue opere non lo rendono buono o malvagio, ma lui fa buone o cattive le opera” (p. 54)
Sola fides
E' questo il principio piu' fortemente criticato della teologia luterana, se lo si intende nel senso che ad essere salvati saranno solo coloro che hanno esplicita fede in Cristo (accettando la sua signoria e ricevendo il battesimo). Dai cristiani Paolo viene comunemente esaltato come il campione dell'universalismo cristiano, come colui che avrebbe allargato i confini della salvezza al di fuori degli "angusti" confini del popolo ebraico. Il tutto in contrapposizione assoluto con il Paolo pre-cristiano , cosi' intollerante nella sua difesa del particolarismo giudaico da perseguitare come eretici i seguaci di Gesu'. Il concetto di "giustificazione per fede" rigidamnte inteso pero' ci pone di fronte al paradosso di un Paolo che in seguito al suo incontro con il Cristo diventa ancora piu' intollerante, affermando che la salvezza una volta prerogativa di color che obbediscono la lla legge e' ora drammaticamnte e di colpo ristretta ai soli battezzati (allora - infinitamente piu' dche oggi - un numero limitissimo di persone, ebree e gentili)
Ora non vi dubbio che Paolo abbia annunciato la giustificazione per fede come via di salvezza anzi come via primaria di salvezza, ma rimane per me incomprensibile come teologi cristiani possano ripetere che "la giustificazione per fede e' per Paolo l'unica ed esclusiva via di salvezza", senza alcun distinguo e senza provare almeno un senso di brivido per le implicazioni di intolleranza che tale idea ha prodotto e ancor oggi produce.
L'esigenza di superare il paradosso di un Paolo universalista e al tempo stesso campione dell'intolleranza religiosa ha portato a vari tentativi di ridefinire il concetto di giustificazione per fede. Ci sono tuttavia dei punti fermi nelle lettere paoline dai quali e' difficile prescinder ed e' ad essi che in primo luogo occorre fare riferimento.
(1) La giustifizione per fede e' un dono di grazia di Dio "in virtu' della redenzione realizzata dal Cristo Gesu (rom 3:
Gal Gesu' Cristo ... ha dato se stesso per i nostri peccai, per stapparci da questo mondo perverso, secondo la volonta' di Dio e Padre nostro" (Gal 1:4) Egli "e/' stat[ messo a morte per i nostri peccati ed e; stato resuscitato per la nostra giustificazione" (Rom 4:25)
"But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. (1Cor 6:11)
(2) La giustificazione avviene solo per fede, indipendentemente dalla legge.
"L'uomo non e' giustificato dalle opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesu' Cristo (Gal 2:15) ... Se la giustificazione viene dalla legge, Cristo e' morto invano" (Gal 2:21).
"Che nessuno possa giustificarsi davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto vivra' in virtu' della fede" (Gal 3:11) "Ora a legge non si basa sulla fede, al contrario dice che chi partichera' queste cose, vivra' per esse" (Gal 3:12) Ne consegue che chi obbedisce e' salvo ma chi trasgredisce e' sotto la maledizione. Invece Cristo riscatta il peccatore dalla maledizione (gal 3:13
"L'uomo e; giustificato per fede indipendentemente dalle opere della legge" (Rom 3:28)
<<La legge da' solo la conoscenza del peccato "La legge provoca l'ira" (Rom 4) - "La legge giunse a dare piena coscienza della caduta" (Rom 5:20)
(3) La giustificazione e' offerto sia a ebrei che a gentili ed e' stata promessa dalla Scritture. Lesempio di Abramo" ebbe fede e questo gli fu accreditato come giustizia.
"Am me era stato affidato l vagelo per i non circoncisi come a Pietro quello per i circoncisi" (Gal 2:7)
In Cristo Gesu' non e' la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carita' (Gal 5:6)
"Questa beatitudine riguarda chi e' circonciso o anche chi non e' circonciso?
"se ebrei come Pietro e Paolo cercavano la giustificazione in cristo, allora anche loro dovevano averne bisogno» (Westerholm, 15)
Ministero dei
Paolo afferma che la giusticazione per fede e' annunciata', "promessa dalle scritture"
La giustificazione e' promessa dalla legge ad Abramo e il dono della legge nn annulla la promessa (Gal 3). A questo riguardo la legge fu come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo (Gal 3
==
DI solito queto viene presentato in alternativa o sostituzione della legge, che avrebbe carattere solo temporaneo
Vi sono tuttavia degli elementi contraddittori:
Paolo
Ma per Paolo non e' cosi'
"La legge dunque e' contro le promesse di Dio? Impossibile! (Gal 3:21)
"Tgliamo dunque ogni valore alla legge mediante la Fede? Niente affatto, anz cofermiamo la legge" (Rom 3:31)
CHe diremo dunque, che la legge e' peccato? No certamente" (Rom 7:7)
E curiosamente ogni volta ch parla del giudizio finale lo fa in termini
Paolo ripete l’indiscus- sa convinzione del Secondo tempio che nel giorno del giudizio, Dio «renderà a ciascuno secondo le sue opere» (Rom. 2,6 et passim). Mai Paolo mette in dubbio che la salvezza attende quegli ebrei e gentili i quali compiano “opere buone” (seguendo rispettivamente la torah e la loro coscienza). i peccatori saranno puniti e i giusti saranno salvati senza alcuna parzialità. «tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male, sul giudeo, prima, come sul greco; gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo, prima, come per il greco. Dio infatti non fa preferenza di persona» (Rom. 2,9-11). È la stessa idea che Paolo aveva ribadito anche in ii corinzi e che avrebbe ripetuto di nuovo alla fine della lettera ai Romani: «tutti in- fatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male» (ii cor. 5,10). «tutti infatti ci presenteremo 10 G. Boccaccini, The Pre-Existence of the Torah. A Commonplace in Second Temple Judaism, or a Later Rabbinic Development?, “Henoch” 17 (1995), pp. 329-350. 11 G. Boccaccini, Hellenistic Judaism. Myth or Reality?, in a. norich, y.z. eliaV (a cura di), Jewish Literatures and Cultures. Context and Intertext, Brown Ju- daic Studies, Providence 2008, pp. 55-76. 153 al tribunale di Dio [...] ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio» (Rom. 14,10-12). in nessun passo nelle sue lettere Paolo attesta una comprensione del giudizio finale diversa da questa.
Giusficazione per fede o salvezza per fede?
Dunque, riassumendo: La giustificazione per fede e' via di salvezza, e' conseguenza del sacrificio del Cristo, avviene solo per sola fides, indipendentemente dalla legge ed e' un dono offerto sia a ebrei che a gentili secondo la promessa delle Scritture. AL tempo stesso Paolo ci dice la promessa non toglie valore alla legge e il giudizio rimane fondato sulle opere.
Come e' possibile tenere insieme questi elementi apparentemente contradditori?
Non per fede in Cristo ma per la fedelta' del Cristo
Alcuni hanno negato che per Paolo la fede in Cristo rappresenti un elemento centrale, che la giustificazione/salvezza non sia per fede in Cristo ma in virtu' della fedelta' del Cristo. Il problema e' che la sostituzione
Non fede in Cristo ma per la defeldta' del Cristo.
G. HEBERT, "Faithfulness and Faith", Theology 58 (1955) 373-379.
L’articolo di Hebert fu severamente criticato da James Barr nel suo celebre libro sulla "Semantica del linguaggio biblico" Articolo di Alber Vanoye] Il valore di un termine non e' dato dell'etimologia ma dal contesto.
Tale interpretazione e' stata ripresa da altri dcome Gager
Il problema è -- come afferma anche Noffke - che non regge alla prova dei testi biblici, in quanto in alcuni passi paralleli e più espliciti, come Gal. 2,16, la traduzione fedeltà di Gesù semplicemente non funziona.
<<"Sapendo che l’uomo non è giustificato in virtù di opere di Legge, ma per mezzo della fedeltà di Cristo, anche noi abbiamo creduto in Cristo, per essere giustificati in virtù della fedeltà di Cristo e non in virtù di opere di Legge (Gal 2:16)>>
E questo va contro a tutta la prim atradizione cristiane come espressa anche nei sinottici che vede nella fede in Cristo, la condizione imprensidibile pe rl'ottenimento del perdono dei peccati.
Piu' che all'etomologia bisogna guardae al consteso e questo contesto e' dato dal giudaismo del I secolo e dagli coevi scritti del movimento gesuano, in paricolare i sinottici, evitandi isolare artificiosamente Paolo dal suo contesto giudaico e cristiano.
==
Una prospettiva di gran lunga piu' produttiva e' quella offerta dalla rivisitazione del concetto di "giustificazione" nel contesto del giudaismo del I secolo e in particolare del nodo cruciale rappresentato dal rapporto tra giustificazione e salvezza. Siamo proprio sicuri che "giustificazione per fede" equivale a "salvezza per fede"?
Un libro fondamentale di Chris VanLandingham pubblicato nel 2006, "Judgment & Justification in Early Judaism and the apostle Paul" ha affrontato il problema nel contesto del giudaismo del I secolo raggiungendo una conclusioni importante: i due concetti di giustificazione e salvezza sono strettamente connessi ma non perfettamente sovrapponibili.
Già Sanders (con Karl Donfried) aveva notato che, nelle parole di Paolo, la giustificazione è coniugata al passato, mentre la salvezza lo è al futuro: le persone «sono state giustificate» per fede, ma «saranno salvate» (o dannate) in un giudizio in cui «Dio [...] renderà a ciascuno secondo le opere» (Rom. 2,6) (Rom. 5,9-10; 13,11; i tess. 5,8; i cor. 1,18)18. Dal punto di vista dei membri battezzati del movimento di gesù, la giustificazione per fede appartiene al passato, mentre la salvezza nel giudizio finale di ciascuno appartiene al futuro. Ma Sanders intendeva questo linguaggio come evidenza di un processo universale attraverso il quale tutti gli esseri umani (ebrei e gentili al- lo stesso modo) vengono salvati per grazia (poiché inclusi nel nuovo patto in cristo) e la loro salvezza sarà confermata nel giudizio fina- le dalle buone opere attraverso le quali hanno dimostrato la loro vo- lontà di «rimanere» nel patto: «l’idea fondamentale di Paolo sembra essere così che i cristiani sono stati purificati e stabiliti nella fede, e debbono rimanere tali, per essere trovati irreprensibili nel giorno del Signore [...] Paolo è consapevole che non tutti rimangono saldamen- te nella condizione di purificazione»19.
il problema con questa interpretazione, come osservato da chris Vanlandingham, è che identifica la giustificazione per fede «al ver- detto di assoluzione che un credente riceverà nel giudizio finale». al contrario, la giustificazione per fede «descrive ciò che accade all’i- nizio della propria esistenza cristiana, non alla fine [...] Descrive la persona perdonata dei suoi peccati e liberata dal dominio del pecca- to»20.
<<ovviamente, per i peccatori, la giustificazione mediante la fede è una via per la salvezza; secondo Paolo, «il vangelo [...] è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo, prima, come del greco» (Rom. 1,16). la giustificazione per fede, tuttavia, non è la salvezza per fede. ciò che Paolo ha in mente non è il destino di tutta l’umanità, ma il destino dei peccatori. Per Paolo, come per tutti i primi seguaci di gesù, ciò che è già stato ricevuto tramite il battesi- mo è il perdono dei peccati passati per i peccatori che si sono pentiti e hanno accettato l’autorità del Figlio dell’uomo.>>
Quando Paolo parla di giustificazione per fede, parla dunque di qualcosa di diverso dal giudizio finale secondo le opere di ciascuno. la giu- stificazione per fede è un dono incondizionato di perdono offerto ai peccatori pentiti che hanno fede in gesù. la salvezza è il risultato del giudizio finale in cui tutti gli esseri umani saranno giudicati in base alle proprie opere. chris Vanlandingham era stato del tutto corretto nelle conclusioni del suo studio sul giudizio e la giustificazione nel giudaismo del Secondo tempio e nell’apostolo Paolo:
- una persona che è stata «giustificata» è una persona che è stata per- donata dei peccati passati (che quindi non costituiscono più un pro- blema), purificata dalla colpa e dall’impurità del peccato, liberata dalla propensione umana al peccato e quindi dotata della capacità di obbedire. il giudizio finale determinerà quindi se tale persona, come atto di volontà, ha seguito questi benefici ottenuti attraverso la mor- te di cristo. Se è così, la vita eterna sarà la ricompensa; altrimenti, la dannazione24. (VamLandigham, 335)
Con giustificazione Paolo intende prima di tutto il perdono dei peccati.
In effetti se al termine giustificazione per fede si sostituisca quello di "perdono per fede" i testi paolini mantengono inalterata tutta la loro coerenza, anzi Paolo puo' affermare che il perdono per fede rappresenta una nuova via di salvezza nel momento in cui al tempo stesso riafferma che il giudizio finale avverrà attraverso un giudizio delle opere.
EPaolo si ritrova collocato all;interno del pensiero del primo cristianesimo
Non solo ma scompare il paradosso che del "rivoluzionario" concetto paolino di "salvezza per fede" non esista alcuna traccia fino alla sua "riscoperta" operata da Agostino (su cui Lutero fonda la sua interpretazione). Della salvezza per fede non c'e' traccia nei sinottici e nemmeno nella tradizione paolina. Scompare anche il paradosso della "censura" che gia' gli Atti avrebbero operato del pensiero paolino.
In Matthew il riferimento al sangue di Cristo: This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.
gli Atti sono il linea con questo
"Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit." (Atti 2:38)
"Tutt i profet All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. (Atti 10:43)
Anche le Deauteropaoline sono sulla stessa line, ponendo al centro il perdono di DIo
"In Gesu' abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissone dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia" (Efesini 1:7) "Con lui Dio ... a perdonato tutti i peccati, annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli" (Col 2:13-14). "Il Signore vi ha perdonato" (COl 3:13)
1 John 1:9: " If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
In sintesi, la teologia cristiana ha arbitrariamente equiparato giustificazione e salvezza, separando Paolo non solo dal sua contesto giudaico, ma anche dal contesto del primo cristianesimo per cui giustificare equivale non a salvezza maagli effetti del perdono di Dio.
Il testo di 2i coinzi 3 non puo' essere preso come provad el fatto che il giustificato sara comunque salvato. Paolo non parla dalla condizione generale dei battezzati ma del lavoro dei ministri che "costruiscono" la comunita' sulle fondamenta del Cristo, la bonta' del cui lavoro sara messa al vaglio del fuoco del giudizio. Questo coumnque non riguarda la giustizia personale anche se "l'opera finira' bruciata". Paolo continua il suo discorso, affermando che cio' che si richiede agli amministratori e' di rimaner fedeli" (4,2). E qui afferma anche rispetto a stesso che "benche' non sia consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificati. Il mio giudice e' il Signore! Non ogliate percio' giudicare nulla prima del tempa, finche' venga il Signore. Egli mettera' in luce i segreto delle tenebre e manifstera' le intenzion dei cuori; allora ciascuno avra' la sua lode da DIo" (1 Cor 4,4-5). DI nuovo reimerge la consapevolezza che la salvezza definitiva e' un fatto futuro e che il giudizio definitivo non debbe essere pronuncaito "prima del tempo".
"Sapendo che l’uomo non è perdonato (giustificato) in virtù di opere di Legge, ma per mezzo della fedeltà di Cristo, anche noi abbiamo creduto in Cristo, per essere perdonati (giustificati) in virtù della fede in Cristo e non in virtù di opere di Legge
La dimensione apocalitica del pensiero paolino
Il testo di VanLandingham e' a mio giudizio un testo fondamentale. Egli correttamente coglie che la giustificazione non e' solo "perdono, purificazione e purificazione dei peccati passati" ma anche un’emancipazione dal dominio del peccato sull’umanità»31 (VanLindingham, 245) ottenuti mediante la fede in cristo. Cio' L'autore non coglie in tutta la sua ampiezza e' la dimensione apocalittica del pensiero paolino , la sua enfasi sul potere del peccato,
Cosi' si dira' nella lettera agli Efesini: "La nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti." (Efesini 6,12)
Il problema dunque per Paolo non e' la legge, o il "legalismo" giudaico: il problema e' "il peccato [che] prendendo occasione dal comandament mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. La legge e' santa e santo e giusto e buono e il comandamento" (Rom 7). Non e' la legge ad essere respnsabile ma il peccato: "esso per rivelarsi peccato mi ha dato la morte servendosi di cio che e" bene" (Rom 7:13)
Se c'e' una guerra in Paolo contro la legge essa non e' indirizzata contro la legge mosaica ma contro quella legge dettata dal male: C'e' in me un;altra legge che spinge l'uomo al male.
Questo e' il linea con la profezia di Enoc
E' quanto dice nelle sue lettere ed e' come lo interpreta gli atti degli apostoli, e come i sinottici presentano il valore della fede.
In questo modo e' possibile riaffermare - come diceva Lutero - che la giustificazione (il perdono) e' per sola fede per sola esplicita fede in Cristo, anche se la fede puo' non essere esclusivisamnte determinante
Gesu' non ci ha liberati dalla legge mosaica, ma da questa altra legge, "dalla legge del peccato e della morete" (8:
cosa che era impossibile per la legge mosaica, perche' la carne la rendeva impotente"
Gesu' e' moto per i peaccatori, per molti non per tutti. (Rom 5:6-11)
"Cristo mori' per gli empi nel tempo stabilito.
Solus Christus
Alcuni esponenti della "Paul-within-Judaism Perspective", come John Gager o Mark Nanos hanno suggerito che le lettere di Paolo sono rivolte ai gentili (non agli ebrei) e che dunque solo a loro Cristo e' presentato come via di salvezza. Mentre il dono della torah e' riservato agli ebrei circoncisi, l'annuncio della giustificazone e il dono della nuova alleanza e' rivolto esclusivamente ai non-circoncisi. Per loro esclusivamente la salvezza e' in Cristo.
<Altri hanno cercato di limitare l'annuncio della giustificazone fede, come esclusivo annunzcio dal salvezaa per i gentili (e non per gli ebrei)>>
E' questo il fondamento dell'idea delle "due vie di salvezza" la quale gode di una certa favore in ambito ebraico cristiano per la sua capacita' di disinnescare alla radice l;idea della "missione" cristiana verso Israele. Ma spostare l'intolleranza paolina dagli ebrei ai gentili non e' poi un grande passo in avanti. Gli ebrei hanno la Torah, ma cosa ne e' dei gentili che non credono in Cristo?
L'idea di due autonome vie di salvezza e' stata molto criticata. ANzitutto dal punto di vista dell'esegesi dei testi paolini in quanto affermarla richiede tortuose esegesi dei testi e l'assunto che Paolo faccia un un'uso della retorica ai limiti dello spregiudicato per dire in realta' il contrario di quello che dice. Vi e' poi l'aspetto teologico in quanto priva il messaggio cristiano del suo centro esclusivo.
Occorre riprendere al problema alla radice. Per un ebreo del Secondo tempio -- abbiamo visto -- esistono "due" vie di salvezza: la legge naturale per i gentili e la legge mosaica per gli ebrei. Ad esse (dal punto di vista prettamente storico) Paolo ne "aggiunge" ora una terza: la "giustificazione per fede". La logica di Paolo e' la stessa per la quale al dono della legge naturale Dio ha aggiunto il dono dell'alleanza sinaitica, ovvero a causa delle trasgressioni <cit>. Paolo infatti e' un ebreo apocalittico e al centro del suo pensiero e' una coscienza fortissima del potere del male, assieme ad una coscienza fortissima della misericordia e della grazia di Dio che lo spinge a vedere Dio impegnato alla ricerca di un rimedio per lo stato di peccato nel quale si trova l'umania' sotto il dominio di Satana che e' il dio di ques mondo"
<<La buona creazione, dono di salvezza di Dio a tutta l'umanita', e' stata corrotta dal peccato per cui la maggioranza delle persone sono cadute preda delle loro passioni (rom>>
Per questo, per limitare il diffondersi del male e per allargare i confini della salvezza si e' reso necessario un ulteriore dono, quello del Patto mosaico, riservato al popolo di Israele con il suggello della circoncisione. Ma l'azione della Toah e' limitata dal suo offrire un argine non un rimedio definitivo al problema del male. Rispetto alla legge naturale, la legge mosaica offre alla liberta' dell'uomo un richiamo esplicito e quindi una conoscenza esplicita di cio' che e' bene e di cio' che e' male. La Torah tuttavia non ha il potere di porre l'uomo al riparo dal potere del male ma solo di rivelarne l'esistenza, ponendosi come benedizione per chi la segua ma anche come maledizione per chi la trasgredisca. Per contrastare il dominio del male e' neessaio un dono ancora piu' grande (independentemente dalla Legge), che per Paolo e' gia' profeticamente annunciato ad Abramo nella stessa Torah. E' questo dono che Paolo annuncia essersi realizzato con il sacrifico e la morte del Cristo, ovvero la giustificazione per fede.
Cristo e' il secondo Adamo la cui axione viene a cntrobilanciare in modo definitivo il potere del male.
Il dono del Cristo e i doni precedenti
Il problema e' come il dono della "giustificazione per fede" si rapporta ai doni precedenti. E' indubbio che per Paolo Cristo ha una centralita' assoluta e un ruolo definitivo. La "giustificazione per fede" e' la via maestra, tanto che egli considera il suo miniterso piu' grande di quello di Mose' che annunciava la condanna (dei trasgressori), mentre Paolo annuncia la salvezza (anche per i trasgressori).
Ma il dono della grazia annulla i precedenti doni di Dio? Si aggiunge ad essi o si sostituisce ad essi? Cosa ne e' della legge naturale e della legge mosaica dopo la venuta del Cristo?
A questo proprosito va sempre tenuto presente che - come nel caso del dono della Legge mosaica - il fine del dono della giustificazione per fede e' sempre quello di allargare i confini della salvezza non di restringerli, Atraverso la giustificazione per fede la misericordia di DIo offre ora una possibilita' di salvezza anche per i paeccatori, cosa che ne; la legge naturale ne; la legge mosaica era stato intese di fare. Paolo non e' un messaggero di sventura ma un messaggero di misericordia. Al centro del suo messaggio e' l'annuncio dell'amore di DIo che si estende atutti gli uoimini ed include anche i nemici, color che i quali il Cristoha versato il suo sangue).
Che ne e' della legge naturale e della legge mosaica ora che si e' manifestato il dono della giustificazione per fede"? e qui notiamo subito la diversa misura con cui la teologia cristiana a guardato
La teologia cristiana ha avuto una sguardo benevolente nei riguardi della legge naturale e di coloro che "senza colpa" sono ignari del Cristo e ricercano il bene:
Già San Tommaso diceva: “Dal fatto che tutti gli uomini sono tenuti a credere esplicitamente alcune verità per salvarsi, non c’è inconveniente alcuno che qualcuno viva nelle selve o tra gli animali bruti. Poiché appartiene alla Divina Provvidenza provvedere a ciascuno le cose necessarie per la salvezza, a meno che uno non lo impedisca da parte sua. Perciò, se uno educato secondo la ragione naturale si comporta in maniera da praticare il bene e fuggire il male, si deve tenere per cosa certissima (certissime tenendum est) che Dio gli rivelerà per interna ispirazione le cose che deve credere necessariamente o gli invierà qualche predicatore della fede come fece con San Pietro e Cornelio (At 10,1 55)” (De Veritate, 14, 11, ad 1)
Dante La chiesa cattolica Il cncilio Vati Cristo in fonso e' colui per il quel
Sulla stessa linea si e' espresso il Concilio Vaticano II: “Quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa ma che tuttavia cercano sinceramente Dio e con l’aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di lui, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna” (LG 16).
<<. E ancora: “E ciò vale anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale” (GS 22).>>
Cosi' - in modo non esclusivo - ribadisce anche il compendio del Catechismo della chiesa cattolica (2005) risponde alla domanda sul significato dell'espressione: «Fuori della Chiesa non c'è salvezza». "Essa significa che ogni salvezza viene da Cristo-Capo per mezzo della Chiesa, che è il suo Corpo. Pertanto non possono essere salvati quanti, conoscendo la Chiesa come fondata da Cristo e necessaria alla salvezza, non vi entrassero e non vi perseverassero. Nello stesso tempo, grazie a Cristo e alla sua Chiesa, possono conseguire la salvezza eterna quanti, senza loro colpa, ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e, sotto l'influsso della grazia, si sforzano di compiere la sua volontà conosciuta attraverso il dettame della coscienza." (Catechismo della Chiesa Cattolica - Compendio, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2005, n.171.)
Tale sguardo benevolente nei confronti della legge naturale invece e' sempre stato negato agli ebrei e alla legge mosaica. Il fatto è conseguenza diretta delle polemiche che hanno accompagnato l'emergere del cristianesimo come religione autonoma e separata dall'ebraismo e quindi da secoli di difficile convivenza tra le due religioni sorelle. Ai gentili non cristiani veniva lasciato la presunzione di innocenza la cui "ignoranza" si perdonava (e si perdona) attribuendola a buona fede . Gli <<ebrei invece erano colpevoli perche' pur "sapendo" rifiutano coscientemente e ostinatamente la grazia divina. Quindi al contrarioLa ragione ' che lgi il ifiuto degli "ebrei" e' unteso come il iuto di coloro che pur conoscendo la verit's, rimamono d essi ostinatamente contrari.>
Tale ostilita' si e' spinta al punto da considerare la pratica stessa della legge un fatto malvagio, rigorosamente proibito ai cristiani. Se negli Atti degli Apostoli si puo' tranquillamente affermare che tra i battezzati ci sono migliaia di circoncisi, i quali seguono fedelmente i precetti dlla legge mosaica, gia' per Giustino alla meta' del secondo secolo d.C. questo e' un qualcosa da guardare con un certo sospetto e circospezione e da molti apertamtne contestato: non e' proibito ma a condizione che rimanga un fatto privato.
Da fine della legge Cristo e' ormai diventato "la fine" della legge.
Eppure Paolo non parla dell'allenza con Israele e della Legge mosaica al passato ma al presente. Le alleane di Dio sono irrevocabili>La legge e' buona e santa.
Paolo dunque immagina uno scenario in cui il Cristo e' l'unica via di salvezza ma la legge non e' abrogata.
Per Paolo la legge naturale, la legge mosaica e la giustificazione per fede non sono vie tra loro esclusive, perché I doni non si annullano ma si integrano nel piano di Dio. Non vi tratta pero’ neppure di vie autonome e separate perché tutto è da Paolo ricondotto al Cristo, principio e fine di ogni cosa.
Dal punto di vista di Paolo, la salvezza e’ sempre e comunque “in Cristo.”, il quale per Paolo Cristo e’ colui “nel quale e per il quale tutte le cose sono state create e
Come tale il Cristo è il fondamento della legge naturale, è la sapienza rivelata agli uomini al momento della creazione.
Cristo è anche il fine della legge mosaica, che di lui è profezia e buon pedagogo cui Dio ha affidato con fiducia i figli del suo popolo Israele.
Quindi nella prospettiva paolina la salvezza “in Cristo” include non solo i “giustificati per fede” ma anche coloro che tra le nazioni sono giusti secondo la legge naturale e coloro che tra gli Israeliti sono giusti secondo la legge mosaica. Anch’essi ricevono salvezza in Cristo pur non conoscendolo o non essendone consapevoli. Cristo e’ preesistente, e’ colui attraverso il quale tutto e’ stato e alla fine dei tempi sara’ il Giudice di fronte al quale tutti, ebrei e gentili, saranno giudicati ciascuno secondo le proprie opere. Quindi il gentile che osserva la legge naturale senza saperlo osserva la legge del Cristo, che e’ il fondamento dell’ordine creative. E l’ebreo che osserva la torah, osserva la legge che fu data ai figli come buon pedagogo perche’ annunciasse loro la venuta del Cristo e ricevera’ per questo salvezza dal Cristo. Solo ai peccatori la fede esplicita in Cristo e’ richiesta coscientemente come condizione per ricevere il battesimo e la giustificazione 9il perdono dei peccati), ma la salvezza per tutti avviene in Cristo anche per i gentili che siano giusti second la legge naturale e per gli ebrei che siano giusti seconod la Legge mosaica. In fondo la posizione di Paolo non e’ lontana da quella espressa dal Vangelo di Matteo ai giusti nel giudizio finale. Ad essi non e’ chiesta quale sia la loro fede ma e’ detto: “tutte le volte che avete fatto al piu’ piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me
Per Paolo dunque è sempre il Cristo (non la fede in lui) il mediatore della salvezza, le tre vie di salvezza sono tutte da lui riconnesse e integrate a di fuori di ogni prospettiva abrogativa o sostitutiva. L’ulivo santo di Israele nasce dal terreno dell’umanità e i giustificati per fede vi sono innestati, e alla fine tutto Israele sarà salvato. Perché le promesse di Dio sono irrevocabili.
Il giudaismo rabbinico opererà la stessa integrazione tra le proprie due (originariamente autonome) vie di salvezza, sviluppando il concetto di preesistenza della Torah, per cui l’ordine creativo (la legge naturale) è anch’esso inglobato nella Torah come legge noachica.
Una volta compresa come preesistente, la Torah viene a includere sia l’alleanza noachica con l’intero genere umano (la legge naturale), sia l’alleanza sinaitica con il popolo d’Israele (le legge mosaica), in virtu' delle quali nel giudizio finale riceveranno salvezza sia i giusti di Israele sia i giusti tra le nazioni. Nell’ottica della teologia rabbinica è possibile dunque ora affermare che la Torah è l’unica ed inclusiva via di salvezza. Anche i gentili che compiono opere di giustizia dunque seguono, senza esserne coscienti, la Torah.
Dire che la salvezza è incentrata sulla Torah (sola Torah) esprime l'irrinunciabile prospettiva della fede ebraica e non è affatto un'affermazione intollerante; lo diventerebbe se ci affermasse che la salvezza è riservata ai soli circoncisi (a quanti cioe' coscientemente vi aderiscono per nascita o per scelta). Analogamente dire che la salvezza e' "in Cristo" (solus Christus) esprime l'irrinunciabile prospettiva della fede cristiana: «In nessun altro [fuorché in Gesù Cristo] è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi possiamo essere salvati» (Atti 4,12). Anche in questo caso non si tratta di un'affermazione intollerante: lo diventa pero' quando si afferma che "la giustificazione per fede e' l'unica esclusiva via di salvezza" (e che quindi a salvezza e' limitata ai soli battezzati o comunque all'esplicito riconoscimento della signoria del Cristo).
Si tratta in fondo di recuperare quanto i primi padri della Chiesa come Clemente Alessandrino affermavano riguardo all'inclusivita' della salvezza in Cristo: "Una è si, la strada della verità, ma in essa, come in un fiume perenne, sfociano tanti rivoli, uno da una parte uno dall’altra. E allora ecco le divine parole: “Ascolta, mio figliolo, e accogli il mio discorso, perché tu abbia molte vie di vita: io ti insegno vie di sapienza, perché non ti vengano meno le sorgenti”, le quali scaturiscono dalla medesima terra. E certo non per un uomo giusto soltanto ha enumerato più vie di salvezza, anzi soggiunge che molte altre vie ci sono per molti giusti, proclamando: “Le vie dei giusti brillano come luce”. Ebbene, anche i precetti e le propedeutiche possono essere vie e indirizzi di vita." (Clemente Alessandrino, Stromati I 5, 28, 1-29)
E' quanto oggi apertamente ribadito da teologi cristiani come Paolo Ricca: "Non possiamo pensare che ci possa essere salvezza all’infuori di Gesù. Questo però non significa che la via cristiana a Gesù sia l’unica che porta a lui. L’unicità e l’universalità della salvezza in Gesù non significa che, prima o poi, tutti debbano diventare cristiani per essere salvati, cioè che non si possa essere salvati se non si diventa cristiani. Gesù Cristo e il cristianesimo non possono essere separati, ma ancora meno identificati." [3]
Sono affermazione che certo si discostino dalla tradizionale interpretazione di Paolo - ma non in virtu' di un rigetto delle posizioni paoline quanto al contrario in virtu' di un ritorno al Paolo ebreo e di una piu' attenta comprensione storica dei suoi scritti. Una volta ricollocata nel suo originario contesto del primo secolo, Paolo non ci appare piu' come il fondamento dell'antigiudaismo e dell'intolleranza cristiana, ne' il nemico della Torah, ma l'araldo della misericordia di Dio che va oltre la legge naturale e le legge mosaica. La prospettiva da lui offerta e' certo diversa da quella affermatasi nel giudaismo rabbinico ma come essa analogamente inclusiva. E' una prospettiva in cui i doni di Dio (la legge naturale e la legge mosaica) non sono abrogati ma integrati “in Cristo”. Perché mai del resto un dono più grande dovrebbe annullare i doni precedenti? La giustificazione per fede (che significa perdono dei peccati passati, liberazione dal potere del male e dono dello Spirito) è per Paolo la via maestra per i peccatori ma non è l’unica ed esclusiva via di salvezza. Per Paolo il Cristo è l’unica ed inclusiva via di salvezza.
Poalo apocalittico
una grazia piu' grande che non solo giustifichi l'uomo peccatore ma lo renda capare di rispondere al dono ricevuto con frutti di giustizia.
Grace vs. evil, not grace vs. law
A collective act of grace (the end of time) vs. an individual act of grace for the sinners.
@2015 Gabriele Boccaccini <work in progress>
Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo Una rilettura della Lettera ai Romani all'interno del giudaismo del Secondo Tempio. Gabriele Boccaccini, Università del Michigan
(1) Introduzione: Un nuovo paradigma nello studio di Paul
Nel contesto del giudaismo del primo secolo la figura di Paolo appare tra le più enigmatiche e una di quelle di più difficile collocazione. Un alone di mistero, se non la maledizione di un antico tabù, sembra ancora aleggiargli attorno e rendere difficile una comprensione serena della sua esperienza. Su Paolo pesa la reputazione ingombrante di primo grande teologo sistematico cristiano ma anche il sospetto – se non l’accusa – di avere contribuito in modo decisivo alla separazione tra cristianesimo ed ebraismo e di avere gettate le basi di una velenosa polemica contro la Torah e il popolo di Israele, foriera di pregiudizi e discriminazioni, fino alla tragedia dell’Olocausto.
La riscoperta dell’ebraicità di Gesù, che dalla fine dell'Ottocento vede impegnati in uno sforzo comune studiosi ebrei e cristiani, ha a lungo contribuito a scavare ulteriormente il solco. Più la figura del Maestro si rivelava compatibile con lo spirito del giudaismo del suo tempo, più il suo discepolo più famoso appariva l’uomo della rottura, quando non addirittura l’autentico fondatore del cristianesimo come religione distinta dall’ebraismo
Per secoli, del resto, i cristiani hanno lodato, e gli ebrei hanno accusato, Paolo di aver separato il cristianesimo dal giudaismo. Ai cristiani Paolo è apparso come il convertito capace di smascherare e denunciare la "debolezza" (se non la malvagità) del giudaismo, e agli ebrei come il traditore che ha trasformato la fede dei suoi antenati in una caricatura (Zetterholm 2009). Paolo e' divenuto così al tempo stesso l'avvocato dell'universalismo cristiano e il principale sostenitore della esclusività cristiana: tutti, ebrei e gentili, uomini e donne, liberi e schiavi, sono chiamati e accolti alla fede, ma per tutti c'è unica via di salvezza, in Cristo, creando cosi' un muro di intolleranza tra credenti e non-credenti. Condannato dalla propria "perfidia", dalla propria colpevole assenza di fede, il popolo ebreo, una volta "eletto", si trova ora privato di ogni dignita', rigettato al pari dei gentili alla dannazione se non attraverso l'esperienza individuale della conversione.
Eppure in questo quadro ci sono molti conti che non tornano. Tra gli autori del primo cristianesimo Paolo è quello che con maggior forza rivendica la propria ebraicità («Anch’io sono Israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino» – Rom 11,1) difende l'irrevocabilita' delle promesse divine ("Dio ha rigettato il suo popolo? Niente affatto!", Rom 11:1) e con più prontezza ribadisce i “privilegi” di Israele di fronte allo zelo dei nuovi convertiti tra i gentili («Tu, oleastro [...] non menar vanto contro i rami!» – Rom 11,17-18).
Con Krister Stendhal, E.P. Sanders, James D.G. Dunn e la “New Perspective” si è cominciato fin dagli anni ’70 a mettere in discussione quella opposizione radicale tra grazia e legge che faceva di Paolo il critico implacabile del “legalismo” ebraico, riconoscendo in tale opposizione non la voce autentica del primo secolo, ma il riflesso anacronistico della polemica che nel sedicesimo secolo divise il cristianesimo con la Riforma7. Con il crollo del “Paolo luterano” è caduto anche il mito della supposta inossidabile coerenza teologica del pensiero paolino. Si e' cosi' cominciato a insistere piuttosto sulla paradossalità della teologia paolina, sulla sua non-sistematicità, sul suo essere legata a problemi e situazioni contingenti, e quindi sulla sua sostanziale incoerenza. Paolo non era un teologo o un pensatore sistematico. Paolo era un pastore, che aveva a che fare con comunità di persone in carne e ossa e con problemi estremamente concreti. In Paolo – come affermato con efficace sinteticità da E. P. Sanders – la soluzione precede il problema. Egli vedeva i gentili avvicinarsi con fede ed entusiasmo al cristianesimo; il suo sforzo teologico fu nel cercare di giustificare a posteriori il fatto avvenuto. La riflessione paolina non sarebbe allora la premessa teoretica all’ingresso dei gentili nella comunità cristiana, ma il tentativo, finanche un po’ confuso e teologicamente non del tutto coerente, di giustificare l’evento nel quale si riconosceva l’azione misericordiosa di Dio.
La nuova prospettiva ha cercato difficile sbarazzarsi degli aspetti più sprezzanti della lettura tradizionale (luterana) di Paul (sostenendo che l'ebraismo anche deve essere considerato come una religione "rispettabile" in quanto anch'esso basato sulla grazia) Ha efficacemente riscoperto la struttura giudaica del pensiero di Paolo, sottolineandone gli aspetti pragmatici e pastorali rispetto alla sua presunta inossidabilita' teologica. E tuttavia non ha messo in discussione la visione di Paul come il critico del giudaismo e l'avvocato di un nuovo modello sostituivo di relazioni tra Dio e l'umanità che sostituisce l'antica alleanza: la grazia di Dio "in Cristo" supera l'alleanza ebraica sia per gli ebrei e gentili, con la creazione di un terzo "popolo".
<Prima di concludere che Paolo fu incoerente occorre tuttavia domandarsi se tale oggi egli ci pare semplicemente perche;' non riusciamo a capire il contesto e la coerenza originaria del suo pensiero >
Sulla scia di queste considerazioni gli autori della New Radical Perspective on Paul" si sono spinti ben oltre, sono giunti a ribaltare clamorosamente il quadro tradizionale, affermando l’immagine di un Paolo fedele alla Legge e cosciente promotore di una “doppia strada” alla salvezza in cui la fede in Gesù è offerta come via di salvezza ai non-ebrei, senza annullare (anzi ribadendo) la funzione salvifica della Torah per gli ebrei. Nell’affermare il primato della grazia nelle sue lettere Paolo si sarebbe sempre e solo rivolto ai pagani indicando a loro esclusivamente il Cristo come via di salvezza. La “conversione” di Paolo non sarebbe altro che una chiamata a predicare ai gentili, che lascia inalterato, anzi rafforza il patto di alleanza tra Dio e Israele. L’entusiasmo revisionista è arrivato al punto di affermare trionfalmente – come già si era fatto con Gesù – che contrariamente a quanto finora da tutti ritenuto «Paolo non era cristiano»9.
La soluzione è teologicamente attraente e si salda armoniosamente agli sforzi del dialogo ebraico-cristiano contemporaneo. Non a caso molti dei propugnatori della Radical New Perspective sono teologi militanti, piuttosto che specialisti del giudaismo del Secondo Tempio. Ma si tratta di una ipotesi storicamente plausibile o di una anacronistica rilettura post-Olocausto del maestro di Tarso?
<< Un nuovo paradigma sta oggi emergendo con la Radical New Perspective - un paradigma che mira a riscoprire pienamente l'ebraicità di Paolo. Paradossalmente, "Paul non era un cristiano" (Eisenbaum 2009) da quando il cristianesimo al tempo di Paolo è stato altro che un movimento messianico ebreo, e quindi Paul dovrebbe essere considerato altro che un Secondo Tempio Ebreo. Che altro avrebbe dovuto essere? Paul è nato ebreo, di genitori ebrei, venne circonciso e nulla nei suoi supporti di lavoro (o addirittura suggerisce) l'idea che è diventato (o si considerava) un apostata (Boccaccini 1991). Al contrario, Paolo è stato il membro del movimento di Gesù e con forza e chiarezza inequivocabile orgogliosamente rivendicato la sua ebraicità e ha dichiarato che anche Dio non ha respinto l'alleanza di Dio con il popolo eletto: "Dio ha rigettato il suo popolo? Niente affatto! Io stesso sono Israelita, un discendente di Abramo, un membro della tribù di Beniamino (Romani 11: 1; cfr Fil 3: 5). >>
E' facile di fronte in questo modo rimanere sconcertati da una prospettiva che sembra forzare la teologia paolina su binari ed interpretare come "retorico" o irrilevante tutto cio' che non rientra in questo schema. E così' può' tornar comodo tornare all'alveo di partenza, all'immagine tradizionale sia pure edulcorata dall'ammissione che si' Paolo era e si sentiva ebreo ma che una volta eliminati gli aspetti più' chiaramente caricaturali e dispregiativi "l'esegesi paolina di Lutero non e' stata cosi lontana dal Paolo autentico, come la recente ricerca ha voluto dimostrare" (Pulcinelli, p.321).
Di fronte alle Basta quindi provare le incongruenze della nuova prospettiva su Paolo per ritornare al Paolo della tradizione o c'e' una strada diversa per recuperare l'ebraicita' di Paolo all'interno della complessita' del giudaismo del Secondo Tempio. E' quanto ci proponiamo di esplorare in questo saggio.
Basta quindi provare le incongruenze della nuova prospettiva su Paolo per ritornare al Paolo della tradizione o c'e' una strada diversa per recuperare l'ebraicita' di Paolo all'interno della complessita' del giudaismo del Secondo Tempio. L'opposizione tra il Paolo cristiano e il Paolo ebreo e' dunque quella tra chi vede in Paolo un'unica via di salvezza in Cristo e coloro che propugnano due vie di salvezza, oppure c'e' una prospettiva diversa piu' storicamente plausibile nel quale collocare Paolo l'ebreo. E' quanto ci proponiamo di esplorare in questo saggio: non una interpretazione esaustiva della figura dell'apostolo, ma una riflessione sulla sua ebraicita' nel contesto giudaico del suo tempo.
(2) Il giudaismo al tempo di Paolo
Se oggi possiamo parlare del Paolo ebreo e' perche' la nostra comprensione dell’ebraismo del primo secolo è in questi ultimi decenni profondamente cambiata. I manoscritti del Mar Morto e i cosiddetti apocrifi e pseudepigrafi dell’Antico Testamento ci hanno restituito l’immagine di un’età creativa e dinamica e di un ambiente vitale e pluralistico, nel quale convivevano espressioni tra loro anche profondamente diverse dello stesso ebraismo, incluso il nascente movimento cristiano 10. Due elementi sono ormai acquisiti alla ricerca contemporanea e costituiscono il punto di partenza di ogni riflessione ulteriore:
(1) Il giudaismo del Secondo Tempio era diviso in correnti di pensiero in dialogo e competizione tra loro.
L'ovvia realtà' e' davanti agli occhi di tutti. Non c'e' ne' mai c'e' stato un unico momento nella storia dell'ebraismo o del cristianesimo in cui essi siano stati delle religioni monolitiche. Oggi parliamo di giudaismo ortodosso, conservativo e riformato e di cristianesemi ortodosso, cattolico e protestante ma anche prima che emergessero queste moderne divisioni esistevano altre divisioni e cosi' lungo tutto il corso della storia.
Nel secondo Tempio - come testimonia Giuseppe - esistevano tre t=distinte tendenze dottrinali: i sadducei, i farisei (con l'ala radicale e militante degli zeloti) e gli esseni. A queste correnti dovremmo aggiungere anche il giudaismo ellenistico (di cui Giuseppe Flavio non tratta concentrandosi sull'ambiente palestinese) e il movemento gesuano la cui distintivita' certo nessuno vorra' negare all'interno del giudaismo del Secondo Tempio in nome di un rigido monolitismo.
Certamente assieme alla visione monolitica dobbiamo evitare l'estremo opposto, come giustamente rileva Pitta di "considerare ogni variazione cristologica e comportamentale nelle prime comunita' cristiane come forma autonoma di giudaismo e di cristianesimo" (p.24P In media virtus dicevano gli antichi e cosi' e' vero anche in questo campo. Se non si puo' negare la diversita' non si puo' nemmeno arrivare arrivare all'assurdo che esista una forma diversa di giudaismo o di cristianesimo per ciascuno dei testi pervenutivi o dei leader conosciuti o di ogni piu' piccola sfumatura di pensiero. Esistono tuttavia delle grandi famiglie all'interno di ogni religione che portavano avanti visioni diverse delle stessa religione. L'ovvia realtà' e' davanti agli occhi di tutti. Non c'e' ne' c'e' mai statoun unico momento nella storia in cui l'ebraismo o il cristianesimo siano state delle religioni monolitiche. Oggi come ieri
Personalmente trovo un po' oziosa la discussione semantica sull'uso del singolare (varieta' di giudaismo e di cristianesimo) o del plurale (giudaismi o cristianesimi). Che se li chiami "giudaismi" o varietà' diverse di giudaismo" la sostanza non cambia. Al tempo d'oggi come al tempo di Gesu' non esisteva un solo modo di intendere il giudaismo ma modi diverse tra loro in dialogo o in competizione (o giudaismi). E quando il movimento di Gesu; emerse le stesse divisioni ben presto si rifletterono all'interno della nuova sette producendo diverse forme di cristianesimo (o cristianesimi)
Molti studiosi usano oggi comunemente il plurale, "giudaismi", a indicare la grande varietà di pensiero del giudaismo nel primo secolo e le varie movimenti religiosi nel quali l'ebraismo del tempo si divideva. E' questa un'idea oggi universalmente accettata nel mondo degli studi. Anche chi come Sacchi o Pitta conserva remore semantiche sull'uso del plurale applicato al termine "giudaismo", non nega la sostanza del problema, che cioè la religione ebraica del tempo fosse estremamente variegata. Che si parli quindi di "giudaismi" o di "correnti giudaiche" in discorso non cambia. In particolare, siamo oggi messi in guardia da ogni visione monolitica costruita sulle più tardive fonti rabbiniche11.
(2) Il movimento di gesu e' parte integrante del pluralismo giudaico del Second Tempio.
Una volta liberatici dai pregiudizi interpretativi e teologici del passato, ci troviamo di fronte ad alcune scoperte sorprendenti. Ad esempio, molte di quelle che eravamo abituati a considerare idee “tipicamente” paoline e anti-giudaiche (quali la giustifi cazione per fede, il peccato originale e la drammatica percezione dell’insufficienza dell’obbedienza alle norme della Torah ai fini della salvezza) si sono rivelate essere idee diffuse anche in altri ambienti e gruppi giudaici del tempo, spesso con alle spalle
S. Stowers, A Rereading of Romans, Yale University Press, New Haven, CT 1994; J.G. Gager, Reinventing Paul, Oxford University Press, Oxford 2000. 9 P. Eisenbaum, Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle, HarperOne, New York, NY 2009. 10 P. Sacchi (ed.), Gli apocrifi dell’Antico Testamento, 5 voll., UTET, Torino (poi Paideia, Brescia) 1981-2000; C. Martone, Testi di Qumran, Paideia, Brescia 1996. 11 G. Boccaccini, Roots of Rabbinic Judaism, Eerdmans, Grand Rapids 2002 (tr. it. I giudaismi del Secondo Tempio, Morcelliana, Brescia 2008). 6.Theme Section - Boccaccini.indd 105 08/05/2012 09:27:06 106 GABRIELE BOCCACCINI
una storia secolare. Ma anche di fronte alle idee "nuove" elaborate all'interno del nascente movimento cristiano sarebbe metodologicamente scorretto considerare come non-giudaica (o non più giudaica) ogni idea che non abbia un parallelo con altri autori o testi giudaici del tempo. Con questo criterio nessuno pensatore originale ebraico sarebbe più ebreo nel momento in cui elabora nuove idee rispetto alla tradizione ricevuta. Non lo sarebbe Filone, Giuseppe Flavio o Hillel. Lo stesso vale per Gesu o Paolo. Il fatto stesso che abbiano elaborato idee originali le rende certo distintive del nuovo movimento ma non per questo meno giudaiche. Va rigettato ogni tentativo di applicare una diversa misura nell'interpretazione delle origini cristiane rispetto alle altre forme di giudaismo contemporaneo.
Chiarite queste premesse metodologiche e' possibile un tentativo di lettura di Paolo non semplicemente in rapporto al giudaismo o nel suo contesto giudaico ma come parte integrante di esso. Se il cristianesimo non si fosse mai sviluppato come religione autonoma, questo sarebbe il modo in cui oggi leggeremmo Paolo, come un autore ebraico del Secondo Tempo, come il Maestro di giustizia o Filone, dei quali nessuno mette in discussione l'ebraicita' nonostante l'originalità delle loro posizioni. Una lettura teologica odierna di Paolo non può ovviamente prescindere dagli sviluppi posteriori, ma una lettura storica non anacronistica ci spinge a immaginare un tempo in cui il "cristiano" Paolo si collocava su un piano non diverso dall'esseno Maestro di Giustizia, dal fariseo "Hillel" o dal giudeo ellenista Filone. Forse e' giunto il momento che la figura di Paolo sia ricollocata nel suo ambito originario storico di appartenenza
Ci sono segnali evidenti che spingono oggi in questa direzione, Per la prima volta the "Eerdmans Dictionary of Early Judaism" a dura di John J Collins e harlow contiene un articolo su Paolo (a firma di Daniel Harrington) e 4 Enoch: The online Encyclopedia of Second Temple Judaism include gli Studi Paolini alla stessa stregua degli studi su Qumran o su Filone. Una tale inclusivita' sarebbe stata impensabile anche solo alcuni anni fa e si colloca in una linea generale di riappropriazione del nascente cristianesimo al giudaismo del primo secolo, di cui si vedono segnali evidenti a livello internazionale. Il presente studio non ha la pretesa di risolvere tutti i numerosi e complessi problemi della teologia paolina ma di offrire alcuni spunti di riflessione che vadano nella direzione di un contributo ad una lettura della figura di Paolo come uno dei protagonisti maggiori del giudaismo del Secondo Tempio, senza negare l'apporto da egli dato al nascente movimento cristiano. Non si tratta di Porre il Paolo ebreo in contrasto con il Paolo cristiano, ma di ribadire che all'interno della diversità giudaica del Second Tempio i due termini non sono il=n contraddizione ed e' possibile leggere Paolo (e Gesu') come pensatori ebrei ed esponenti di un movimento riformatore ebraico che solo in seguito (e con molto gradualita) si separata' dalle altre forme di giudaismo a formare una religione separata ed autonoma.
L'obiettivo del mio lavoro è quello di abbracciare pienamente il paradigma della Radical New Perspective non come la conclusione, ma come punto di partenza di una riflessione che legga il pensiero di Paolo all'interno del giudaismo del Secondo Tempio. A mio parere, il potenziale di un tale approccio ha appena cominciato a manifestarsi. Abbiamo ancora una lunga strada da percorrere prima di comprendere appieno tutte le sue implicazioni monumentali. Al fine di individuare correttamente Paolo Ebreo nel contesto del variegato mondo del giudaismo del Secondo Tempio, abbiamo bisogno prima di tutto di stabilire una migliore comunicazione tra gli studiosi del Nuovo Testamento e specialisti del Secondo Tempio, due campi di studi che fino ad oggi sono rimasti troppo lontano e
sordo a vicenda. Queste mie riflessioni non hanno certo la pretesa di offrire una spiegazione esaustiva del complesso pensiero paolino, ma di indicare piuttosto una scelta metodologica
(2) Tre Avvertenze circa l'ebraicità di Paolo
Alla luce di queste osservazioni possiamo ora riassumere Da questo documento si concentra sulla ebraicità di Paul, è importante chiarire, come premessa, ciò che la riscoperta dell'ebraicita' non dovremmo implica da tale, per evitare equivoci comuni.
(a) Al fine di recuperare l'ebraicità di Paolo non abbiamo a dimostrare che era un Ebreo come tutti gli altri, o che non era un pensatore originale. È importante non applicare a Paul uno standard differente rispetto a qualsiasi altro Ebreo del suo tempo. Affermare che trovare qualche idea in Paul che non ha eguali in altri autori ebrei rende Paolo "non-ebrei", porterebbe al paradosso che nessun pensatore originale del giudaismo del secondo tempio dovrebbe essere considerato "ebreo" - non certo Filone o Giuseppe o Hillel o il Maestro di Giustizia, i quali anche formulato "originali" risposte alle domande più comuni della loro età. Perché solo Paul essere considerato "non-ebrei" o "non-più-ebraica" semplicemente perché ha sviluppato una riflessione originale? La nozione stessa di fare una distinzione all'interno Paolo tra idee suo ebraico e "non-ebrei" (o "cristiani") non ha alcun senso. Paul era ebreo nelle sue idee "tradizionali" e rimase tale anche nella sua "originalità". Paolo era un pensatore ebreo e tutte le sue idee (anche il non-conformisti più) erano ebrei
(b) Al fine di recuperare l'ebraicità di Paolo che non dobbiamo sottovalutare il fatto che egli era una figura molto controversa, non solo all'interno giudaismo del Secondo Tempio, ma anche all'interno del movimento di Gesù. L'interpretazione classica che la natura controversa di Paolo (sia all'interno che all'esterno il suo movimento) invocato il suo tentativo di separare il cristianesimo dal giudaismo non tiene in considerazione la diversità del Secondo Tempio di pensiero ebraico. Non c'è mai stato un ebraismo monolitico contro un cristianesimo altrettanto monolitico. Ci sono state molte diverse varietà del giudaismo (tra cui il movimento di Gesù all'inizio, che a sua volta era anche molto diversa nelle sue componenti interni). La critica e' arma tipica di tutti i movimenti riformatori o d'opposizione; lo fanno i farisei, gli esseni. Lo fa anche Paolo.
(c) Al fine di recuperare l'ebraicità di Paolo non dobbiamo dimostrare che non aveva nulla da dire agli ebrei e che la sua missione era finalizzato solo l'inclusione di Gentili. Come Daniel Boyarin ci ha ricordato nel suo lavoro di Paul, un Ebreo è un Ebreo, e rimane un Ebreo, anche quando lui o lei esprime radicale autocritica verso la propria tradizione religiosa o contro altre forme competitive di ebraismo (Boyarin 1994 ). Limitare l'intero discorso teologico paolino alla sola questione dell'inclusione dei Gentili sarebbe ancora una volta limitare Paolo Ebreo ai margini del giudaismo e oscurare le tante implicazioni della sua teologia nel più ampio contesto del Secondo Tempio di pensiero ebraico.
(3) La "conversione" di Paolo nel contesto dei "giudaismi" del suo tempo
Non fu conversione dal giudaismo al cristianesimo
L'accento sulla diversità giudaica del primo secolo permette in primo luogo di rileggere con un'ottica diversa il problema della conversione di Paolo. E' oggi universalmente accettato dagli studiosi che Paolo mai intese la propria esperienza come un passaggio da una religione all'altra, dall'ebraismo al cristianesimo. E questo non fosse altro che per il semplice fatto che il cristianesimo non esisteva allora come religione distinta dall'ebraismo, essendo il movimento gesuano un movimento messianico all'interno del giudaismo stesso. In questo senso Paolo non intese mai "convertirsi", nel senso di abbandono della proprie religione per abbracciarne un'altra
La conversione come passaggio da una religione all'altra era un'esperienza ben conosciuta nell'antichità, sia nel giudaismo che nel mondo greco-romano. (Giuseppe ed Aseneth, Filone) e l'Asino d'Oro di Apuleio. In entrambi i casi il tema e'quello del completo abbandono del proprio popolo, della propria famiglia e della propria identita' per intraprendere un cammino di radicale "metamorfosi" che porta all'acquisizione di un nuovo popolo, di una famiglia e di una nuova identita'.
Filone di "trattare con rispetto" i proseliti, giacche' "essi hanno abbandonato il proprio paese, i loro amici e le loro relazioni" per acquisire virtu e santita' (Spec Leg I 51-53)
Non e' tuttavia a questi testi che dobbiamo guardare per comprender e l'esperienza di Paolo. Paolo continua a reclamare la propria ebraicita anche dopo la "conversione" e in lui sono del tutto assenti questi elementi di rottura con il proprio popolo, la propria religione e la propria famiglia di origine che abbiamo visto in Giuseppe e Asenath e Filone. Anche dopo la propria conversione Paolo riafferma la propria appartenenza (religiosa ed etnica) al popolo ebraico.
Come afferma Pesce: "Paolo non si e' mai convertito... non usa mai la parola greca metanoia o il verbo metanoein per definire il proprio cambiamento... Paolo non fu un apostata... Paolo vive e interpreta l'esperienza della rivelazione che cambia la sua vita come un fatto interno alla sua esperienza giudaica... La rivelazione [ricevuta] in nessun modo attenua il suo modo di essere giudeo e tanto meno lo abolisce e neppure lo pone in crisi... Paolo era e rimaneva soltanto ebreo" (Pesce, pp.13-32)
In cosa consiste dunque l'esperienza sulla via di Damasco?
< Con la sua “conversione” quindi Paolo mai intese di cambiar religione, semmai decise di mutare la propria appartenenza da un gruppo giudaico (quello dei farisei, al quale aveva aderito con zelo militante) a un altro gruppo giudaico (quello dei seguaci di Gesù, al quale ora aderisce con lo zelo militante del convertito sulla via di Damasco). Da tutto questo consegue che, come nel caso di Gesù, anche la domanda sull’ebraicità di Paolo debba essere posta oggi in termini nuovi. Il problema non è se e in che misura egli possa essere considerato ebreo, ma che tipo di ebreo egli fosse, giacché nel primo secolo vi erano molti modi diversi – e tutti ugualmente legittimi – di essere ebrei.>
Da fariseo a seguace di Gesu'
L'epistolario paolino e gli Atti degli Apostoli ci forniscono un quadro coerente del Paolo "pre-cristiano". Paolo e' un ebreo di Tarso Paolo era un Ebreo ", della tribù di Beniamino » (Rm 11,1; Fil 3,5) . Ha vissuto nella diaspora , come cittadino nativo e di Tarso , la capitale della provincia romana di Cilicia ( Atti 9:11 ; 21:39 , 22:03 ) . Negli Atti , Paolo vanta ripetutamente il suo status di cittadino romano , che gli ha concesso i privilegi e la tutela del diritto romano ( At 16 , 22 ) , e sostiene che ha ereditato la cittadinanza romana dal padre ( "Sono nato un cittadino " Atti 22:28 ) . Come al solito tra gli ebrei della Diaspora , Paolo era conosciuto con il suo nome ebraico " Saul" ( שָׁאוּל ) e il suo nome greco Paulos ( Παῦλος ; . Lat Paulus ) . Nato e cresciuto in una famiglia ebrea , fin da piccolo Paolo era probabilmente un membro della comunità ebraica locale e fu istruito nella lettura della Bibbia in greco ( ed ebraico ? ) . Era certamente fluente sia in ebraico / aramaico e greco . Sembra probabile dai suoi scritti , che ha anche ricevuto qualche tipo di educazione retorica greca , ma nessun riferimento specifico è fatto in fonti antiche .
Quanto alla sua collocazione specifica all'interno del variegato mondo del giudaismo del Secondo Tempio, anche in questo caso le fonti offrono una risposta unitaria. Paolo si definisce "un fariseo " (Fil 3,5) e così lo fa ripetutamente anche negli Atti , dove Paolo si auto=definisce "fariseo, figlio di farisei" e viene anche affermato che ha vissuto a Gerusalemme e fu allievo di Gamaliele . Filippesi ( 3,4-6 ) offre una sorta di riassunto della vita giovanile di Paul . Paolo si riferisce a se stesso come essere " circonciso l' ottavo giorno , un membro del popolo di Israele , della tribù di Beniamino , ebreo da Ebrei , come la legge, fariseo ; [6 ] per zelo , persecutore della chiesa , quanto alla giustizia sotto la legge , irreprensibile " .
Atti introduce bruscamente Paolo come un nemico della Chiesa , in netto contrasto con l'esempio del primo martire Stefano. Paolo " approvato " l'uccisione di Stefano e membri del movimento precoce Gesù molestata , serve "animato da zelo" i sommi sacerdoti Sadducean ( Anna e Caifa ? ) . Paolo in particolare, è descritto come un protagonista della persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme che ha portato gli ellenisti di essere " sparsi in tutta la campagna della Giudea e della Samaria . " Paolo è stato poi inviato a Damasco per studiare la sorte dei cristiani lì . Fu durante il suo viaggio a Damasco , che qualcosa è accaduto a cambiare radicalmente il suo atteggiamento verso il movimento di Gesù . In diversi casi a sue lettere Paolo si riferisce apertamente le sue azioni persecutorie contro i membri del movimento di Gesù prima della sua "conversione" . Paolo era un fariseo ( cfr. primi anni di vita di Paolo ) . La sua affermazione che la sua persecuzione è venuto "fuori zelo" , sembra indicare che Paolo il fariseo fu attratto dagli insegnamenti di zeloti e si unì ai sommi sacerdoti , cioè i sadducei , nella loro campagna contro i membri più radicali del movimento di Gesù . Va notato , tuttavia , che la persecuzione di Paul non hanno come bersaglio tutti i membri del movimento di Gesù , ma solo il partito cristiano - ellenistica guidata da Stefano, che secondo gli Atti 7, è stato accusato di promuovere opinioni radicali riguardo al tempio di Gerusalemme e l'osservanza di la Torah . Il " Ebrei " del movimento di Gesù sono stati esentati ; Atti 5:34-39 sostiene che Gamaliel giocato un ruolo decisivo nel proteggere gli apostoli dall'ira dei Sadducei dopo la morte di Gesù.
La ricostruzione degli Atti e' coerente. Gli apostoli vengono arrestati, ammoniti, minacciati, dalle autorità' sadducee ma i farisei si oppongono ad una totale repressione del dissenso.
La persecuzione colpirà gli apostoli e Giacomo il maggiore, il fratello di Giovanni, verra' messo a morte, solo nel periodo del regno hi Erode Agrippa I (41-44), quando il potere sadduceo potrà' ammantare la repressione religiosa con la ragion di stato.
La descrizione dell'esecuzione di Giacomo, il fratello di Gesu' e' conforme a questo schema. Il sommo sacerdote Anania approfitta della morte del procuratore romano e del breve periodo di interregno prima dell'arrivo del nuovo procuratore per agire di fatto come governatore della provincia. Ma l'esecuzione di Giacomo e' vista come un abuso di potere da parte della componente farisaica che richiedono l'immediata rimozione del sommo sacerdote--richiesta alla quale i Romani prontamente acconsentono sostituendo il potente sommo sacerdote.
La "persecuzione" giudaica contro il nascente movimento cristiano fu dunque essenzialmente una persecuzione sadducea, che soltanto nei confronti di alcune frange cristiane più' radicali può' aver attirato la collaborazione di attivisti "zeloti" farisei come Paolo. Nell'approvare la morte di Stefano e nel perseguitare gli ellenisti cristiani, il fariseo Paolo mostra uno "zelo" che le fonti non attribuiscono a Gamaliele, ma nel perseguitare gli ellenisti cristiani e nel risparmiare gli apostoli non agisce in totale contrasto con la posizione del suo maestro.
(3) La conversione di Paolo
Come nel caso di Gesù, il problema di Paolo non è se fosse un Ebreo o no, ma che tipo di Ebreo egli fosse, perché nel variegato mondo del giudaismo del secondo tempio c'erano molti modi diversi di essere un Ebreo (Boccaccini 1991 ). Secondo le sue stesse parole Paolo fu educato come un fariseo. L'idea che Paolo abbia abbandonato l'ebraismo quando "convertito" in movimento di Gesù è semplicemente anacronistico.
La conversione come esperienza di abbandono radicale di identità religiosa e etica di uno è stato effettivamente conosciuta nell'antichità (come attestato in Giuseppe e Aseneth, e nelle opere di Filone). Ma questa non e' stata l'esperienza di Paolo. Cristianesimo il suo tempo è stato un movimento messianico ebreo, non una religione separata. Paul, che è nato e cresciuto un Ebreo, è rimasta tale dopo la sua "conversione"; nulla è cambiato nella sua identità religiosa ed etnica. Che cosa è cambiato però era la sua visione dell'ebraismo. Nel descrivere la sua esperienza non come una "chiamata profetica", ma come una "rivelazione celeste," Paolo si indicava la radicalità della manifestazione. Paul non ha abbandonato l'ebraismo, ma "convertito" da una varietà del giudaismo a un altro.
Ancora Pesce: "Non si tratta di qualcosa che lo faccia uscire dal giudaismo, ma invece di qualcosa che lo orienta a prendere una strada precisa all;interno del giudaismo stesso" (Pesce, 25)
Con Alan Segal, Sono d'accordo che "Paolo era un farisaico Ebreo convertito al nuovo apocalittico, setta ebraica" (Segal 1990).
La radicalita' come segno della "conversione" paolina=
In nessun modo si dovrebbe minimizzare sottovalutare l'importanza della manifestazione e il suo impatto nella vita di Paolo. E 'stata una conversione che rimane all'interno del giudaismo ma che tuttavia ebbe l'effetto di riorientare completamente tutta la vita e la visione del mondo di Paolo. Non e' la religione ebraica cio' che dopo l'incontro con il Cristo appare a Paolo "perdita" e "spazzatura" (Fil 3:7-8), ma e' pur tuttavia una certa visione del giudaismo che appare a lui tale. Se un ebreo ortodosso diventa riformato, o se Woody Allen in un incubo onirico della sua fantasia si immagina trasformato in un rabbino ultra-ortodosso, anche noi descriviamo questa esperienza in termini di "conversione". Se la conversione di Paolo non deve in alcun modo essere intesa come un capitolo nella separazione tra cristianesimo ed ebraismo, essa rappresenta al contrario un evento rilevante nel contesto della diversità del giudaismo del secondo tempio.
Occorre tuttavia a mio giudizio rifuggire anche da posizioni che tendono a minimizzare la conversione di Paolo "riducendola" ai termini di una chiamata che avrebbe indirizzato Paolo ad un missione verso i Gentili ma non modificato nella sostanza dil suo modo di interndere il giudaismo. Paolo non e' fariseo cui e' stato rivelato l'identita' del Messia ed il cui unico scopo nella vita e' ora di annunciare la buona novella ai gentili.
Paolo era e rimase un ebreo prima e dopo la sua conversione. Non lo stesso può' dirsi della sua identita' farisaica. Lungi dall'essere la roccaforte del legalismo ed el conservatorismo, Il fariseismo e' stato uno dei principali movimneti di riforma adel Secondo L'accesa competizione tra Farisei e cristiani deriva proprio dal fatto dall'avere molti punti in comune edal condividere la stess urgenza riformatrice. Certo ci sono degli elementi farisaici nel pensiero di Paolo. Di questo Paolo sapra' ricordarsenea ll'occorrenza, come quando di fronte al Sinedrio affermera' di essere accusato di credere in qialcosa dalla prte dei farisei stategia opportunistica per dividere il campo dei suoi acusatori ed attirarsi la simpatia dei farisei ricordando i numerosi punti in comune tra il movimento gesuano e il farisaismo.
In questo contesto la conversione di Paolo non puo' essere ridotta a una chiamata. Ebbe effetti dirompenti sulla visione del mondo di Paolo
Con la sua “conversione” quindi Paolo mai intese di cambiar
religione, semmai decise di mutare la propria appartenenza da un gruppo
giudaico (quello dei farisei, al quale aveva aderito con zelo militante) a
un altro gruppo giudaico (quello dei seguaci di Gesù, che aveva perseguitato e al quale ora aderisce con lo zelo militante del convertito sulla via di Damasco).
Conclusione
Paolo era un fariseo (con tendenze zelote) che ha aderito al movimento di Gesù. Passeranno pero' molti anni prima che Paolo sia conosciuto come l'apostolo delle genti ed acquisisca un ruolo di leadership all'interno del movimento gesuano. Nella Lettera ai Galati Paolo afferma di essersi recato in Arabia e qauindi di essere tornato a Damasco. Dopo tre anni Paolo si reca una prima volta a Gerusalemme da cristiano "per visitare Pietro e stare con lui 15 giorni". Paolo ebbe anche modo di incontrare Giacomo, il fratello di Gesu', ma non vide nessun altro apostolo (Gal 1:
Passano altri 14 anni che Paolo dice di aver trascorso "nelle regioni di Siria e della Cilicia". Lo ritroviamo quindi con Tito a Gerusalemme tra coloro che accompagnano Barnaba, il leader riconosciuto della comunita' cristiana di Antiochia. A questo punto Paolo si presenta come parte di un gruppo che all'interno della primo cristianesimo si e' andato caratterizzando per una particolare attenzione per la missione verso i Gentili.
Prima di Paolo l'apostolo dei gentili, c'era Paolo "il seguace di Gesù" e il Paolo "membro della comunita' di Antiochia". Ogni discorso su Paolo non può quindi evitare la questione di ciò che il movimento di Gesù stava nel contesto del giudaismo del secondo tempio e del ruolo assunto dalla comunita' di Antiochia nella sua particolare apertura ai gentili
CAPITOLO II
Cap. 2. Paolo il seguace di Gesu'; il periodo formativo
Siamo tutti d'accordo che, al suo inizio, il cristianesimo è stato un movimento messianico ebreo, ma che cosa significa esattamente? Sarebbe semplicistico ridurre il messaggio primi "cristiani" ad un annuncio generiche sulla venuta imminente del regno di Dio, e di Gesù come il Messia atteso. E sarebbe riduttivo immaginare Paolo come un fariseo a cui una particolare attenzione per la missione per i pagani. è stato rivelato il nome del futuro Messia e che credeva di vivere alla fine dei tempi.
Come risultato della sua "conversione", Paul pienamente abbracciato la visione del mondo apocalittica cristiana e l'affermazione che Gesù il Messia era già venuto (e sarebbe tornato alla fine dei tempi). Questa comprendeva la spiegazione del perché il Messia era venuto prima della fine. I primi cristiani avevano una risposta; Gesù non è venuto semplicemente a rivelare il suo nome e l'identità. Gesù è venuto come il Figlio dell'uomo, che aveva "il potere sulla terra di rimettere i peccati" (Mc 2 e paralleli).
<> Un dibattito ebraico Secondo Tempio <>
L'idea del Messia come perdona sulla terra perfettamente senso come uno sviluppo dell'antica tradizione apocalittica enochico. Il "contro-narrazione" di 1 Enoch incentrata sul crollo dell'ordine creativa da una ribellione cosmica (il giuramento e le azioni degli angeli caduti) apocalittica: "Tutta la terra è stata corrotta dall'insegnamento di Azazel dei suoi [propri] azioni ; e scrivere su di lui tutto il peccato "(1 En 10:. 8). Era questa ribellione cosmica che ha prodotto la catastrofe del diluvio, ma anche la necessità di una nuova creazione.
La visione enochico dell'origine del male ha profonde implicazioni per lo sviluppo del Secondo Tempio di pensiero ebraico. L'idea della "fine dei tempi" è oggi tanto radicata nelle tradizioni ebraica e cristiana per rendere difficile persino immaginare un tempo in cui non era, e di comprendere appieno l'impatto rivoluzionario quando prima emerse. Nelle parole della Genesi, nulla è più perfetto del mondo perfetto, che Dio stesso ha visto e ha elogiato come "molto buona" (Gen 1,31). Nessuno avrebbe cambiato qualcosa che "funziona", a meno che qualcosa è andato terribilmente storto. Nel pensiero apocalittico, l'escatologia è sempre il prodotto di protologia.
Il problema di enochico dell'ebraismo con la Legge mosaica è stato anche il prodotto di protologia. Esso non è venuto da una critica diretta della legge, ma dal riconoscimento che la ribellione angelica aveva reso difficile per le persone a seguire le leggi (compresa la Toràh mosaica) in un universo ormai sconvolto dalla presenza del male sovrumana. Il problema non era la Torah in sé, ma l'incapacità degli esseri umani di fare buone azioni, che colpisce il rapporto umano con il Mosaico Torah. Lo spostamento della messa a fuoco non è stato in primo luogo da Mosè a Enoch, ma dalla fiducia nella responsabilità umana al dramma della colpevolezza umana. Mentre al centro del Mosaico Torah è stata la responsabilità umana di seguire le leggi di Dio, al centro di enochico ebraismo era ora un paradigma di vittimizzazione di tutta l'umanità.
Questo è il motivo non sarebbe corretto parlare di enochico giudaismo come una forma di ebraismo "contro" o "senza" la Torah. Enochico ebraismo non era "in competizione saggezza", ma più propriamente una "teologia della denuncia." Non c'era halakhah enochico alternativa a questo mondo, nessun codice purezza enochico, non enochico Torah; ogni speranza di redenzione è stata rinviata alla fine dei tempi. I Enochians non erano in competizione con Mosè, non facevano altro che lamentarsi. Nel Libro di enochico I sogni, il popolo eletto di Israele è promesso un futuro di riscatto nel mondo a venire, ma in questo mondo Israele è influenzato dalla diffusione del male, senza la protezione divina, come tutte le altre nazioni sono.
La vista enochico aveva risvolti inquietanti nel autocomprensione del popolo ebraico, come il popolo dell'alleanza. Ha generato un acceso dibattito all'interno del giudaismo circa l'origine e la natura del male (Rosen-Zvi 2011; Capelli 2012; marca 2013). Molti (come i farisei ei sadducei) respinto l'idea stessa di origine sovrumana del male; alcuni esplorato altre strade per salvare la libertà umana e l'onnipotenza di Dio percorsi che hanno portato a soluzioni alternative, dal malignum cor di 4 Esdra al yetzer hara rabbinico. Anche nei circoli apocalittici, c'erano teologie in competizione. Verso la metà del II secolo aC il Libro dei Giubilei ha reagito contro questa scomparsa del rapporto di alleanza con Dio attraverso la creazione di una sintesi efficace tra Enoch e Mosè, che molti studiosi vedono come la fondazione del movimento esseno. Pur mantenendo la struttura enochico di corruzione e di degrado, Giubilei reinterpretato il patto come "medicina" fornita da Dio di risparmiare al popolo eletto dal potere del male. La fusione di Mosaic e tradizioni enochico ridefinito uno spazio, in cui il popolo di Israele potrebbe ora vivo protetto dalla malvagità del mondo sotto le mura di un halakhah alternativo, finché sono rimasti fedeli alle regole imposte. L'alleanza è stata restaurata come pre-requisito per la salvezza. A questo proposito, come dice Collins, "Giubilei, che racconta le storie della Genesi da una prospettiva decisamente Mosaico, con interessi halachiche espliciti" stavano "in netto contrasto" alla tradizione enochico (Collins 2007). Ancora più radicale la Regola comunitario esplorare la predestinazione come un modo per neutralizzare la perdita di controllo del mondo creato da Dio e ripristinare l'onnipotenza di Dio (Boccaccini 1998).
Enochico ebraismo è rimasto fedele alle proprie sedi (ebrei e gentili sono ugualmente colpiti dal male), ma non era insensibile alle critiche di aver dato troppo potere al male e, quindi, riducendo drasticamente le possibilità umane di essere salvati. La tradizione enochico successivamente cercato di risolvere il problema seguendo un percorso diverso. Nelle parabole di Enoch si legge che alla fine dei tempi nel Giudizio, come previsto, Dio e il suo Cristo Figlio dell'uomo salverà i giusti e condannare gli ingiusti. I giusti sono "d'onore" (di merito, le buone opere) e sarà vittorioso in nome di Dio, mentre "i peccatori" non hanno onore (senza le buone opere) e non verranno salvati in nome di Dio. Ma inaspettatamente nel cap. 50 un terzo gruppo emerge al momento del Giudizio. Essi sono chiamati "gli altri"; sono peccatori che si pentono e abbandonano le opere delle loro mani. "Non avranno onore alla presenza del Signore degli Spiriti, ma attraverso il suo nome saranno salvati, e il Signore degli Spiriti avrà pietà di loro, perché grande è la sua misericordia" (Boccaccini 2013). In altre parole, il testo esplora il rapporto tra giustizia e misericordia di Dio e il ruolo svolto da questi due attributi di Dio nella sentenza. Secondo il Libro delle Parabole, i giusti sono salvati in base alla giustizia di Dio e la Misericordia, i peccatori sono condannati in base alla giustizia di Dio e la misericordia, ma coloro che si pentono saranno salvati per la misericordia di Dio, anche se non devono essere salvati in base alla giustizia di Dio. Il pentimento fa prevalere la misericordia di Dio sulla giustizia di Dio.
Il Gesu' storico
Il dibattito sul Gesu' storico e' oggi piu' acceso che mai. In alcuni circoli e per gran parte dell'opinione fa ancora scandalo l'idea che Gesu' nacque, visse e mori' da ebreo.
Gli studiosi oggi concordano sull'ebriacita' di Gesu', ma si dividono nell'indicare quale tipo di ebreo egli fosse. Da un lato ci si interroga su quanto il Gesu' storico abbia coscientemente partecipato al dibattito teologico giudaico del suo tempo o ne sia stato "marginale". Dall'altro, si discute se e in che misura il Gesu' dei Vangeli rifletta il pensiero del Gesu' storico o lo adatti o lo tradisca o addirittura lo reinventi totalmente, e in particolare se l'apocalitticita' del pensiero gesuano sia un tratto aggiuntivo o costitutivo del suo messaggio. Anche in Italia i migliori specialisti, da Mauro Pesce a Paolo Sacchi, per anni si sono confrontati su queste domande. Sono problemi aperti, forse irrisolvibili, che riserviamo ad altra occasione.
Per la nostra riflessione su Paolo e' importante notare come le antiche fonti cristiane post-pasquali concordino nel presentare la figura di Gesu' in chiave apocalittica.
L'idea cristiana della prima venuta del Messia come perdona è una variante radicale, ma molto logica del sistema enochico. Il concetto dell'esistenza di un tempo di pentimento immediatamente prima della sentenza e la profezia che a quel punto "i peccatori" si dividono tra "i pentiti" (gli altri) e "l'impenitente" è il necessario "premessa" delle missioni di Giovanni e Gesù, come narrato nei sinottici. La venuta imminente del Giudizio, quando la terra sarà purificata con il fuoco, rende urgente e il pentimento "il perdono dei peccati" per coloro che in questo mondo hanno "onore". "Essere battezzati con acqua; altrimenti, voi sarete battezzati con il fuoco del giudizio da parte del Figlio dell'Uomo "-questa sembra essere la sostanza del messaggio di Giovanni il Battista, come inteso dalla Sinottici, un'interpretazione che non contraddice l'interesse degli autori cristiani a presentarlo come una profezia del battesimo cristiano (dello Spirito Santo). Idee simili trovano un'eco anche nella vita di Adamo ed Eva, un testo generalmente datato al I secolo EV, dove il peccatore Adam fa penitenza per 40 giorni immersi nelle acque del Giordano (e non è un caso che Giovanni battezzò in acqua viva del Giordano). Il primo uomo (e la prima peccatore) è guidato da una speranza incrollabile: "Forse Dio avrà pietà di me" (Vita 4: 3). La sua richiesta di essere ammesso nel Giardino dell'Eden non saranno accettate, ma al momento della sua morte, la sua anima non sarà consegnato al diavolo, come il suo crimine meritava, ma eseguita a cielo; così Dio ha deciso nella sua misericordia, nonostante le lamentele di Satana. Nell'interpretazione cristiana, Giovanni Battista, il precursore, non poteva che annunciare l'urgenza di pentimento e di esprimere la speranza nella misericordia di Dio. Ma con Gesù era un'altra cosa; egli era il Figlio dell'uomo che aveva il potere sulla terra di rimettere i peccati, ha lasciato ai suoi discepoli il potere del perdono attraverso il battesimo "con lo Spirito Santo," e tornerà con gli angeli per eseguire la sentenza con il fuoco. Dopo tutto, chi può avere più potere di perdonare quello che Dio ha delegato il giudice escatologica? Come perdona, Gesù non è stato inviato "i giusti", ma per "i peccatori", in modo che potessero pentirsi. Non ci sono prove nei sinottici di una missione universale di Gesù ad ogni uomo, Gesù è stato inviato "alle pecore perdute della casa d'Israele" (Mt 10, 6); i giusti non hanno bisogno del medico. Gesù era il medico inviato per guarire i peccatori (Marco 2:17; Matteo 9:13), come Luke esplicita: "Io sono venuto a non chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi" (Lc 5,32). Leggendo i Sinottici alla luce del libro delle Parabole di Enoch fa luce anche su alcune parabole che la tradizione cristiana attribuiti a Gesù. La parabola della pecora smarrita (Mt 18: 10-14; Luca 15: 1-7) definisce il rapporto tra Dio e "gli altri"; Parabola di Luca del figlio prodigo (15: 11-32) ribadisce il tema, ma aggiunge anche un insegnamento sul rapporto tra "giusti" e "gli altri", tra chi ha l'onore e sono salvati perché non hanno mai abbandonato la casa del Padre e coloro che non hanno onore, eppure vengono salvati come pure dal momento che si sono pentiti e abbandonate le opere delle loro mani. Gli esempi potrebbero essere numerosi, ma non parabola sembra più illuminante per me quello narrato da Matthew sugli operai nella vigna (Mt 20: 1-16). Il padrone di casa che paga lo stesso stipendio per diverse "misure" di lavoro, dà la piena ricompensa (la salvezza) per il "giusto" e per gli "altri", proprio come ch. 50 delle Parabole sostenuto che Dio farà nel Giudizio. Misericordia di Dio ("non mi è permesso di fare quello che ho scelto con ciò che appartiene a me? O ti invidio la mia generosità?") Migliori prestazioni Giustizia di Dio, o come la Lettera di Giacomo direbbe, "trionfi Mercy sul giudizio (Gk. katakauchatai eleos kriseos) "(Giacomo 2:13).
Il contrasto con le tradizioni sviluppate nel movimento rabbinico non potrebbe essere più forte. I rabbini liberamente discutere la relazione tra i due middot, misure di Dio di giustizia e di misericordia, fornendo risposte flessibili al problema. Mishnah Sotah (1: 7-9) attacca al principio, "Con che cosa misurare un uomo metes deve essere misurato di nuovo a lui," e afferma che "con la stessa misura" Dio dà giustizia quando punire azioni malvagie e Mercy quando gratificante buona azione. D'altra parte, il testo parallelo Toseftà Sotah (3: 1-4: 19) sostiene che "la misura della Misericordia è cinquecento volte superiore alla misura della giustizia." Ma i due attributi divini sono mai opposti, come nel libro di parabole e nella tradizione cristiana; al contrario, la loro natura necessariamente complementare è sottolineata. Non a caso la versione "rabbinica" delle parabole si concluderà con parole diverse, in cui la Misericordia di Dio è lodato, ma la giustizia di Dio non è negato: "Questo ha fatto più lavoro in due ore rispetto al resto di voi ha a lavorare tutto il giorno" (Gerusalemme Talmud, Berakhot 2: 8).
CAPITOLO III
gli anni di apprendistato: Paolo "membro della comunita' di Antiochia
Al centro del messaggio del primo cristianesimo e' dunque l'annuncio del perdono di peccati, inteso come una seconda opportunita', offerta dal Messia (e futuro giudice) ai peccatori penitenti, di vedere azzerate le proprie colpe nell'imminenza del giudizio.
Paolo e' spesso presentato come colui che fu capace di portare a compimento tutte le potenzialita' universalistiche di questo messaggio fuori dalle secche del particolarismo ebraico.
"Christianity began with one tremendous problem. Clearly the message of Christianity was meant for all men… But the fact remained that Christianity was cradled in Judaism; and, humanly speaking, no message which was meant for all the world could even have had a more unfortunate cradle. The Jews were involved in a double hatred--the world hated them and they hated the world" (Barclay 1958, p.9).
Cosi' si esprimeva uno dei massimi teologi inglesi del tempo, che certamente si sarebbe offeso se qualcuno lo avesse accusato di antisemitismo per queste affermazioni che oggi suonano a dire poco sconcertanti, tanto piu' all'indomani dell'Olocausto. L'opposizione tra il particolarismo ebraico e l'universalismo cristiano e' del resto un luogo comune nella predicazione cristiana nei secoli.
<L'istituto per la creato da Hitler era del resto retto in Germania da un rispettabile teologo protestante che dopo la guerra prosegui' la sua rispettabile carriera. Le posizioni dell'Istituto erano del resto condivise da molti colleghi anche al di fuori della Germania nazista, anche di parte di persone che mai si sarebbero sognate di giustificare le persecuzioni antiebraiche e lo sterminio di Auschwitz >
Eppure una rilettura di Paolo all'interno della diversita' del giudaismo del Secondo Tempio e all'interno della diversita' della prima comunita' cristiana mostra l'astoricita' di queste posizioni.
(1) I gentili non erano esclusi nel giudaismo del Secondo Tempio
Anzitutto, non e' corretto affermare che nel giudaismo del Secondo Tempio i gentili fossero esclusi da ogni prospettiva di salvezza. Ci sono certo gruppi e tendenze fortemente che esprimono punti di vista di netta chiusura nei confronti dei gentili ecc. ecc.
C'e' chi indicava come unica possibilita' il proselitismo...
Ma ci sono anche posizioni di grande apertura.
In Filone troviamo entrambi gli elementi: l'apertura ai proseliti e l'inclusione dei gentili timorati di Dio.
Filone presente il giudaismo come la religione del cosmo, di cui gli ebrei sono (per nascita) i sacerdoti e i gentili sono i "laici". In questo quadro c'e' spazio non solo per i proseliti (per scelta) divengono ebrei) ma anche per i gentili "timorati di Dio" che riconoscono il Dio d'Israele come Dio unico e intendono vivere secondo la legge naturale.
Le presenza dei timorati di Dio nelle comunita' giudeo-ellenistiche e' testimoniata da testimonianze epigrafiche e dalla letteratura del Secondo Tempio, in particolare Giuseppe Flavio e Luca (vedi Paul Treblincon in Jewish communities in Asia Minor (Cambridge 1991).
= (2) Il movimento di Gesu' non mostra alle sue origini quello zelo universalistico
Il movimento di Gesu' inzialmente non si distingue in modo particolare per la sua apertura ai Gentili, anzi il vangelo di Matteo attribuisce a Gesu"
Sono venuto per le pecore perdute della casa diIsraele.
SDoppia limitazione: ebrei e peccatori. (gli esclusi sono i gentili e giusti) E infatti Gesu' -- come abbiamo visto -- non predica ai giusti ma ai [peccatori e predica agli ebrei non ai gentili. non che non ci fossero gentili in Galilei ma Gesu' se ne sta lontano. dalla citta' elle
Che questa non sia una "reinterpretazione restrittiva del messaggio gesuano" a uso e consumo della comunita' matteana e' confermatod dal fatto che gli Atti degli apostoli (scritti da un autore che certamente credeva nell'apertura ai gentili) presenta un quadro sostalziamente analogo
Cio' non esclude che non possa esistere giustizia al di fuore del popolo ebraico (anzi la In fondo non e[ strano che Dio alla fine voglia offrire ai prorpi figli con un dono speciale, che non e' riservato agli altri e del quale alcuni gentili possano ezzezionalmente
Matteo pone l'apertura ai gentili come un detto del Gesu' risorto...
Le stesse fonti cristiane confermano questo quadro con i numerosi riferimenti ai timorati di Dio. Aoofron un quadro piu' articolato. Secondo gli Atti degli Apostoli la prima comunita' cristiana era formata esclusivamente da ebrei (anzi esclusivamente da Galilei) e non aveva nella sua agenda post-resurrezione alcuna missione organizzata verso i gentili. L'apertura ai gentili fu accettata solo a conclusione di un travagliato processo. Secondo gli Atti degli Apostoli dapprima entrarono a far parte del movimento ebrei ellenisti, e si creo' cosi' una prima distinzione all'interno del movimento tra "cristiani ebrei" e "cristiani ellenisti". La separazione porto' anche all'emerger di una leadership autonoma (i sette diaconi, guidati da Stefano, tra i quali anche un proselita). La persecuzione che si scatena a geruslamme contro Stefano e il suo gruppo (lasciando indisturbati i Dodici e i "crisitiani ebrei") produce non solo il battesimo trai i "cuguni" separati samaritani, ma il primo gentile a ricevere il battesimo su un eunuco etiope. Protagonisti dell'evento non furono semplicemente un cristiano e un gentile, ma un tipo particolare di entrambi. il cristiano Artefice del battesimo non fu uno dei Dodicie e neppure uno della prima cerchia dei discspoli di Gesu; ma un compagno di Stefano, un certo Filippo l'evangelista, uno dei nuovi venuti alla fede e leader del gruppo dei "Cristiani Ellenisti". Il gentile non era un pagano ma un timorato di Dio (tanto che Filippo lo trova immerso nella lettura del profeta Isaia e non ha certo bisogno di istruirlo sui principi della fede monoteista di Israele. L'iniziativa poi del battesimo non parte da Filippo ma dal;'eunuco etiope che la esprime sotto forma di domanda: "Cosa impedisce a me di essere battezzato?".
Il seconda battesimo di un gentile descritto negli Atti e' quello del centurione Cornelio a Cesarea. Il gentile e' ancora una volta un timorato di Dio, ma questa volta il cristiano e' Pietro, leader dei Dodici e dei cristiani ebrei. A differenza di Filippo, Pietro mostra di avere molta minore dimestichezza con gentili e e' preoccupato all'idea di accettare il suo invito a recarsi a casa sua.
Il
La ricostruzione degli Atti va certo letta come una ricostruzione semplifica e idealizzata ma l'autore degli Atti non aveva certo nessun interesse a creare una storia che cosi' palesemente contraddiceva la presunta vocazione universalistica cristiana e che conferma il detto che il vangelo di Matteo attribuisce a Gesu"
Solo lentamente la comunita' si apre dunque ai gentili. Tutto merito di Paolo? Nient'affatto. Il processo si avvia prima di Paolo. Se il giudaismo ellenistico ha aperto la strada alla diffusione del primo cristianesimo tra i gentili e all'interno del primo cristianiseimo e' Barnaba il mentore di Paolo. < Gli Atti degli Apostoli precisano che fu Barnaba a chiamare Paolo come suo collaboratore.
5 Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia. 26 Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente; ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati Cristiani.
Barnaba volle anche Paolo con se in quello che erroneamente e' chiamato il primo viaggio missionario di Paolo e che invece fu un viaggio missionario organizzato e diretto da Barnaba con Paolo come suo collaboratore. L'incidente di Lystra, in cui la folla pagana scambia Barnaba e Paolo per degli dei, rivela come Barnaba-Zeus fosse al comando della missione ed enfatizza il ruolo esercitato da Paolo-Hermes come suo eloquente portavoce. >
<Paolo divenne membro del movimento di Gesù e poi caratterizzato il suo apostolato all'interno del movimento di Gesù ad avere una particolare attenzione per la missione per i pagani.>
Eppure Tutto questo avviene prima di Paolo e Barnaba come mentore di Paolo
Paolo quindi si inserisce in un processo di apertura ai gentili che si era avviato prima di lui.
Paolo segue Barnaba nel cosiddetto concilio di Gerusalemme e ne
La novita' paolina non va quiandi ricercata tanto nell'apertura ai gentili ma nelle modalita' in cui a suo avviso i gentili dovevano essere acccolti e nelle giustificazioni teologiche che Paolo pone a fondamneto del loro ingresso.
L'incidente di Antiochia
Non e' un caso che Paolo nella lettera ai Galati faccia coincidere il Concilio di Gerusalemme con la fine del suo periodo di "apprendistato" (i 14 anni trascorsi in Cilicia e Siria, compreso il viaggio missionario con Barnaba) che segue i tre anni di formazione culminati con la visita a Pietro.
Il ritorno ad Antiochia coincide infatti con l'inizio di un suo ministero autonomo. L'evento che segna il passaggio non e' il "Concilio di Gerusalemme" (in cui Paolo non ha una posizione autonoma ma di Sostegno a Barnaba) ma il cosiddetto incidente di Antiochia che proietta Paolo ad un ruolo di leadership distinto da Barnaba e Pietro che erano stati i suoi mentori.
L'apparente unanimità raggiunto il cosiddetto Consiglio di Gerusalemme non ha risolto tutti i problemi legati alla presenza di gentili nella Chiesa. Accettato il fatto che i Gentili battezzati non erano tenuti a essere circoncisi o per mantenere la legge di Mosè, la polemica esplode sul rapporto tra ebrei e gentili all'interno della comunità in particolare durante i pasti comuni. Dovrebbero sedersi in tavoli separati o potrebbero essi aderire allo stesso tavolo - ebrei e gentili, maschi e femmine, padroni e schiavi?
L'incidente di Antiochia mostra che Paul e James avevano opinioni diverse. James si oppose alla condivisione di tavoli tra ebrei e gentili, mentre Paul ha favorito esso. Peter è stato preso nel mezzo. All'inizio si e' conformato alla prassi della Chiesa di Antiochia, ma dopo "alcune persone sono venute da Giacomo" lui "si tirò indietro." Barnaba anche seguito il suo esempio. Paul ha reagito con veemenza, non esitando ad accusare sia Pietro (e con lui Barnaba) di "ipocrisia".
L'elemento dirompente della controversia e' che l'opposizione ad una pratica distinta (e dettata da una situazione contingente, nella comunita' di Antiochia) diventa adesso in Paolo opposizione teologica.
Il periodo di apprendistato con Barnaba e' terminato, Paolo e' ora il portatore cosciente di un proprio autonomo pensiero all'interno della prima comunita' cristiana. Nella lettera ai Galati egli ricorda ai suoi lettori le tappe fondamentali della sua vita La "conversione" che ha riorientato la sua percezione del giudaismo. I tr anni formativi che lo hanno posto in contatto con il messaggio cristiano e che sono culminati con il soggiorno a Gerusalemme con Pietr. Vengono poi i 14 anni di apprendistato con Barnaba, durante i quali egli ha maturato la sua vocazione di apostolo dei gentili. Ma tutto questo appartiene al passato. Per Paolo e' giunto adesso il momento di rivendicare la propria liberta' di pensiero e la propria autonomia anche nei confronti dei suoi mentori (Pietro e Barnaba). Il suo messaggio e' diverso dal loro e non dipende in alcun modo dal loro, in quanto la sua l'autorita' deriva direttamente da una "rivelazione" divina in Gesu Cristo:
- [11]Vi dichiaro dunque, fratelli, che il vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo; [12]infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. (Gal 1:11-12).
Paolo ha raggiunto una tale confidenza sulla giustezza del suo vangelo da addirittura dichiarare che " se qualcuno vi predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anàtema!" (Gal 1:9).
Paolo identifica il punto di svolta
La novita' dell'annuncio paolino ruota attorno ad una originale reinterpretazione dell'idea di giustificazione, ossia il perdono dei peccati (che e' e resta l'annuncio centrale del primo cristianesimo). Non solo il perdono e' offerto a tutti indistintamente (ebrei e gentili, cosa che anche Giacomo avrebbe ammesso) ma avviene indipendentemente dalla legge, per un atto di pura grazia. Ne deriva che all'interno della comunita' cristiana non possa esistere alcune distinzione tra ebrei e gentili, perché gli uni e gli altri sono ugualmente peccatori e sono egualmente giustificati per la grazia di Dio per mezzo di Gesù. Cio' porta Paolo a porre l'accento sulla morte di Gesu' come elemento decisivo del perdono dei peccati, cosi' come egli enuncia all'inizio stesso della lettera:
- Il Signore Gesù Cristo... ha dato se stesso per i nostri peccati, per strapparci da questo mondo perverso, secondo la volontà di Dio e Padre nostro (Gal 1:3-4).
La gratuita' dell'atto comporta che per quanto riguarda la giustificazione, gli ebrei (noi che per nascita siamo ebrei e non gentili peccatori, sapendo che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno».) non possono rivendicare alcuna superiorità, a meno di non negare la grazia di Dio. "Io non annullo la grazia di Dio; perché se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto per niente." (2,21).
La legge e' uno strumento di giudizio, non di perdono. Offre salvezza a chi la pratica, e condanna a chi la trasgredisce. "la legge non si basa sulla fede; al contrario dice che chi praticherà queste cose, vivrà per esse." (
Ma il perdono avviene del tutto indipendentemente dalla legge. e fu promesso ben prima che la legge fosse data.
La domanda sorge legittima; se la giustificazione e' basata sulla promessa, perche la Legge fu data. Questo e' un problema che riguarda gli ebrei, non i gentili, perche' e' agli ebrei che la legge fu data. Paolo cerca di non porre la promessa in opposizione alla legge, la giustificazione in contrasto al giudizio.
"La legge è dunque contro le promesse di Dio? Impossibile!" (Gal 3,21). "La legge è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede." (3,24). Ma adesso tutti i battezzati sono sullo stesso piano perche' sono stati giustificati dal compimento della promessa divina. la cosa non riguarda solo ebrei e gentili ma anche le altre distinzioni centrali Nella comunita' cristiana, "non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù." (Gal 3,28).
Il perdono e' stato offerto ai circoncisi ( "coloro che erano sotto la legge" (4,5) e agli incirconcisi (quando eravate sottomessi a divinità)
Nell'ultima parte della lettera Paolo affonta il problema specifico di gentili battezzati che vogliano circoncidersi (o ai quali sia richiesto di circoncidersi per acquisire uno status egualitario rispetto agli ebrei battezzati)
<Cio' significa che a maggior ragione per i gentili battezzati sarebbe ora assurdo la circoncisione> (per acquisire uno status egualitario rispetto agli ebrei battezzati , in quanto ad essi sono stati accomunati dal compimento della promessa. Da notare che Paolo <si rivolga a battezzati> non affronti qui il problema della circoncisione come prerequisito al battesimo (questione che era stata al centro del "Concilio" di Gerusalemme), ma il problema di gentili gia' battezzati che desiderino circoncidersi. Qui Paolo e' netto. Non c'e'; nessuna utilita' nel farlo, giacche' tra i battezzati essere circoncisi o incirconcisi non conta nulla. ("io Paolo vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla", 5,2). La loro uguaglianza deriva dall'essere stati perdonati sulla base della stessa promessa.
Per coloro che sono stati perdonati in virtu' della promessa cio' che e' richiesto e' di vivere secondo lo Spirito
"Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura." (3,15). Quindi
==
La rottura con Barnaba segna l'inizio dei due viaggi missionari di Paolo che lo condurranno fino in Grecia. Il primo (ca.50-52) lo porta fino in Grecia
E' durante il terzo viaggio cominciato ca. 54 lo porta a Efeso e quindi a Corinto dove (ca. 57) Paolo scrive la lettera ai Romani. Paolo e' ormai un protagonista affermato del nascente movimento cristiano
CAPITOLO TERZO
(6) La lettera ai Romani: un testo dell'apocalittico giudaica
Paolo si presenta alla comunita' di Roma nella complessita' delle sue identita'. E' un ebreo, circonciso, fiero dei privilegi e delle promesse legate all'alleanza stabilita da DIo con il suo popolo. E' un ebreo apocalittico (che crede nella fine dei tempi e nell'imminente venuta del giudizio). E' un seguace di Gesu' (che vede nella sua missione di Messia per il perdono dei peccati e attende il suo ritorno con gli angeli). E' un cristiano della diaspora (che sull'esempio di Barnaba ha abbracciato con convinzione la missione verso i gentili e ritiene che essi stessi siano destinatari del perdono divino. Ed e' ormai anche come il leader di una affermata componente del nascente movimento cristiano (che negli anni e' cresciuta a sviluppare un proprio modello originale di rapporto tra ebrei e gentili ed una teologia che ne e; al fondamento).
Non sorprendentemente, i problemi della origine del male, la libertà della volontà umana, e del perdono dei peccati sono al centro del pensiero di Paolo. Come abbiamo visto, questi non erano problemi problemi paolini, ma questioni sulle quali si interrogava tutto il giudaismo del Secondo Tempio. L'originalità di Paolo non e' nelle domande, ma nelle risposte.
Nella lettera ai Romani, Paolo scrisse alla comunità cristiana di Roma - una comunità cristiana di persone, ebrei e gentili, ex peccatori che credevano di aver ricevuto il perdono dei peccati attraverso la morte di Gesù. Paolo si rivolge ad una comunita' che non ha fondato, anche se sa di avere a Roma degli amici importanti, in primo luogo Priscilla e Aquila che con lui sono stati a Corinto e Efeso. Essendo chiamato adesso a spiegare il proprio punto di vista e non semplicemente a rispondere ai interrogativi rivoltigli dai propri seguaci, la lettera ai Romani presenta dei caratteri di maggiore organicita' che dovrebbero permettere una presentazione coerente del punto di vista paolino. Considerate queste condizioni, occorre essere molto cauti prima di parlare di irrisolvibili incoerenze o di pure speculazioni retoriche. Se la logica del discorso non ci appare lineare forse dipende, piu' che dallo scrittore antico, dall'interprete moderno che ha perso familiarita' con il contesto ideologico originario. Un lettura del testo all'interno del giudaismo del Secondo Tempio puo' gettare luce su alcuni nodi fondamentali del discorso paolino.
Il punto di partenza di Paolo e' l'imminenza del giudizio e la legittimita' dell' "ira di Dio ... contro ogni empieta' e ogni ingiustizia" (1:18). Dio infatti ha reso manifesto agli uomini "cio' che di Dio si puo' conoscere". Sono gli uomini ad essersi "perduti nei loro vani ragionamenti" e quindi ad essere responsabili.
Conoscendo la volonta' divina, gli uomini quindi sono "inescusabili" nelle loro opere di male. Cio' vale in egual misura per ebrei e gentili. A questo punto Paolo ripete l'indiscussa convinzione degli ebrei del Secondo Tempio che nel Giorno del Giudizio, Dio "renderà a ciascuno secondo le sue opere" (Rm 2:6). In nessun modo Paolo contesta il fatto che, se ebrei e gentili seguono rispettivamente la Torah e la propria coscienza, otterranno la salvezza nel giudizio. "La vita eterna" attende "coloro che perseverando nelle opere di bene cercano gloria, onore e incorruttibilità ... gloria, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima e poi per il greco, perche' presso Dio non c'e' parzialita' (Rom 2:
Paolo quindi ricorda ai suoi lettori che secondo il disegno di Dio la vita morale degli ebrei è regolato dalla Torah, mentre la vita morale dei Gentili è regolato dalla propria coscienza (guidata dalla conoscenza della legge naturale dell'universo) - un'idea che Paolo preso in prestito dal giudaismo ellenistico e la loro enfasi sul ordine creativo come il principale mezzo di rivelazione della volontà di Dio).
[2:12]Tutti quelli che hanno peccato senza la legge, periranno anche senza la legge; quanti invece hanno peccato sotto la legge, saranno giudicati con la legge. [13]Perché non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. [14]Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi; [15]essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono.
Paolo conclude la sua trattazione con la specifica annotazione cristiana ("secondo il mio vangelo") che il giudizio divino avverra' "per mezzo di Gesù Cristo", l'escatologico Figlio dell'Uomo.
Unico tratto distintivo "cristiano" e' cosi' fino a questo punto l'indicazione di Gesu' come del futuro giudice escatologico, un elemento che subito colloca Paolo nel versante apocalittico.
A questo punto Paolo cita un passo delle Scritture (Qohelet 7: 2) a dimostrazione del fatto che il male è un problema universale e nessuno puo' dirsene immune. La posizione paolina non consiste nella ripetizione di un'affermazione biblica da tutti condivisa ma dalle conseguenze che egli ne trae. L'esperienza che non esista alcuna persona che non pecchi e' sotto gli occhi di tutti, ma ovviamente gruppi diversi ne traevano conclusioni diverse. Un sadduceo vi avrebbe visto conferma del ruolo essenziale dei sacrifici in ordine di mantener e restaurare l'ordine divino in caso di trasgressione. Un fariseo vi avrebbe scorta la necessita' di un continuo processo di conversione dell'individuo, secondo la strada indicata dalla propria interpretazione della Torah. Paolo invece lo intende nella prospettiva apocalittica di un'origine superumana del male. E difatti Paolo si immerge immediatamente su una questione cruciale che era allora dibattuta nei circoli apocalittici del tempo. Paolo prende posizioni contro coloro che vedevano nell'alleanza con DIo e nella Legge il segno di una immunita' dal peccato generato dalla ribellione degli angeli. E' la posizione che troviamo espressa nel Libro dei Giubilei (e i testi della comunita' di Qumran), dove Dio nella sua onnipotenza ha fin dalle origini della creazione disegnato per Israele (o per i suoi eletti) uno spazio che lo separa e lo difende dal mondo contaminato dal peccato angelico. Gli spiriti maligni sono stati lasciati liberi di contaminare la terra, ma Israele ha nel patto la "medicina" che lo protegge dalla sua loro influenza. Paolo invece rimane in linea con la tradizione enochica del Libro dei Sogni la quale afferma che l'alleanza e il possesso della Legge non significano alcuna immunita' dal peccato.
Certo, essere membri del popolo ebraico rappresenta una "superiorita'" e la circoncisione e' "utile" (Israele rimane il popolo eletto), ma anche Israele al pari delle altre genti e' soggetto al potere degradante del male (nel linguaggio del Libro dei Sogni da "buoi" sono diventati "pecore"). Come Paolo chiarisce "quanto la Legge dice, lo dice per quelli che sono sotto la Legge" ed anch'essi sono egualmente "colpevoli di fronte a Dio" (3:19). la conclusione e' perentoria: "Giudei e greci, tutti, sono sotto il dominio del peccato".
La comunanza nel peccato di ebrei e gentili rende necessario e plausibile un intervento che riguarda entrambi allo stesso modo. A questo punto Paolo puo' fare seguire l'annuncio cristiano che si e' adesso manifestata in Cristo la giustizia di Dio, annunciata dalla legge e dai profeti. Tale giustizia e' rappresentata dal perdono dei peccati. Per Paolo questo atto di perdono avviene "indipendemente dalla legge" ed e' aperto a "tutti quelli che credono". Tutti coloro che hanno peccato sono giustificato gratuitamente per grazia attraverso la fede in Gesu che e' "strumento di espiazione". In questo non c'e' distinzione alcuna tra ebrei e gentili. . Dio non e' Dio soltanto dei Giudei ... lo e' anche dei gentili ... Non c'e' che un solo Dio che giustifichera' i circoncisi in virtu' della fede e gli incorconcisi in virtu' della fede.
Che la giustificazione basata sulla promessa operi per ebrei e gentili e' dimostrato dall'esempio di "Abramo, nostro antenato secondo la carne". A Abramo che non era ancora circonciso, allora Dio rivolse una promessa ed Abramo fu giusticato perche' credette. "Di fronte alla promessa di Dio, [Abramo] non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede ... Ecco perché gli fu accreditato come giustizia.
Oggi per Paolo una nuova promessa e' data, quella del perdono dei peccati: "Gesu Cristo nostro Signore ... è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. (Rom 4:24-25). La risposta a tale promessa non deve essere l'incredulita' ma come nel caso di Abramo la fede. Nel mondo esistono giusti e persone buone ma Gesu' non e' morto per loro ma per i peccatori. Per Paolo la giustificazione e' il primo passo importante nella strada verso la salvezza. Coloro che in questo modo sono stati "riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita." Coloro che da Dio sono riconciliati affrontano ogni tribolazione con perseveranza, saldi nella speranza della salvezza futura. "Giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui."
<viviamo "nella speranza della gloria di Dio". Le tribolazioni che i cristiani affrontano producono perseveranza e virtu' provata e questo e' il fondamnto della speranza Che "saremo salvati mediante la sua vita. > <Con tutto il Secondo Tempio degli ebrei Paolo riconosce la presenza del male, e cita un passo delle Scritture (Qohelet 7: 2) a sottolineare che il male è un problema universale. Ogni Secondo Tempio Ebreo sarebbe stato d'accordo. I problemi sono le implicazioni e rimedi a questa situazione.>
A questo punto Paolo affronta il nodo centrale. Perche' il sacrificio di Gesu' e il dono della riconciliazione sono necessari? Il problema per Paolo non è la Legge mosaica o la legge naturale, il problema è il peccato.
Paolo lati con la tradizione apocalittica di origine sovrumana del male. Con le tradizioni enochico, condivide un simile contesto di battaglia cosmica tra il Principe della Luce e il Principe delle Tenebre: "Che comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quale accordo c'è fra Cristo e Belial "(2 Cor 6,15), così come la speranza per il futuro di riscatto dal potere del diavolo:" Il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi "(Rm 16,20) . Quello che possiamo notare, tuttavia, è una certa visione più pessimistica del potere del male. Nel sistema paolino, il peccato di Adamo prende il posto del peccato degli angeli caduti: "Il peccato è entrato nel mondo attraverso un solo uomo [ie Adamo], e la morte è venuto attraverso il peccato, e così anche la morte per tutti perché tutti hanno peccato "(Rm 5,12). Il problema non e' la lgge il peccato esisteva anxche prima della legge. Il peccato di Adamo è controbilanciata dalla obbedienza del "nuovo Adamo", Gesù. Al fine di creare le condizioni che hanno reso necessario il sacrificio del Salvatore celeste, Paolo sfrutta la vista enochico del male radicalizzando la sua potenza. Mentre nelle persone Enoch (giudei e gentili) stanno lottando contro l'influenza delle forze del male, Paolo immagina uno scenario post-guerra in cui "tutti, Giudei e Greci, sono sotto il potere del peccato" (Rm 3: 9). Adamo ed Eva hanno perso la battaglia contro il diavolo e di conseguenza tutti i loro discendenti sono diventati "schiavi del peccato" (Rm 6: 6).
La schiavitù era un'istituzione sociale stabilito durante l'Impero Romano. Quando Paolo parlava di popolo sconfitto e schiavi a causa della guerra, tutti sapevano esattamente cosa le implicazioni erano per loro ei loro figli. Una volta che la lotta era finita, gli schiavi dovevano rassegnarsi alla loro condizione. Giuseppe Flavio esprime il senso comune del suo tempo, quando si rivolge agli abitanti di Gerusalemme assediata e ricorda loro che "la lotta per la libertà è una cosa giusta, ma avrebbe dovuto essere fatto in un primo momento ... Pretendere ora di scrollarsi di dosso il giogo [dei Romani] è stato il lavoro di coloro che avevano in mente di morire miseramente, non di quali fossero gli amanti della libertà ... si tratta di una legge forte e determinato, anche tra bestie, così come tra gli uomini, di cedere alla quelli che sono troppo forti per loro "(Bel V.365-67). I Romani ammirato e onorato coloro che hanno combattuto coraggiosamente per la libertà, ma disprezzato gli schiavi ribelli e condannato loro alla croce. Nessuno poteva aspettarsi il diavolo per essere più debole rispetto ai Romani. La libertà può essere recuperato solo attraverso il pagamento di un riscatto.
Significa che tutti gli "schiavi" sono peccatori? Non necessariamente. Ancora una volta, questa è stata una questione di esperienza comune. Essere uno schiavo non significa necessariamente essere "ingiusti". Tuttavia, gli schiavi sono in una situazione molto precaria in quanto non sono liberi e in qualsiasi momento potrebbero essere comandati dal loro padrone di fare le cose malvagie.
Paul mai in dubbio la santità e l'efficacia del mosaico Torah o implica il suo fallimento. Al contrario, egli ribadisce la "superiorità" del Mosaico Torah e il patto ebraico che ha dato agli ebrei come "una piena consapevolezza della caduta" (Rm 3,10) e le "profezie" sulla venuta del Messia. È il peccato che deve essere incolpato, non la Torah:
"La legge è santa, e il comandamento è santo e giusto e buono. Ha fatto ciò che è bene, quindi, portare la morte a me? Niente affatto! E 'stato il peccato, la morte lavorando in me attraverso ciò che è buono, in modo che il peccato può essere dimostrato di essere il peccato, e per mezzo del comandamento potrebbe diventare peccato oltre misura. Sappiamo infatti che la legge è spirituale; ma io sono di carne, venduto come schiavo al peccato. Non capisco le mie azioni. Io non faccio quello che voglio, ma faccio la cosa che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, sono d'accordo che la legge è buona. Ma in realtà non è più io a farlo, ma il peccato che abita in me ... Poiché io mi diletto nella legge di Dio nel mio intimo, ma vedo nelle mie membra un'altra legge in guerra con la legge della mia mente , che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte? (Rom 7: 12-24)
E 'questa situazione di schiavitù totale, non una debolezza intrinseca del "bene" Torah, che porta Paolo a fare ciò che il Libro delle Parabole di Enoch aveva già fatto, cioè, a cercare la speranza per i peccatori, non solo in un eroico attaccamento alla legge (in base alla giustizia di Dio), ma anche in un intervento della Misericordia di Dio, un'offerta graziosa di perdono dei peccati "a parte la legge" (e la giustizia di Dio). La malvagità della natura umana sotto il potere del peccato stabilisce che "nessun essere umano sarà giustificato per le opere previste dalla legge» (Rm 3,20), ma solo di un atto gentile di "giustificazione per grazia di Dio come dono, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, Dio lo ha prestabilito come sacrificio di espiazione del suo sangue "(Rm 3: 24-25). Dio ha dovuto reagire a una situazione estrema di disagio e di controbilanciare l'azione del diavolo con un estremo atto di misericordia: "Perché, mentre eravamo ancora deboli, al momento giusto Cristo morì per gli empi. In effetti, raramente si chiunque morire per una giusta persona, anche se forse per una persona buona qualcuno potrebbe davvero il coraggio di morire. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più sicuro poi, ora che siamo stati giustificati per il suo sangue, saremo salvati per mezzo di lui dall'ira di Dio "(Rm 5: 6-9).
L'intero dibattito sulla "giustificazione" e "salvezza" in Paul è ancora troppo influenzato dal quadro della teologia cristiana. Come un Ebreo apocalittico e un seguace di Gesù, Paolo ha affermato che il perdono dei peccati è stato il risultato importante di Gesù il Messia per gli Ebrei e Gentili, nella battaglia cosmica che Gesù ha combattuto contro le forze demoniache. Motivazione fornisce ai peccatori (Ebrei e Gentili allo stesso modo), un antidoto, o almeno un sollievo tanto necessario alla travolgente potere del male - una seconda possibilità data alle persone senza speranza. Erano "nemici" ma Cristo è morto per loro. Usando il linguaggio delle parabole di Enoch, quei peccatori ebrei e gentili che hanno ricevuto il battesimo si sono messi tra gli "altri", che non sono né "giusto" o "ingiusti", ma ora sono "peccatori pentiti". Non hanno meriti di rivendicare in base alla giustizia di Dio, ma hanno ricevuto la giustificazione mediante la misericordia di Dio.
Paul è convinto che coloro che sono giustificati saranno anche "salvato" nel giudizio, ma la giustificazione non è uguale salvezza (VanLandingham 2006). Essere perdonati dei loro peccati è per i peccatori un passo importante sulla via della salvezza, ma non è una garanzia di futuro salvezza nella sentenza in cui saranno valutate solo le loro opere. <La liberazione dal peccato non rende immuni da ogni responasabilita' (assicurando una salvezza a prescindere dalle azioni) ma al contrario restaura le condizioni del libero abitrio e responsabilizza l'individuo a esercitare la proprie scelte in liberat' e non in schiavitu.> Quindi, Paolo ricorda continuamente i suoi lettori della necessità di rimanere "immacolati" dopo aver ricevuto il battesimo. <e con scandalo guarda a coloro che alla liberazione dal peccato non fanno seguire scelte conformi di opere buone: "Stolti Galati...> Avere equiparato "giustificazione mediante la fede" (che Paolo predicò) con "(eterna) salvezza per fede" (che Paolo non predicò mai) è uno dei maggiori distorsioni del reinterpretazione cristiana di Paolo.
Paolo affronta il problema del fatto che non tutti gli ebrei hanno riconosciuto Gesu' come Messia.
Paolo non parla dell'incredulita' di Israele, come talora si legge in alcuni commentari. Paolo parla dell'incredlita' di una parte di Israele. Lui stesso, ebreo, figlio di ebrei della tribu' di beniamino, corconciaso" e' la prova vivente che
l contrario sono i gentili che sono stati accolti all'interno del popolo ebraico. Paolo rifiuta ogni logica sostitutiva. I gentili non hanno sostituito Israele con nuovo popolo di DIo. SI tratta solo che l'incredulita' di alcuni ebrei ha aperto lo spazio all'accoglienza di alcuni gentili. Le promesse e i patti di Dio rimangono validi e lo rimangono per sempre.
La situazione di quegli ebrei che non riconoscono l'autorita' di Gesu e' cosi' divenuta eguale uguale a quella dei gentili che non riconoscono l'autorita'. Questo significa che non ci sia possibilita' di salvezza al di fuori Certo non c'e' possibilita' dui giustificazone e questo - agli occhi di Paolo - rende difficile (ma non esclude) la salvezza di molti di loro. Paolo comunque e' fiducioso che "alla fine" tutto Israele sara' salvato. Non esistono "giusti" tra di essi? Questo Paolo non lo afferma, il giudizio rimane opera di Dio ed e' basato sulle opere di giustizia compiute da ciascuno individuo, cosi' come sulla capcita di perseveranza di coloro che hanno rievuto il battesimo in Cristo. La salvezza individuale e' facilitata dalla fede in Cristo che libera dal peccato ma il giudizio finale non dipende dall'accettazione dell'offerta di perdono in Cristo
CAPITOLO QUARTO
(7) Paolo Controverso cristiana vs James e Peter
La storia dunque ci restituisce l’immagine non di un Paolo polemico contro il popolo ebraico e la Torah, ma di un Paolo protagonista di un dibattito tutto interno al popolo ebraico e alle sue componenti apocalittiche in particolare, in una polemica che già prima di Paolo vedeva scontrarsi contrapposti gruppi giudaici. Lo scontro si ripercuote anche all’interno della tradizione cristiana dove si confrontavano sensibilità e prospettive diverse, come reso palese dalla polemica che separa la tradizione paolina da quella di Giacomo. Quando nel XIX la scuola di Tubingen scopri' il paolinismo e la sua opposizione con Giacomo, vi vede il segno della lotta decisiva scatenatasi all'interno del cristianesimo tra la "nuova" religione e l'ala conservatrice o giudaizzante. Paolo fu certo una figura controversa all'interno del giudaismo del Secondo Tempoi anche per il passato farisaico e l'impostazione apocalittica del suo pensiero certo non poteva essere da tutti condivisa, soprattutto in un;ottica farisaica. Sia l'opzione farisaica che quella apocalittica appartengono al giudaismo del Secondo Tempio. L'opposizione a Paolo non e' da parte del giudaismo ma di un certo giudaismo, cosi' come la sua battaglia di Paolo non e' contro il giudaismo ma contro una certa visione del giudaismo. Fare di Giacomo l'alfiere del giudaismo contro la novita' cristiana e' del tutto fuorviante, ma anche farne l'esponente di una sorta di cristianesimo farisaico, la quinta colonna e' non meno fuorviante. Gli atti degli apostoli parlano di una corrente "farisaica" cristiana come di una minoranza che al Concilio di Gerusalemme si oppone al battesimo dei gentili che non fossero prima circoncisi. Ma Giacomo -- abbiamo visto -- non e' su quella linea. Giacomo condivide con Paolo l'idea apocalittica che nel giudizio "la misericordia prevale sulla giustizia"
ecc. ecc.
Paul era solo una voce in un dibattito che ha coinvolto e diviso i molti componenti del giudaismo del Secondo Tempio, e la sua posizione riflette la posizione generale del movimento di Gesù. Possiamo capire perché Paolo è stato visto con sospetto da altri ebrei che non condividono l'idea apocalittica dell'origine sovrumana del male e respinto l'enfasi sulla missione cristiana del perdono compiuta da Gesù il Messia. Allora perché è stato Paolo anche una figura controversa all'interno del movimento di Gesù? La risposta non può essere attribuita solo a un sospetto naturale verso una persona che è stata a lungo considerata come un "nemico" e per sua stessa ammissione perseguitato la Chiesa.
C'è qualcosa nella teologia di Paolo, che lo differenzia da altri leader cristiani (come Pietro e Giacomo). Mentre alcuni membri del movimento di Gesù sembrano più interessati in una prospettiva di restauro delle Dodici Tribù di Israele (vedi l'incipit della lettera di Giacomo), in Paolo vi è una particolare attenzione all'inclusione di Gentili. Non è stato un problema nuovo; molto prima Paul, comunità ebraico-ellenistica avevano già sviluppato modelli di inclusione dei Gentili nelle comunità come "timorati di Dio." Paul, invece, lo ha fatto in modo apocalittico, seguendo le linee di testi come il Libro dei Sogni enochico, dove si legge che nel mondo a venire la "pecora bianca" (Ebrei giusti) saranno riuniti al "uccelli del cielo "(i gentili giusti), a formare il nuovo popolo di Dio. Nelle parabole di Enoch anche, il Messia Figlio dell'uomo viene indicata come la "luce" delle genti. Paul non ha mai affermato di essere stato il primo a battezzare Gentili. Ciò che distingue è l'entusiasmo con cui Paolo ha dedicato la sua vita alla predicazione ai Gentili. <Lo stesso Barnaba
< La visione che vede Paolo contrapporsi alla leadership dei Cristiani ebrei circa
Ma c'è
qualcosa che è molto più controversa. Paolo sembrava aver spinto per uno status uguale di Gentili all'interno della nuova comunità.
L'unanimità apparente raggiunto il cosiddetto Consiglio di Gerusalemme non risolve tutti i problemi legati alla presenza dei gentili nella Chiesa. A condizione che battezzati pagani non erano tenuti a essere circoncisi o per osservare la Legge di Mosè, la polemica è esplosa sul rapporto tra ebrei e gentili all'interno della comunità soprattutto durante i pasti rituali comuni. Dovrebbero sedersi a tavoli separati o potrebbero non aderire allo stesso tavolo - Ebreo e Gentile, maschio e femmina, liberi e schiavi?
La teologia di Paolo e' funzionale a questa idea.
Paul sfrutta la sua visione pessimistica circa la peccaminosità della natura umana, al fine di affermare la "uguaglianza nel peccato" di ebrei e gentili all'interno della Chiesa. Il punto è che per Paolo la giustificazione, cioè il perdono dei peccati, viene da solo la fede. Mentre altri cristiani sarebbero parlare di peccato come una tentazione (che consente un ruolo più importante per la libertà della volontà umana), la metafora della schiavitù lascia spazio solo a una personale "sì" (e rende privo di senso l'idea dell'esistenza di eventuali prerequisiti e qualsiasi pretesa di "superiorità" dagli ebrei nel corso dei pagani, e quindi alcuna giustificazione per una distinzione dei due gruppi nella nuova comunità). Se solo un "sì" viene chiesto ai peccatori, non c'è spazio per le "opere" e la giustificazione è "solo la fede". Se invece il peccato è una tentazione e peccatori mantenere un certo grado di libertà, allora possono e devono essere invitati a "provare" la loro fede con alcune "opere". Questo è ciò che la lettera di Giacomo fa sostenendo che "una persona è giustificato per le opere e non per la sola fede" e "la fede senza le opere è morta" (Giacomo 2: 19-26). La giustificazione è il risultato di una sinergia tra l'uomo e Dio: [Dio] dà ancor più grazia; quindi dice: "Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili." Sottomettetevi dunque a Dio. Resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Lamentarsi e afflitti e piangerete. Lasciate che il vostro riso si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà. (Giacomo 4: 6-10). Non a caso, la lettera di Giacomo non menziona neppure la morte di Gesù; la predicazione di Gesù, la "legge della libertà" ha insegnato, è il presupposto per la giustificazione. Per Paolo invece la morte e il sacrificio di Gesù è l'unica cosa che conta come un atto unilaterale e grazioso della misericordia. "Io non annullo la grazia di Dio; infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto per niente "(Galati 2:21). La disputa teologica aveva profonde implicazioni pratiche nella vita della Chiesa. L'incidente di Antiochia mostra che Paul e James avevano vista opposti di come gli ebrei e gentili dovrebbero coesistere nella chiesa. James si oppose alla condivisione di tavoli tra ebrei e gentili, mentre Paolo favorito esso. Pietro e Barnaba è stato catturato nel mezzo. All'inizio Peter conforme con la prassi della Chiesa di Antiochia, ma dopo "alcune persone sono venute da James" egli "si ritrasse." Paul ha reagito con veemenza, affrontare Pietro e accusandolo di "ipocrisia". Per Paolo non c'è distinzione tra i membri ebrei e gentili della chiesa, perché erano ugualmente peccatori e sono stati altrettanto giustificati dalla grazia di Dio per mezzo di Gesù. Per quanto riguarda la giustificazione, gli ebrei non possono vantare alcun superiorità, a meno che non negano la grazia di Dio. "Io non annullo la grazia di Dio, perché, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto per niente." (02:21).
Vuol dire che Paolo "abolito" la distinzione tra ebrei e gentili tout court in questo mondo? E' quanto comunemente si afferma, ma una lettura attenta di Paolo invita quanto meno alla prudenza. Molto interessante, Paolo famoso detto circa l'uguaglianza tra ebrei e gentili arriva in un contesto più ampio che ha incluso "maschio e femmina" e schiavo e libero ":" Non c'è più Ebreo né Greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è più maschio e femmina; per tutti voi siete uno in Cristo Gesù. "(Gal 3,28) In vista di Paolo, queste categorie sono in qualche modo alterati in questo mondo; non vi è inimicizia più e opposizione in Cristo. Eppure nessuna di queste categorie è abolita. Tanto meno per crearne una terza (cf. Pesce 31-32: in tutte e tre queste divisioni "L'essere in Cristo e' la sospensione escatologica, e' l'anticipazione della fine della contrapposizione tra queste... categorie di esseri umani. Non e' la creazione di una terza categoria" >
Paolo chiede Filemone ad accogliere la sua latitanza schiavo Onesimo come un fratello in Cristo, ma non dice Filemone a liberare tutti i suoi schiavi, con l'argomento che in Cristo Gesù non c'è più schiavo o libero. Paolo menziona Priscilla prima del marito Aquila nel ministero di Cristo (Rm 16: 3-4), ma ribadisce che "il capo della donna è l'uomo" (1 Cor 11: 3), mentre avrebbe potuto sostenuto che in Cristo Gesù non c'è più maschio e femmina. Paolo proclama la fine di ogni ostilità tra Giudei e Gentili in Cristo, ma ... Perché avrebbe dovuto sostenuto solo in questo caso che una tale distinzione non è più valido? Ironia della sorte, la teologia tradizionale cristiana ha sottolineato la "fine" definitiva della distinzione tra ebrei e gentili come decreto divino, ma non ha mai preso una posizione forte sulla parità "abolizione" di ogni distinzione di genere e di status sociale. Delle due una: o Paul abolito tutte e tre le categorie o non ne ha abolito nessuna.
CONCLUSIONE
7. Sintesi e Conclusioni
Chi e' Paolo? Il fondatore dell'intolleranza cristiana, colui che afferma che non vi e' salvezza e bene se non nell'adesione al Cristo, o l'apostolo della misericordia divina, il servo di quel Gesu' che non ha esitato a morire per la salvezza dei nemici e dei lontani? Talora le due immagini si sovrappongono nella predicazione cristiana, quasi che esse potessero essere conciliabili e potessero essere spese a proprio piacimento a seconda delle circostanze. In un mondo oggi come ieri dilaniato da tensioni e conflitti religiosi, l'Olocausto ieri e oggi l'integralismo islamico, le parole pesano come macigni e non possiamo illuderci che esse non contino, che non abbiano conseguenze, che non preparino le coscienze all'azione.
Come uomo, non mi ha mai convinto l'immagine di Paolo come del campione di ogni intolleranza, sia pure edulcorata da tante belle parole circa l'universalita' cristiana. Bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno. Il predicatore (di ogni religione) che afferma che tutti sono i benvenuti nella comunita' dei salvati ma che non vi e' possibilita' di bene al di fuori di un rapporto esplicito con Gesu ne' salvezza se non nella fede esplicita in Gesu', non e' altro che un pericoloso intollerante. Questo e' oggi il messaggio dei fanatici di ogni religione, i quali accolgono col sorriso ogni proselito ma pensano che solo coloro che condividono la loro fede sono destinati alla salvezza, mentre "gli altri" sono condannati alla perdizione. Davvero pensiamo che Paolo fosse uno di loro e che la sola differenza che mentre alcuni "uccidono con la spada" i buoni cristiani debbano rivendicare la loro liberta' di "uccidere" gli altri con le parole. < Con la sola differenza che Paolo uccideva a parole, mentre alcuni uccidono con la spada >
Non mi convince nemmeno l'immagine di alcune voci della New Radical Perspective che mentre si preoccupa di affermare che gli ebrei, a differenza di tutti gli altri uomini possono salvarsi in virtu' della Legge, poi consolida la stessa intolleranza nei confronti del resto dell'umanita' che ancora una volta si afferma avrebbe accesso alla salvezza solo in virtu della fede esplicita in Gesu. Mi sembra una forzatura dettata da una certa visione del dialogo abraico-cristiano che non si preoccupa dei dati storici, ne' dell'implicazione con il dialogo con gli uomini tutti.
Come storico rigetto queste caricature delle figure di Paolo che nel suo tempo fu portatore di un messaggio di grande apertura e tolleranza verso i peccatori. Paolo nelle sue lettere non e' mosso dal desiderio di condannare ma dalla preoccupazione per i peccatori cui rivolge il lieto annuncio della promessa di giustificazione di Dio attraverso il Flgio suo Gesu' Cristo. Paolo e' stato al contrario il portatore di un buona notizia di salvezza e di speranza. Gesu' non e' venuto a predicare la condanna per coloro che non credono in lui, ma la salvezza non solo per i giusti ma anche per i peccatori. >
E' per me incredibile e inspiegabile come da molti cristiani Paolo sia presentato come il portatore di un messaggio di condanna verso coloro che non credono in Gesu'. Non giudicare e' una dei pochi insegnamenti di Gesu' che Paolo ripete a chi vorrebbe separarsi non solo dal peccato ma fisicamente dai peccatori. "Lascia la vendetta a Dio." E' starodinario come il richiamo alla centralita' del tema della misericordia ribadito nell'insegnamento di Papa Francesco da molti sia avvertito come una pericolosa novita' teologica e non come il richiamo all'idea fondante del cristianesimo.
Paolo era un ebreo del secondo tempio, un ex fariseo divenuto membro e leader del movimento di Gesù. Come molti Secondo Tempio degli ebrei (anche al di fuori del movimento di Gesù), a causa della sua "conversione" Paul abbracciato la visione apocalittica di origine sovrumana del male e guardò i peccatori, non solo come persone responsabili delle proprie azioni, ma anche vittime di un male soprannaturale e desiderava, e si aspettava, qualche aiuto dal cielo per controbilanciare il potere del male.
Come tutti i membri del gruppo cristiano, Paul ha condiviso l'idea che Gesù il Messia era venuto sulla terra come il Figlio dell'uomo per portare il perdono ai peccatori, e tornerà presto a eseguire la sentenza. Come membro della comunita' di Antiochia, Paolo credeva fermamente che questo messaggio di perdono incluso Gentile peccatori pure, e ha deciso di dedicare la sua vita a predicare ai gentili. Contrariamente ad altri membri dei movimenti di Gesù si è rifiutato di accettare che i pagani battezzati avevano uno status diverso o inferiore all'interno della Chiesa, come lui non riusciva a vedere alcuna differenza tra un peccatore ebreo e un peccatore Gentile, in quanto entrambi erano stati perdonati "per sola fede." Ciò non vuol dire che ha sostenuto l'abolizione della distinzione tra Giudei e Gentili in questo mondo; al contrario, come nel caso del genere e distinzioni sociali li accettato come una realtà inevitabile (e forse anche provvidenziale) fino alla fine dei tempi, quando queste distinzioni sarebbero scomparire.
Come Secondo Tempio Ebreo, Paul mai ha messo in dubbio la validità della Torah o il ruolo che la coscienza esercita nell'animo del non-ebreo; la sua preoccupazione era l'incapacità delle persone di obbedire alla Torah e alla propria coscienza. Paolo era un Ebreo Torah-osservanti, che credeva che "la giustificazione per fede" è stato un dono offerto per mezzo di Gesù il Messia di tutte le "peccatori" (non solo a Gentili). Significa che credeva che gli ebrei dovrebbero abbandonare l'obbedienza della Torah e che nessun Ebreo poteva essere salvato senza battesimo? Nient'affatto. Mentre ripetendo l'insegnamento ebraico comune che "tutti gli uomini sono peccatori", Paul ha condiviso l'idea apocalittica tale sentenza è stato secondo ai fatti e l'umanità era divisa tra il "giusto" e "ingiusto". Ma ora che è giunto il tempo della fine, gli ingiusti sono stati offerti la possibilità di pentirsi e ricevere la giustificazione attraverso il perdono. Paolo predicò principalmente per i gentili, ma il suo messaggio non era né indirizzato solo ai gentili, né è stato unico per loro. Esattamente lo stesso Vangelo è stato annunciato a ebrei e gentili - la buona notizia del dono del perdono. "Mi era stato affidato il compito di predicare il Vangelo ai non circoncisi, come a Pietro era stato al circoncisi" (Galati 2: 7).
Paolo certo aveva una visione molto più pessimistica del potere del male. e questo lo porta ad allargare i confini della misericordia divina a ebrei e gentili senza distinzione. Paolo ha paragonato la situazione dell'umanità ad una popolazione sconfitto e asservita dal diavolo, ma avrebbe condiviso il principio gesuano che solo i malati hanno bisogno del medico. I malati comprendono ebrei e gentili, (forse la maggioranza) ma non necessariamente tutti. I giusti, ebrei e gentili, non hanno bisogno del medico.
Dire che gli ebrei hanno la Torah, mentre i Gentili hanno Cristo non rappresenta fedelmente la posizione di Paolo. Nella visione di Paolo, Cristo è dono di Dio, non per i soli ebrei ne' per i soli gentili, ma per i peccatori. I giusti (ebrei e gentili) saranno salvati se hanno compiuto buone azioni. Ma Paolo è consapevole del fatto che il potere del male rende così incredibilmente difficile per tutta l'umanità ad essere giusti, per gli ebrei a seguire la Torah e per il Gentile di seguire la propria coscienza. Egli predica la buona notizia che alla fine dei tempi i peccatori (giudei e gentili) viene offerta la possibilità straordinaria di pentirsi e di essere giustificati in Cristo per la misericordia di Dio, a parte la giustizia di Dio. <E' giunto il momento di restituire A Pauolo la forza rivoluzionaria del suo annuncio> Paolo non era luterano <e non era intollerante>: non ha mai insegnato "la salvezza per fede soltanto" per l'umanità; ha annunciato al peccatori "giustificazione (cioè, il perdono dei peccati passati) per fede". Paolo non predicare solo due vie di salvezza, ma piuttosto a tre - gli ebrei giusti hanno la Torah, i Gentili giusti hanno la loro coscienza; per i peccatori (ebrei e gentili), che sono caduti senza speranza sotto il potere del male e anelano alla conversione, esiste il perdono del Cristo.
For too long we have made Paul the apostle of intolerance, the one who was admonishing people that they will NOT be saved unless they believe in Jesus. But Paul was not concerned about condemning, he was concerned about announcing the Mercy of God. I think that we should invite our colleagues in the Church to see Paul as the champion of God's Mercy. Paul is concerned about the power of evil, but is announcing that God wants the salvation of the sinners, of all sinners (Jews and Gentiles alike) and has even sacrificed his own Son in order to achieve this goal.
We have turned Paul's message of Mercy into a threat against non-Christians and against people of good will who try hard to be righteous (as if Paul were a prophet of doom and were saying: "no matter what you do, if you don't believe, you will go to Hell"). Instead Paul is announcing the good news that God loves the sinners, that Jesus died for their liberation. No matter what your sins are, God has offered to everybody a second chance and did the unthinkable in order to lead everybody to redemption.
I think that we have forgotten that Paul was an apostle of mercy.
Therefore my answer to your question would be: instead of being concerned about who will NOT be saved, let's all be concerned with Paul about announcing a loving and merciful God who like a good shepherd leaves his sheep in the stable and goes in search of the lost ones. In Matthew, Jesus says that he was sent to the lost sheep of the House of Israel. Paul would have said that he was sent to the lost sheep among the nations. I dream of a church that is not concerned about condemning but about searching the poor and the lost. Let's tell our colleagues in the Church that like Jesus and Paul we should be not judges but heralds and testimonies of the Mercy of God.
Paul, a Second Temple Jew: The New Radical Perspective Revisited
By Gabriele Boccaccini
Introduction
When in 1927 British novelist Cecily Spencer-Smith Phillimore published his "Paul the Jew", not a few pouted, as if the name of the apostle was vilified by association. Phillimore was a devout (traditional) Christian, she did not intend to promote any theological revolution. Her novel dealt with the life of the apostle before his conversion, that is, before "Paul the Jew" became "Paul the Christian", as the title of the sequel of novel fully revealed in 1930. However, talking of Paul the Jew, or simply reminding the readers of what he was, appeared to many as an inappropriate remark if not an unbearable insult to the memory and work of the greatest Christian theologian, whose major accomplishment had been exactly to emancipate the nascent Christianity from Judaism.
Three assumptions:
(a) At the center of Pauline theology is a polemic against the Law, which he abolished. Paul attacked the view, held by his Jewish and Jewish Christian opponents, that salvation can be earned by "works," that is, acts of obedience to the Law. Paul the champion of "righteousness by faith" vs. Jewish works-righteouness.
(b) universalism vs. particularism (creation of a "third race", distinct from both Judaism and paganism)
(c) While Second Temple Jewish Literature has no (or little) interest for the interpretation of Paul
The Christian prejudice was largely shared by Jews. While Jesus the heretic could easily become "the Jewish brother" misunderstood and exalted by his Gentile followers, Paul appeared to be beyond any possibility of redemption. After all, he was the one who was primarily responsibly for such a misinterpretation of Jesus and the transformation of Christianity into a non-Jewish religion. As the Karaite leader clearly spelled out already in the X century, it was Paul (not Jesus) who created Christianity. The few Jewish authors who dare deal with Paul were "Christian converts," like Felix Mendelssohn-Bartholdy, or were suspected of being (crypto-Christians or) too dangerously naive in their desire to reach out to a Christian audience, like Werfel and Asch.
Unlike Jesus, who also "in the beginning of the twentieth century was commonly viewed in contrast to Judaism, but is now firmly localized within first-century Judaism" (Zetterholm, p.2), Paul is still largely (was) a taboo in Judaic Studies. When Claude Montefiori published the first work by a Jewish scholar on the subject it was primarily to defend the honorability of Judaism from the attacks of Paul, claiming that Paul did not target "(rabbinic) Judaism" but only a corrupted Hellenistic variant of it, "which was colder, less intimate, less happy because it was poorer and more pessimistic" (Montefiore, p.93).
Paul's opposition to Judaism was inthetized in two basic elements:
grace vs. law
and universalism vs. particularism
"Christianity began with one tremendous problem. Clearly the message of Christianity was meant for all men… But the fact remained that Christianity was cradled in Judaism; and, humanly speaking, no message which was meant for all the world could even have had a more unfortunate cradle. The Jews were involved in a double hatred--the world hated them and they hated the world" (Barclay 1958, p.9).
Without Paul Christianity would have remained a Jewish sect with a strong messianic emphasis.
The new perspective Moore - Stendahl - Sanders.
Sandmel -- Segal -- Boyarin
The New Radical Perspective
Schweitzer -> Davies -> Klausner
Things have changed dramatically with the so-called "New Radical Perspective"
Assumptio that Paul was a Jew and remained a Jew
The NRP sees "Paul as the representative of a universalistic, messianic, Jewish movement for which the main problem was the salvation of the non-Jews" (Zetterholm, p.10). "Paul can be completed located within the framework of first-century Judaism" (Zetterholm, p.11)
"Paul lived and died a Jew… Paul is unambiguously Jewish--ethnically, culturally, religiously, morally, and theologically" (Eisenbaum p.
Theis is also the premise of my study.
[[His "conversion" was a call to preach to Gentiles
"ordinary Jew" (what does it means?)
What are the reasons of conflict within the Church and outside the church?
What was the meaning of his teaching for the Jews? the Jews first and then the Gentiles.
The diversity of Judaism allows us to relocate Paul as a Second Temple Judaism in the varieties of groups and theologies of his time. ]]
The opposition between
Obviously Paul was (and remained) a Jew, we also know what kind of Jew he was, as he joined the Jesus movement, more difficult is to understand what king of Christian he was
====Was Paul Christian or Jewish? All started on way to Damascus: The conversion of Paul====
The starting point is clear: Paul was born a Jew and was raised as a Jew.
"The traditional story of Paul looks something like this: Paul was originally a zealous Jew who was persecuting the church, until something utterly miraculous happened: the resurrected Jesus appeared to him. This revelation led to Paul's conversion from Judaism to Christianity, from being a zealous Pharisee to being an unstoppable preacher of the gospel of Jesus Christ. Once converted he realized the futility of Judaism, with its endless demands of the law, and rejected it" (Eisenbaum 2009, p.2).
The conversion was understood as a radical departure from Judaism, to embrace a new faith (religion), Christianity. Paul broke radically with Judaism and ceased observing the Jewish law, and lived in a state of constant opposition to Judaism. Paul the Jew became Paul the Christian.
It was generally conceded whether Paul retained some "Jewish" elements in his thought. After all, in formulating his "new" faith Paul quoted (not the words of some Greek philosophers, but) the very Jewish tradition with which he was presumed to have broken--a passage from the prophet Habbakuk (2:4) and the example of Abraham (Rom 4). The apparent contradiction was overcome by claiming that Paul (and Christianity at large) was in a line of continuity with "classical Judaism", the religion of the ancient prophets. But to recognize the influence of "later" post-biblical traditions on the development of Paul's thought was a completely different matter.
Heinrici denied that "the intellectual and religious forces of late Judaism exercised a dominant influence". Paul, like Jesus, went back with the classical Judaism of the prophets, he did not derived his thought from the Judaism of his time, dominated on the one hand by "fantastic apocalyptic views" and on the other by "soulless Rabbinism."
"Paul has not been able to free himself from the Rabbinic methods of exegesis. He employs it in his arguments, especially in connexion with justification by faith. But the inner essence of his religious conviction was not effected by it" (Wellhausen, Israelitischel ind juedische Geschichte, 1907, 386ff).
Contemporary scholars (even those who maintain the traditional view of separation between Paul and Judaism) seem to be more inclined to recognize the contribution of first-century Judaism to the development of Paul's thought.
Paul did not convert from Judaism to another religion, Christianity.
Scholars began to question that Paul's conversion meant his parting of Judaism.
In Davies' words, "Paul throughout his life might be described as a Pharisee who had accepted Jesus as the Messiah (Davies 1948 [1955, 2nd ed. p.71]).
"From the vantage point of almost two thousand years, perhaps we can conclude that Pul did change his formal affiliation, as it were, from Judaism to what came to be called Christianity. Yet from Paul's own standpoint, he has remained completely within Judaism. From his own vantage point, his "conversion" was not a change of affiliation but a personal experience of God. It was kindred to the sense of personal communion with God which marked the ancient prophets of Israel" (Sandmel 1958, p.63)
Stendahl described Paul's "conversion" as a prophetic call. Compare Jer 1:4-5; Isa 6:1-8; Ezek 1:4--3:15) Krister Stendahl portrait Paul as a person who was "called rather than converted"--called to fulfill a particular mission, to bring knowledge of God to the Gentiles.
The NRP has taken a step forward in denying any separation between Paul and Judaism.
Paul continued to observe the Torah and remained within Judaism. Paul was "as Jewish as any Jews in antiquity" (Zetterholm, p.1); he "was not a Christian" (Eisenbaum, book title).
My position
We should not dramatize Paul's conversion as a rejection of everything that Paul believed, or even Judaism itself.
Conversion was known (see Joseph and Aseneth / Philo). A proselyte was someone who deserted his/her former identity to embrace a "new" identity.
The
We should not trivialized Paul's conversion as it did not cause dramatic changes in his worldview. It was more than a simply call to preach to Gentiles. Paul describe it in term of a "revelation."
"Conversion is a decisive and deliberate change in religious community, even when the convert nominally affirms the same religion" (Segal 1990, p.7).
Paul did not abandon Judaism nor retained only some (or much) of it in embracing Christianity. Paul was and remained a Jew. Paul's conversion dis not change his being a Jew (Jewish identity), it changed his view of Judaism
Paul converted from a variety of Judaism to another. It would be like to a leader of a very conservative Christian group to convert to liberal positions, or vive versa, or an ultra-orthodox Jew becoming a Reform Rabbi.
The recognition that "Paul was a Pharisaic Jew who converted to a new apocalyptic, Jewish sect" (Segal 1900, p.6) does not downplay the radically of the event.
In sum. The Radical New Perspective is correct is its claim that Paul was and remained a Jew but has failed so far to take seriously the implications of Paul's conversions within the diverse world of Second Temple Judaism.
The dichotomy between Paul the Jew and Paul the Christian is misleading. Certainly Paul was not a Christian is the sense it is commonly intended (the member of a "new" religion separated from Judaism). Paul was and remained a Jew. Yet within Judaism he was the member of a group, the Jesus movement, that during Paul's lifetime began to be label of "the Christians" and later developed in what we now know as "Christianity."
The fact that there are elements in Paul that cannot be found in any other Jewish author of the time does not mean that Paul is not Jewish. Using the same criterion we should equally say that Philo is not Jewish or Hillel or Josephus ceased to be Jewish in the moment that they expressed a new idea.
In the diverse world of Second Temple Judaism it was possible to be what today is impossible (both Jewish and Christian).
What was the Jesus Movement About, before Paul
What was Christianity before Paul and or what would it have been without Paul?
Scholars seem to have a clear idea of what Christianity became thanks to, or due to the fault of, Paul--an antinomistic and universalistic movement, but seems to be more vague in defining what Christianity was before Paul.
"Before Paul, Christianity was a typical version of Judaism, without subtractions, but to which was added the belief that Jesus was in some way God's agent, and was destined to return." (Sandmel 1958, p.58).
The Jesus movement was not born as a "new" religion but as a first-century Jewish messianic movement, within the great variety of first-century Jewish movements. Modern scholars have struggled to reconstruct the original message of Jesus and to understand the continuity or discontinuity from the prophet of Nazareth and his movement. From our prospective the problem is irrelevant, Paul was not a disciple of the historical Jesus; as a Jew, he joined the group and the ideology of the early Jesus followers.
What meant for a Jew and a Pharisee like Paul to join the jesus movement? to believe that Jesus was the Messiah and the end of times was imminent. Paul was not not simply a Pharisee who now knew the identity of the Messiah.
All ancient sources indicate that at its inception the Jesus movement was a
Forgiveness of sins.
The way in which the first Christian reinterpreted the experience of Jesus. Whether this was the original message of Jesus or the reinterpretation of his disciples, Jesus was understood as the Messiah Son of Man.
John the Baptist was interpreted as the announcer of the imminent coming of the Kingdom of God
At the center of both the experiences of
In a world dominated by evil John the Baptist are presen
The mission to the Gentiles
The first Christians were ALL Torah-observant Jews.
Discussion of Jesus and the Gentiles.
The Jesus movement was a Jewish messianic sect.
There was no organized plan for converting Gentiles. It came only as the result of a gradual process.
First, some Hellenistic Jews joined the Church. They had already established contact with Gentiles, as Gentiles were welcomed as "God-fearers" in Hellenistic-Jewish communities.
Some Gentile asked to be baptized. Some opposed the practice but the majority accepted it.
What Paul added?
When Paul entered the Christian movement he found a movement whose members were almost all Jews but that already accepted Gentiles. His self-definition as Apostle of Gentiles means an acceleration in the Christian mission toward Gentiles who he relentlessly promoted but not a rejection of his mission to the Jews,
The status of Gentiles within the Church.
Often Paul has been described as Christian who did not accepted Gentiles converts, or wanted to impose on them the entire burden of the Law, a making them "proselytes". That such a party existed is attested in Acts, where it is associated with a group of "Christian Pharisees." (Acts 15:1: certain individuals camas down from Judea and were teaching the brothers, "Unless you are circumcised according to the custom of moses, you cannot be saved."
Such a group appeared however a minority, against both Paul and James.
The council of Jerusalem -- The Jewish-Hellenistic model where jews and Gentile God-fearers coexisted within the same community without their distinction and separation being questioned. After all Judaism was accustomed to such distinctions "by birth", first of all, the separation between priests and non-priests.
The incident at Antioch had to do with the degree of intimacy between Jews and non-Jews
The problem was the relation between Jews and Gentiles in the Christian community.
The distinction between Jews and Gentiles stood in Hellenistic-Jewish Communities. The Jews are the "priests" of humankind.
James and the Church of Jerusalem followed the same model.
For Paul, there is complete equality between Jewish and Christian believers.
The Inconsistent Paul
Raisanen
Before claiming an inconsistency we should try to understand a text in its own terms.
Comes first the chicken or the egg?
A new theology the contrast between Paul and James====
It was because Paul experienced the skepticism of the Jews and the enthusiasm of the Gentiles that he developed his personal understanding of the Christian mission? or it was because Paul a personal theological view that Paul became the apostle to the Gentiles?
The same could me said about James.
Sanders solution might be correct from the psychological point of view but regardless of their motivations James and Paul produced to competitive variants of the Christian system. Once their controversy is relocated within the diverse world of Second Temple Judaism
"Justification by faith"
Since the Reformation the Pauline "justification by faith has been interpreted as "salvation by faith."
But "justification" and "salvation" are two completely different concepts. At anytime that Paul talks of the last judgment as based on "faith in Jesus".
"We know that a person is justified not by the works of the law but through faith in Jesus Christ" (Gal 2:16).
By radicalizing some tendency present in Second temple Judaism, Paul describes the situation of sinners as those of "slaves"
Paul addresses a typical Second Temple problem, that of the origin and strength of evil.
Justification of sins is a form of emancipation from slavery.
James is in line with the Testaments of Twelve Patriarchs. --Under temptation.
==
=
All gentiles are "sinners", a Jew is not "Gentile sinner", but there are also "Jewish sinners"
All sinners are "slaves of sin"
The "two ways of salvations" does not perfectly fit the Pauline scheme. Jesus is the forgiver of sins, the redeemer of slaves (sinners), Jews and Gentiles
While Paul maintained that there a basic distinction between Jews and Gentiles. (The NRP is correct on this point). Contrary to what traditional scholarship claims Paul reiterated and reinforced such a distinction against these Gentile Christians that wanted to see it abolished. "What is the superiority of Jews? Great" The covenant is irrevoca
A Jewish sinner receive "justification by faith in Christ" exactly as a Gentile sinner. While there is a profound distinction between Jews and Gentiles, Paul does see distinction between a Gentile sinner and a Jewish sinner: both of them are equally justified by faith in Jesus.
=A "third race" ?
See A Former Jew: Paul and the Dialectics of Race (2009 Sechrest), book Sechrest describes Paul as someone who was born a Jew, but who later saw himself as a member of a different race.
Eschatological situation. In the community there is "no male
Paul did not abolish this categories in "this world."
These categories belong to this world. In the world to come there will be no longer "male and female" (Jesus would have said "we will be like angels") slave and owners and Jews and Gentiles (see the ending of Dream visions).
If the Christian community is a "third race", is only in an apocalyptic and mystical perspective. In the moment of worship such distinction does not count (table-fellowship). but in the everyday life until the end of the world such a distinction remains valid.
=
Gli ebrei in Italia
L'Italia e' un paese meraviglioso, la cui cultura e' il risultato di contributi diversi. Siamo sempre stati un paese multietnico e multireligioso. Non e' una novità degli ultimi decenni. Tra le componenti culturali e religiose, quella ebraica ha un ruolo di primo piano per la sua antichità e l'ampiezza del suo impatto.
Gli ebrei vivono in Italia dai tempi di Giulio Cesare. La comunità ebraica di Roma e' una delle più antiche del mondo. Il quartiere ebraico di Roma attorno al Portico di Ottavia ha il primato di essere uno quartiere ebraici con la più antica presenza ininterrotta di ebrei al mondo.
La vita ebraica prima dell'Unita' italiana
Fino al Medio Evo, gli ebrei vivevano in prevalenza nel sud Italia (Puglia, Calabria, Sicilia), ma nel 1492, la cacciata degli ebrei dalla Spagna significa anche la cacciata degli ebrei dall'Italia meridionale (allora sotto il dominio spagnolo). Da allora la maggioranza degli ebrei italiani vive nel centro-nord Italia, spesso confinati in quartieri chiusi (i ghetti). Nonostante, queste limitazioni la vita ebraica in Italia e' segnata solo occasionalmente da eventi di persecuzione (il più tragico dei quali sono lo sterminio degli ebrei di Trento nel 1475, falsamente accusati di omicidio rituale di un bambino cristiano, o l'eccidio a Siena del 1799, innescato da moti antinapoleonici). Per la maggioranza degli ebrei l'Italia e' una terra tollerante e ospitale. In alcune realtà come a Venezia soprattutto o a Mantova o Ferrara o Livorno le comunità ebraiche danno un contributo importantissimo e originale all'economia e alla cultura delle citta' che li ospitano. Nella fantasiosa etimologia ebraica, Italia e' "isola della rugiada divina" ( אי טל יה ).
Il Risorgimento e l'Emancipazione
Nell'Ottocento gli ebrei partecipano con grande entusiasmo al Risorgimento italiano. Appoggiano Mazzini e Garibaldi, sostengono gli sforzi del Piemonte per l'Unita' italiana, contribuiscono all'organizzazione dello sbarco dei Mille. Poiche' la maggior parte dei cattolici si auto-escludono dal processo risorgimentale, gli ebrei entrano in massa nell'amministrazione del nuovo regno. Sono primi ministri (Alessandro Fortis, Luigi Luzzatti, Sydney Sonnino), sindaci (Ernesto Nathan a Roma), prefetti, generali. Si considerano tra i più ferventi patrioti. L'Italia li ricambia garantendo loro piena cittadinanza ed eguali diritti. Vengono costruite le grandi sinagoghe monumentali di Torino, Firenze, e Roma. Fortissima e' la presenza ebraica nella cultura italiana. Basti pensare allo scrittore Italo Svevo, al pittore Amedeo Modigliani, al compositore Mario Castelnuovo-Tedesco. La vitalita' dell'ebraismo italiano si estende ben oltre i confini nazionali: In America il rabbino livornese Sabato Morais fonda il Jewish Theological Seminary.
Fascismo e anti-fascismo
Di fronte al fascismo gli ebrei si comportano come i loro concittadini. Gli ebrei sono ferventi nazionalisti (adorano Gabriele D'Annunzio), partecipano in 5000 alla prima guerra mondiale (meta' sono ufficali; i caduti sono 420 i decorati 700). Nel dopoguerra molti ebrei aderiscono con entusiasmo al regime fascista (Aldo Finzi, Margherita Sarfatti, Guido Jung, Renzo Ravenna). Molti altri si schierano all'opposizione del regime (Claudio Treves, Vittorio Polacco, Lodovico Mortara, Eucardio Momigliano, Pio Donati, fino ai Fratelli Rosselli). La maggior parte degli ebrei si adegua al pari del resto della popolazione italiana. A differenza del periodo risorgimentale dove l'essere ebreo e' sinonimo di liberale e patriota, fino alla meta' degli anni '30 l'identita' ebraica non gioca un ruolo decisivo nella scelta di campo tra fascismo e antifascismo. L'antisemitismo non entra che marginalmente nel dibattito politico.
I Patti Lateranensi del 1929
La situazione comincia a cambiare con il concordato del 1929. La Chiesa cattolica spinge per il riconoscimento dell'Italia come stato cattolico, che ufficialmente spinga ai margini le altre religioni come culti ammessi. Il regime fascista ha bisogno dell'appoggio del Vaticano. Il concordato segna una prima marginalizzazione degli ebrei italiani che fino ad allora avevano vissuto nel nuovo stato una situazione di assoluta eguaglianza e parità di diritti. E segna una prima grave incrinatura nei rapporti tra ebrei e regime. Gli ebrei si sentono traditi e trattati come merce di scambio. La successiva Legge Falco (1930) che regola i rapporti tra Stato Fascista ed ebrei italiani viene tuttavia accolto favorevolmente e sembra segnata un rasserenamento nei rapporti con il regime. Come segno di buona volonta' il regime autorizza la costruzione della Sinagoga di Genova nel 1935.
Le leggi razziali del 1937
La marginalizzazione religiosa diventa marginalizzazione sociale con le Leggi Razziali del 1937. Esse vengono purtroppo accettate dall'opinione pubblica con indifferenza. Anche la Chiesa cattolica italiana le condivide come una rivincita contro il ruolo avuto dagli ebrei nel Risorgimento. Si protesta solo per l'inclusione degli ebrei battezzati tra i discriminati, ma si applaude alla misura che sancisce la raggiunta identificazione tra lo stato cattolico-fascista e l'identita' dei suoi cittadini. L'impatto delle Leggi razziali e' devastante, in quanto significarono l'espulsione di migliaia e migliaia di cittadini dall'insegnamento, dalla pubblica amministrazione e dall'esercito. L'universita' italiana perse piu' di 300 studiosi e ricercatori di fama mondiale (scienziati, storici, economisti, compositori). Ed eppure tutto questo impallidisce in confronto al trauma personale delle migliaia di bambini/e e ragazzi/e italiani che da un giorno all'altro scoprono di essere diversi e indesiderati nel loro stsso paese.
L'emigrazione
Con la perdita del lavoro moltissimi sono gli ebrei che lasciano l'Italia, o cercano di farlo, ma e' molto difficile ottener eil visto d'espatrio e pochi sono i paesi disposti all'accoglienza. Le mete preferite sono L'Inghilterra e la Francia in Europa, i paesi del Sud America e gli Stati Uniti. Tra loro ricordiamo: Emilio Segrè, Bruno Rossi, Ugo Lombroso, Giorgio Levi Della Vida, Mario Castelnuovo-Tedesco, Camillo Artom, Ugo Fano, Roberto Fano, Salvatore Luria, Piero Foà, Luigi Jacchia, Guido Fubini, Massimo Calabresi, Franco Modigliani. Altri troveranno rifugio in Gran Bretagna (Arnaldo Momigliano, Uberto Limentani, Guido Pontecorvo); in Palestina (Umberto Cassuto, Giulio Racah, Gad Luzzati); o in Sud America (Carlo Foà, Amedeo Herlitzka, Beppo Levi). Con loro lasceranno l'Italia anche Enrico Fermi e Luigi Bogliolo, le cui mogli erano ebree. C'e' poco tempo. Lo scoppio della guerra e' ormai alle porte.
I campi di internamento degli ebrei "stranieri" (1940-43)
Nei primi anni del conflitto l'Italia non partecipa alle deportazioni e allo sterminio che già si scatena sul fronte orientale e in Francia. Accoglie anzi numerosi rifugiati, specie dai Balcani. Si formano dei campi di raccolta e internamento in ogni provincia per questi ebrei stranieri, persino un'orfanotrofio per bambini a Nonantola. I maggiori centri sono nell'Italia del Sud, tradizionale terra di confino per i dissidenti dal fascismo (Ferramonti, Campagna [vicino a Salerno]). Le condizioni di vita sono difficili per questi rifugiati ma a loro e' concessa una certa libertà. Si forma addirittura con il consenso del Regime una associazione ebraica, la DELASEM, che provvede assistenza materiale e spirituale ai rifugiati.
Le Deportazioni (8 sett. 1943 - 25 aprile 1945)
Il rastrellamento del Ghetto di Roma (16 ottobre 1943)
Dopo la breve illusione seguente alla caduta del fascismo il 25 luglio 1943, tutto cambia con l'8 settembre 1943, con l'occupazione tedesca e la costituzione della Repubblica Sociale. A questo punto il territorio italiano entra a far parte della soluzione finale. Per tutti gli ebrei in Italia comincia mesi e mesi di clandestinità. La Repubblica Sociale abbandona rapidamente il sud Italia e si consolida sul fronte di Cassino. Questo significa che i due più grandi campi di internamento degli ebrei stranieri sono nel giro di poche settimane liberati dagli Alleati. La maggior parte degli ebrei italiani pero' si trova al centro nord. La situazione si fa subito drammatica. Il 16 ottobre 1943 più' di mille ebrei cadono nel Rastrellamento del Ghetto di Roma e vengono inviati a morire ad Auschwitz. Su 1023 persone ne ritorneranno solo 16. Analoghe retate si svolgono a Firenze, Venezia, Bologna, Trieste e in Piemonte.
Gli eccidi in Italia
16 ebrei vengono uccisi a Meina sul Lago Maggiore nel settembre 1943. I famigliari Einstein vengono trucidati in Toscana. I tedeschi comunque evitano accuratamente di compiere eccidi in loco (non ci saranno campi di sterminio in Italia, se non la Risiera di San Sabba a Trieste, che pero' funziona prevalentemente come campo di transito e di sterminio per prigionieri politici), assieme al campo di Fossoli, vicino a Carpi, Modena, e a quello di Bolzano, che sono la principale centrale di smistamento per le deportazioni, tutte indirizzate al campo di sterminio di Auschwitz. L'unico eccidio di ebrei e' la strage delle Fosse Ardeatine (24 marzo 1944), ma viene effettuata all'interno di una rappresaglia politica contro la Resistenza. Almeno 75 delle 335 vittime furono ebrei; gli ebrei (anche anziani e bambini) vi vengono aggiunti per far numero.
Le deportazioni ad Auschwitz
Sono circa 8,000 gli ebrei italiana deportati a Auschwitz. Gli ebrei italiani vi sono condotti a morire, molti muoiono gia' all'arresto e durante il trasporto, la maggior parte il giorno stesso del loro arrivo. Tra le vittime ci sono personaggi illustri come i rabbini Nathan Cassuto e Riccardo Pacifici, il chimico Leone Maurizio Padoa, l'epigrafista Mario Segre, i musicisti Leone Sinigaglia e Mario Finzi, l'economista Riccardo Dalla Volta, il pugile Leone Afrati, il dirigente sportivo Raffaele Jaffe, e tanti altri. Ma ad essere deportate sono intere famiglie (anziani, neonati, donne, bambini). I sopravvissuti sono solo un piccolissima minoranza, degli 800 bambini ne torneranno solo 25. Si salveranno solo alcuni giovani uomini e donne che per circostanze fortunose riusciranno a sopravvivere le terribili condizioni di vita del campo.
L'opera della DELASEM
La DELASEM entra in clandestinità, gestita ora prevalentemente da non-ebrei. la centrale operativa e' a Genova, retta dal Cardinale Boetto, con sezioni in tutto il centro-nord. A Genova arrivano gli aiuti clandestini dalla Svizzera tramite il Nunzio apostolico e da li' sono distribuiti in tutto il centro Nord. Tra coloro che operano nella DELASEM si distinguono l'arcivescovo di Firenze, il card. Dalla Costa, l'arcivescovo di Assisi, numerosi sacerdoti, suore , istituti religiosi, semplici cittadini, come il ciclista Gino Bartali. L'organizzazione aiuta numerosi ebrei a rifugiarsi in Svizzera, tra di essi anche i bambini dell'orfanotrofio di Nonantola.
Il dopoguerra
I primi racconti dei perseguitati
Dopo la guerra compaiono i primi resoconti degli ex-deportati (Sofia Schafranov, Lazzaro Levi, Bruno Piazza nel 1945, Giuliana Fiorentino Tedeschi, Alba Valech Capozzi, Frida Misul e Luciana Nissim Momigliano nel 1946, e infine nel 1947 Primo Levi e Liana Millu). Quanto vi e' raccontato appare così incredibile che l'opinione pubblica vi presta poca attenzione. La vita ebraica riprende il suo ritmo. In Italia "solo" il 18% degli ebrei e' perito, la presenza ebraica non e' cancellata. Nella coscienza collettiva l'Olocausto rimane legato all'occupazione nazista, insieme ai bombardamenti, alle rappresaglie, alla prigionia, ai campi di lavoro. Tutto lo sforzo collettivo si concentra sulla ricostruzione del paese. Le leggi razziali sono abolite, la costituzione include il Concordato ma stempera gli aspetti più discriminatori delle Intese. La fine del pontificato di Pio XII segna anche l'inizio del disgelo tra ebrei e cattolici in Italia. Ad essere eletti sono Papi, sia Giovanni XXIII che Paolo VI, i quali durante la Guerra si erano adoperati in prima persona contro l'Olocausto. Il Concilio Vaticano II approva nel 1965 una dichiarazione (la Nostra Aetate) di ferma condanna dell'antisemitismo.
La rinascita della vita ebraica in Italia
Gli ebrei italiani continuano a contribuire alla vita culturale italiana nel dopoguerra, "anonimamente" come hanno sempre fatto: Tra di loro ci sono scrittori come Giorgio Bassani, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Alberto Moravia e Elsa Morante, attori come Arnoldo Foà, Vittorio Gassman e Franca Valeri e intellettuali come Umberto Terracini, Vittorio Foa, Carlo Levi, Giacomo Debenedetti, Leo Valiani, e Bruno Zevi, sacerdoti cattolici come don Lorenzo Milani. Altri ebrei italiani trovano fama e riconoscimento internazionali, a cominciare dai premi Nobel Emilio Segrè (1959), Salvatore Luria (1969), Franco Modigliani (1985) e Rita Levi-Montalcini (1986). Dal punto di vista religioso si distingue tra tutti in Italia la figura di Elio Toaff, rabbino-capo di Roma dal 1953 al 2002.
La rinascita di interesse negli anni '90 e il Giorno della Memoria
Il lungo silenzio si interrompe con due eventi significativi, la visita di papa Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma nel 1986, che per molti italiani segna la riscoperta della presenza ebraica in Italia, e quindi lo straordinario successo del film La vita e' bella di Benigni nel 1997. che riaccende l'interesse sulle tematiche dell'Olocausto in italia.
L'Istituzione del Giorno della Memoria nel 2000 (assieme alla Giornata della cultura ebraica in settembre) hanno largamente contribuito ad una maggiore consapevolezza della storia degli ebrei in Italia.
Gospel of John
The paper does a good job in explaining why both Johannine scholars and Second Temple specialists have seldom connected John's Christology with Second Temple Judaism. The lack of historicity of the Gospel, its close relationship with the Johannine community, and its distance from the earliest forms of Christology should not viewed as obstacles to a rediscovery of the Jewishness of John. Jewish messianism does not simply predate Jesus but accompanies and follows the composition of the Gospels. For us it would be sufficient to demonstrate that the Gospel of John developed its Christology in the context of, and in conversation with, (other) first-century Jewish messianic expectations. Boyarin says: "Jews came to belief Jesus was God, because they already believed that the Messiah would be a divine redeemer..." I would say: "Some Jews came to believe Jesus was God, because some of them already believed that the Messiah would be a divine redeemer...". We cannot I think that seeing John's christology as a form (or development) of Jewish messianism does not imply to deny its originality. (John's Cristology is not Jewish only if it copied something that already existed in early Judaism; it is enough to show that John's Christology emerged in the context of Jewish messianism as a variant The problemof the lack of historicity of the Gospel, its relation with the Johannine community and its distance from the earliest forms of Christology. are all true, but are not an obstacle The debate on Jewish messianism does not simply predate the Gospels but accompanies and followed the Gospels. For us It is sufficient to say that John developed its Christology in the context of, and in conversation with, (other) first-century Jewish messianic expectations.
I would accept Baoyarin point of view with only a caveat: he says: "Jews came to belief Jesus was God, because they already believed that the Messiah would be a divine redeemer..." I agree but only with a small change: I would say: Some jews came to belief... because some of them already believed". We cannot talk of a single Jewish messianism and we should talk of John's Cristology as one of the many possible forms of Jwsih messianism. As Ben said in conclusion: "Some Jewish text present a high messianism that is remarkable similar to the Christology of John" (I would emphasize: similar not identical). The Son-of-Man theology was already a form of "high messianism". In my paper I would argue that John's Cristilogy is the only form of Jewish messianism to claim that Jesus the Messiah was uncreated. Provide that the Gosepl of Jogn give us its own version of Jewish messianism. Does the Gospel of John testifies to the existence of other forms of Jewish messianism.
STudies on the Gospel of John do not see it a connection to Jewish messianism
Studies on Jewish messianism genrally do not take John into consideration.
Early Judaism scholars view the Gospel of John's Chritostology as a development of early Christology, which is turn viewed as a development of Jewish messianic expectation ... The Gospel of John's Christology is understood to be removes not merely from Jewish messianic beliefs but from messianic belief in early Christianity.
--
I think that seeing John's christology as a form (or development) of Jewish messianism does not imply to deny its originality. (John's Cristology is not Jewish only if it copied something that already existed in early Judaism; it is enough to show that John's Christology emerged in the context of Jewish messianism as a variant
The problemof the lack of historicity of the Gospel, its relation with the Johannine community and its distance from the earliest forms of Christology. are all true, but are not an obstacle
The debate on Jewish messianism does not simply predate the Gospels but accompanies and followed the Gospels. For us It is sufficient to say that John developed its Christology in the context of, and in conversation with, (other) first-century Jewish messianic expectations.
I would accept Baoyarin point of view with only a caveat: he says: "Jews came to belief Jesus was God, because they already believed that the Messiah would be a divine redeemer..." I agree but only with a small change: I would say: Some jews came to belief... because some of them already believed".
We cannot talk of a single Jewish messianism and we should talk of John's Cristology as one of the many possible forms of Jwsih messianism.
As Ben said in conclusion: "Some Jewish text present a high messianism that is remarkable similar to the Christology of John" (I would emphasize: similar not identical).
The Son-of-Man theology was already a form of "high messianism".
In my paper I would argue that John's Cristilogy is the only form of Jewish messianism to claim that Jesus the Messiah was uncreated. Provide that the Gosepl of Jogn give us its own version of Jewish messianism. Does the Gospel of John testifies to the existence of other forms of Jewish messianism.
@2018
Chapter 1 -- Introduction
[Paul the Hater]
In an age of resurgent religious intolerance, Jews, Christians and Muslims are challenged to prove that monotheistic religions are not intrinsically intolerant and exclusive, but indeed capable to inspire and unite people of good will in peace and coexistence. Centuries of conflicts show that this has not always been the case. Made fully aware by their own experience, the children of Abraham are compelled to look at themselves and face the “evil within,” the roots of violence and hatred hidden in their own religious traditions and beliefs.
It is only a matter of intellectual honesty to admit that in the road to interfaith dialog and mutual respect, Paul of Tarsus appears today more an obstacle than a facilitator. Born a Jew, we are told that he “became” a Christian, making manifest with his own conversion and teaching that all the unbelievers are doomed unless they also convert and submit themselves to the Christian Messiah. Condemned by their own "perfidy", by their guilty lack of faith, the Jewish people, who once were "the chosen people of God", have been deprived of all dignity, and pushed to damnation like all gentile unbelievers or believers in another religions, if not through the individual experience of conversion and rejection of their own religious identity.
A message of inclusiveness generated an even more insurmountable wall of intolerance between believers and unbelievers. Everybody (Jew and Gentile, man and woman, freeperson and slave) is called and welcomed, but there is only one path to salvation in Christ for all humankind.
Should we than accept the paradox of a message of grace that generated hatred, a message of inclusion that generated exclusion? Or should we deny Paul, and expose him as a champion of intolerance--the "genius of hatred" as Friedrich Nietzsche denounced him[4], or to put it in a more colorful, contemporaneous vocabulary, “a racist, chauvinist jerk” ? Or should we just forget Paul and resign ourselves to take a different path in spite of him?
<<He preached Even more paradoxical is how the Christian tradition did not see any contradiction between praising Paul as the advocate of Christian universalism vs. Jewish particularism, and making him the major proponent of Christian exclusiveness. Everybody (Jews and Gentile, men and women, freepeople and slaves) are called and welcomed, but there is only one way of salvation in Christ for all humankind.
<This wa already notice by Sandmel: “Paul felt that his version of Judaism was for all humankind, yet Paul was no thorough-going universalist. His universalism did lead him to deny any difference between Jew and Greek, so long on both are in Christ” (Sandmel, 21).
A message of inclusiveness generated an even more insurmountable wall of intolerance between believers and unbelievers. Condemned by their own "perfidy", by their guilty absence of faith, the Jewish people, who once were "the chosen people of God", came to be deprived of all dignity, and pushed to damnation like all gentile unbelievers or believers in another religions, if not through the individual experience of conversion and rejection of their own cultural, religious and ethnic identity.]]
<<Are monotheistic religions intrinsically and mutually intolerant and exclusive? The experience and teaching of Paul appear more an obstacle than a seem of much help. who was “born a Jew” and “became a Christian” Isn’t Paul’s experience of “conversion” and his doctrine of salvation insurmountable obstacles in the road to interfaith dialog and respect? Did Paul really believe that faith in Christ was the only path to salvation and all the unbelievers are condemned to perdition unless they convert and submit themselves to the Christian Messiah? Is this idea not only morally untenable, but also historically incorrect?>>
[Paul and Judaism]
In the context of first-century Judaism, Paul's figure appears to be among the most enigmatic and one of the hardest to grasp. A halo of mystery, if not the curse of an ancient taboo, still seems to hover around him and make a serene understanding of his experience difficult.
Paul weighs the cumbersome reputation that indicates him as the first great systematic theologian of nascent Christianity, but also weighs the suspicion - if not the accusation - of having contributed decisively to the separation between Christianity and Judaism and to have thrown the basis of a poisonous polemic against the Torah and the people of Israel, a harbinger of prejudice, intolerance and discrimination, up to the Holocaust tragedy.
The rediscovery of the Jewishness of Jesus, which since the end of the nineteenth century has engaged Jewish and Christian scholars in a joint effort, has contributed to further digging the furrow. The more the figure of the Master proves to be compatible with the spirit of the Judaism of his time, the more his most famous disciple appears to be the man of rupture, when not even the true founder of Christianity as a religion distinct from Judaism. Already in the 10th century, the Karaite leader Yaqub al Qirqasini opposed Jesus
to Paul--the unjustly persecuted Jewish teacher to his unfaithful disciple, seen as the authentic creator of Christianity.
It can’t be easily overlooked that for centuries Paul has been praised by Christians, and blamed by Jews, for separating Christianity from Judaism. “None has produced more animosity between Jews and Christians… Paul has long been regarded as the source for Christian hatred of Jews and Judaism … [He] turned his back on his former life as a Jew and became the spokesman for early Christian anti-Judaism” (Gager 3-4). Paul appeared to Christians as the convert who unmasked and denounced the “weakness” (if not the wickedness) of Judaism, and to Jews as the traitor who made a mockery of the faith of his ancestors (Zetterholm 2009).
(a) In order to affirm the grace of Christianity, Paul denounced Judaism as a legalistic religion
(b) In order to affirm his universalistic project, Paul had to fight against Jewish particularism
"Christianity began with one tremendous problem. Clearly the message of Christianity was meant for all men… But the fact remained that Christianity was cradled in Judaism; and, humanly speaking, no message which was meant for all the world could even have had a more unfortunate cradle. The Jews were involved in a double hatred--the world hated them and they hated the world" (Barclay 1958, p.9).
These shameful words were written in 1958 by one of the most respected Christian theologians of the time. A Britishman
Yet there's something not quite right about this. Among the authors of early Christianity, Paul is the one who most strongly claims his Jewishness ("I too am an Israelite, of the descendants of Abraham, of the tribe of Benjamin" - Rom 11: 1) defends the irrevocability of the divine promises ( "God has rejected his people? Nothing at all!", Rom 11: 1) and with more readiness reiterates the "privileges" of Israel in the face of the zeal of the new converts among the Gentiles ("You, oleastro [...] boast against the branches! "- Rom 11: 17-18).
On the other hand, Judaism hardly fits the features of "legalism" and "hatred against the world" that scholars like Weber, Schurer, and Bousset identified as the major features of Second Temple (and contemporary) Judaism.
==
Specialists of Rabbinic Judaism like Claude Joseph Montefiore, Salomon Schecter and George Foot Moore repeated in their work that this was not the case, but their work and little impact. In 1921 Moore published an article openly denouncing the bias (and antisemitism) of many of his colleagues.[5]
The war, the Holocaust
Thanks to the works of Krister Stendhal, E.P. Sanders, James D.G. Dunn and others, the "New Perspective" has begun since the '70s to question that radical opposition between grace and law that made Paul the implacable critic of Jewish "legalism", recognizing in this opposition not the authentic voice of the first century, but the anachronistic reflection of the controversy that divided Christianity with the Reformation in the sixteenth century. With the collapse of the "Lutheran Paul" the myth of the supposed stainless coherence of the Pauline thought has also fallen. Scholars and theologians began to insist rather on the paradoxical features of Pauline theology, its non-systematic nature, its being linked to contingent problems and situations, and therefore its substantial inconsistency. Paul was not a theologian or a systematic thinker. Paul was a pastor, dealing with communities of flesh-and-blood people and with extremely real problems. For Paul - as affirmed with effective conciseness by E. P. Sanders - the solution precedes the problem. He saw the Gentiles approaching with Christianity faith and enthusiasm; his theological effort was to try to justify the fact in retrospect. Pauline reflection would then not be the theoretical premise for the entry of the Gentiles into the Christian community, but the attempt, even a bit confused and theologically not entirely coherent, to justify the event in which he recognized the merciful action of God.
The New Perspective has also tried hard to get rid of the most derogatory aspects of the traditional (Lutheran) reading of Paul (claiming that Judaism also should be regarded as a “respectable” religion based on grace). It has effectively rediscovered the Jewish structure of Paul's thought, emphasizing its pragmatic and pastoral aspects against its presumed theological consistency. It has not however challenged the view of Paul as the critic of Judaism and the advocate of a new supersessionist model of relations between God and humankind—God’s grace “in Christ” superseded the Jewish covenant for both Jews and gentiles by creating a third separate “race.” Paul “explicitly denies that the Jewish covenant can be effective for salvation, thus consciously denying the basis of Judaism … Paul polemicizes … against the prior fundamentals of Judaism: the election, the covenant, and the law” (Sanders, 551f).
Another line of thought was pursued by scholars like Krietser Stendahl (1963), Lloyd Gaston (1977), Stanley Stowers (1994), John Lodge (1996), John G. Gager (2000).
Paul was and remained a Jew
Two paths to salvation: “one, God’s unshakable commitment to Israel and to the holiness of the Law (=Judaism), and two, the redemption of the Gentiles through Jesus Christ. (Gager, 152).
Mark Nanos, A new paradigm is emerging today with the “Paul within Judaism” Perspective—a paradigm that aims to fully rediscover the Jewishness of Paul. Paradoxically, “Paul was not a Christian,”2 since Christianity, at the time of Paul, was nothing else than a Jewish messianic movement, and therefore, Paul should be regarded as nothing other than a Second Temple Jew. What else should he have been? Paul was born a Jew, of Jewish parents, was circumcised, and nothing in his work supports (or even suggests) the idea that he became (or regarded himself as) an apostate.3 On the contrary, Paul was a member of the early Jesus movement, and with strength and unmistakable clarity, proudly claimed his Jewishness, declaring that God also did not reject God’s covenant with the chosen people: “Has God rejected his people? By no means! I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin” (Rom. 11:1; cf. Phil. 3:5).
MY VIEW
I have never been content with the traditional “Lutheran” approach. In 1991 in a chapter of my book Middle Judaism devoted to Paul and James, I wrote: “No New Testament writing is more or less Jewish for the simple reason that they are all Jewish… Even Paul belongs to Judaism: the ideas he expresses (including those that appear most extraneous, such as the theories of original sin and justification by faith), are an integral part of the Jewish cultural and religious patrimony of the first century… Of course, there is an obvious ad extra polemic in the New Testament, but this itself is part of the internal debate within Judaism at the time…” (Boccaccini, Middle Judaism, 1991, p.215).
PAUL THE JEW AND PAUL THE CHRISTIAN
Obviously my sympathies are all for the Paul-within-Judaism perspective. Paul was and remained a Jew. He was and remained all his life an observant Jew. And yet I am not persuaded that Paul was just an ordinary Jew’ And yet I am not completely persuaded by the “two ways” The Jesus movement was born within Judaism and the many Jews who joined it (including Paul) did it for personal reasons that where independent from the inclusion of Gentiles. I am convinced of separating Jesus and Paul from their movement I am not convinced that the solution be in a simple call to forget Luther and the Christian Paul, as if they were never existed
Obviously There have been something in their teaching that would lead to future developments. If Paul was a Jew, we should neither try to connect his ideas to later understandings of Judaism, nor isolate the from the contemporary conversation thare must be something that connects Paul to “Jesus was not the first founder of Christianity and Paul was not the second” (Gager, vii) Paul was not a Christian (Eisenbaum).
How is it possible to claim that “Christianity” has nothing to do with Jesus and Paul. There must have been something in Jesus and Paul must have laid the foundations for How is it possible to reconcile Paul the Jew with Paul the Christian.
DIVERSITY IN SECOND TEMPLE JUDAISM
Se oggi possiamo parlare del Paolo ebreo e' perche' la nostra comprensione dell’ebraismo del primo secolo è in questi ultimi decenni profondamente cambiata. I manoscritti del Mar Morto e i cosiddetti apocrifi e pseudepigrafi dell’Antico Testamento ci hanno restituito l’immagine di un’età creativa e dinamica e di un ambiente vitale e pluralistico, nel quale convivevano espressioni tra loro anche profondamente diverse dello stesso ebraismo, incluso il nascente movimento cristiano 10. Due elementi sono ormai acquisiti alla ricerca contemporanea e costituiscono il punto di partenza di ogni riflessione ulteriore:
(1) Il giudaismo del Secondo Tempio era diviso in correnti di pensiero in dialogo e competizione tra loro.
Nel secondo Tempio - come testimonia Giuseppe - esistevano tre distinte tendenze dottrinali: i sadducei, i farisei (con l'ala radicale e militante degli zeloti) e gli esseni. A queste correnti dovremmo aggiungere anche il giudaismo ellenistico (di cui Giuseppe Flavio non tratta concentrandosi sull'ambiente palestinese) e il movemento gesuano la cui distintivita' certo nessuno vorra' negare all'interno del giudaismo del Secondo Tempio in nome di un rigido monolitismo.
Certamente assieme alla visione monolitica dobbiamo evitare l'estremo opposto, come giustamente rileva Pitta di "considerare ogni variazione cristologica e comportamentale nelle prime comunita' cristiane come forma autonoma di giudaismo e di cristianesimo" (p.24). In media stat virtus dicevano gli antichi e cosi' e' vero anche in questo campo. Se non si puo' negare la diversita' non si puo' nemmeno arrivare arrivare all'assurdo che esista una forma diversa di giudaismo o di cristianesimo per ciascuno dei testi pervenutivi o dei leader conosciuti o di ogni piu' piccola sfumatura di pensiero. Esistono tuttavia delle grandi famiglie all'interno di ogni religione che hanno portato e portano avanti visioni diverse delle stessa religione.
L'ovvia realtà' e' davanti agli occhi di tutti. Non c'e' ne' mai c'e' stato un unico momento nella storia dell'ebraismo o del cristianesimo in cui essi siano stati delle religioni monolitiche. Oggi parliamo di giudaismo ortodosso, conservativo e riformato e di cristianesimi ortodosso, cattolico e protestante ma anche prima che emergessero queste moderne divisioni esistevano altre divisioni e cosi' lungo tutto il corso della storia. Ieri come oggi.
Personalmente trovo un po' oziosa la discussione semantica sull'uso del singolare (varieta' di giudaismo e di cristianesimo) o del plurale (giudaismi o cristianesimi). Che se li chiami "giudaismi" o “varietà diverse di giudaismo" la sostanza non cambia. Al tempo d'oggi come al tempo di Gesu' non esisteva un solo modo di intendere il giudaismo ma modi diverse tra loro in dialogo o in competizione (o giudaismi). E quando il movimento di Gesu; emerse le stesse divisioni ben presto si rifletterono all'interno della nuova sette producendo diverse forme di cristianesimo (o cristianesimi)
E’ questa la ragione per la quale molti studiosi usano oggi comunemente il plurale, "giudaismi", a indicare la grande varietà di pensiero del giudaismo nel primo secolo e le varie movimenti religiosi nel quali l'ebraismo del tempo si divideva. Anche chi come Sacchi o Pitta o Collins conserva remore semantiche sull'uso del plurale applicato al termine "giudaismo", non nega la sostanza del problema, che cioè la religione ebraica del tempo fosse estremamente variegata. E' questa un'idea oggi universalmente accettata nel mondo degli studi. Che si parli di "giudaismi" o di "correnti giudaiche" in discorso non cambia. Comunque la si esprimi, siamo oggi messi in guardia da ogni visione monolitica costruita sulle più tardive fonti rabbiniche11.
(2) Il movimento di gesu e' parte integrante del pluralismo giudaico del Second Tempio.
Una volta liberatici dai pregiudizi interpretativi e teologici del passato, ci troviamo di fronte ad alcune scoperte sorprendenti. Ad esempio, molte di quelle che eravamo abituati a considerare idee “tipicamente” paoline e addirittura “anti-giudaiche” (quali la giustificazione per fede, il peccato originalee la drammatica percezione dell’insufficienza dell’obbedienza alle norme della Torah ai fini della salvezza) si sono rivelate essere idee diffuseanche in altri ambienti e gruppi giudaici del tempo, spesso con alle spalle una storia secolare.
Ma anche di fronte alle idee "nuove" elaborate all'interno del nascente movimento cristiano sarebbe
metodologicamente scorretto considerare come non-giudaica (o non più giudaica) ogni idea che non abbia un parallelo con altri autori o testi giudaici del tempo. Con questo criterio nessuno pensatore originale ebraico sarebbe più ebreo nel momento in cui elabora nuove idee rispetto alla tradizione ricevuta. Non lo sarebbe Filone, Giuseppe Flavio o Hillel. Lo stesso vale per Gesu o Paolo. Il fatto stesso che abbiano elaborato idee originali le rende certo distintive del nuovo movimento ma non per questo meno giudaiche. Va rigettato ogni tentativo di applicare una diversa misura nell'interpretazione delle origini cristiane rispetto alle altre forme di giudaismo del tempo.
If we can claim that Philo was a Jew and at the same time represented of a distinctive form of Judaism, the same is possible with Paul.
Three Caveats about the Jewishness of Paul
Since my remarks focus on the Jewishness of Paul, it is important to clarify, as a premise, what we should not imply by that, in order to avoid some common misunderstandings.
1. In order to reclaim the Jewishness of Paul, we do not have to prove that he was a Jew like everybody else, or that he was not an original thinker. It is important not to apply to Paul a different standard than to any other Jew of his time. To claim that finding any idea in Paul that is unparalleled in other Jewish authors makes Paul “non-Jewish” would lead to the paradox that no original thinker of Second Temple Judaism should be considered “Jewish”—certainly not Philo or Josephus or Hillel or the Teacher of Righteousness, all of whom also formulated “original” answers to the common questions of their age. Why should only Paul be considered “non-Jewish” or “no longer Jewish” simply because he developed some original thinking? The very notion of making a distinction within Paul between his Jewish and “non-Jewish” (or “Christian”) ideas does not make any sense. Paul was Jewish in his “traditional” ideas and remained such even in his “originality.” Paul was a Jewish thinker and all his ideas (even the most nonconformist) were Jewish.
2. In order to reclaim the Jewishness of Paul, we do not have to
downplay the fact that he was a very controversial figure, not only within Second Temple Judaism, but also within the early Jesus movement. The classical interpretation that the controversial nature of Paul (both within and outside his movement) relied on his attempt to separate Christianity from Judaism does not take into consideration the diversity of Second Temple Jewish thought. There was never a monolithic Judaism versus an equally monolithic Christianity. There were many diverse varieties of Judaism (including the early Jesus movement, which, in turn, was also very diverse in its internal components).
3. In order to reclaim the Jewishness of Paul, we do not have to prove that he had nothing to say to Jews and that his mission was aimed only at the inclusion of gentiles. As Daniel Boyarin has reminded us in his work on Paul, a Jew is a Jew, and remains a Jew, even when he or she expresses radical self-criticism toward his or her own religious tradition or against other competitive forms of Judaism.4 Limiting the entire Pauline theological discourse to the sole issue of the inclusion of gentiles would once again confine Paul the Jew to the fringes of Judaism and overshadow the many implications of his theology in the broader context of Second Temple Jewish thought.
Chiarite queste premesse metodologiche e' possibile un tentativo di lettura di Paolo non semplicemente in rapporto al giudaismo o nel suo contesto giudaico ma come parte integrante di esso. Se il cristianesimo non si fosse mai sviluppato come religione autonoma, questo sarebbe il modo in cui oggi leggeremmo Paolo, come un autore ebraico del Secondo Tempo, come il Maestro di giustizia o Filone, dei quali nessuno mette in discussione l'ebraicita' nonostante l'originalità delle loro posizioni. Una lettura teologica odierna di Paolo non può ovviamente prescindere dagli sviluppi posteriori, ma una lettura storica non anacronistica ci spinge a immaginare un tempo in cui il "cristiano" Paolo si collocava su un piano non diverso dall'esseno Maestro di Giustizia, dal fariseo "Hillel" o dal giudeo ellenista Filone. Forse e' giunto il momento che la figura di Paolo sia ricollocata nel suo ambito originario storico di appartenenza
Ci sono segnali evidenti che spingono oggi in questa direzione. I piu’ recenti dizionari del giudaismo del Secondo Tempo (come the "Eerdmans Dictionary of Early Judaism" a cura di John J Collins e Harlow contiene un articolo su Paolo (a firma di Daniel Harrington) e 4 Enoch: The online Encyclopedia of Second Temple Judaism include gli Studi Paolini alla stessa stregua degli studi su Qumran o su Filone. Una tale inclusivita' sarebbe stata impensabile anche solo alcuni anni fa e si colloca in una linea generale di riappropriazione del nascente cristianesimo al giudaismo del primo secolo, di cui si vedono segnali evidenti a livello internazionale. Il presente studio non ha la pretesa di risolvere tutti i numerosi e complessi problemi della teologia paolina ma di offrire alcuni spunti di riflessione che vadano nella direzione di un contributo ad una lettura della figura di Paolo come uno dei protagonisti maggiori del giudaismo del Secondo Tempio, senza negare l'apporto da egli dato al nascente movimento cristiano. Non si tratta di porre il Paolo ebreo in contrasto con il Paolo cristiano, ma di ribadire che all'interno della diversità giudaica del Second Tempio i due termini non sono affatto in contraddizione ed e' possibile leggere Paolo (e Gesu') come pensatori ebrei ed esponenti di un movimento riformatore ebraico che e’ parte integrante della diversita’ ebraica del primo secolo e che solo in seguito (e con molto gradualita) si separata' dalle altre forme di giudaismo a formare una religione separata ed autonoma.
The goal of this volume is fully to embrace the paradigm of the “Paul within Judaism” Perspective not as the conclusion, but as the starting point of our conversation about Paul In my opinion, the potential of such an approach has just begun to be manifested. We have still a long way to go before fully understanding all its monumental implications. In order to properly locate Paul the Jew within the diverse world of Second Temple Judaism, we need, first of all, to establish a better communication between New Testament scholars and Second Temple specialists—two fields of studies that, to date, have remained too distant and deaf to each other. No much will be accomplished as long as Pauline specialists, NT scholars and theologians discuss Paul among themselves and Second Temple specialists refutes to be engaged in any conversation on Paul. The future of Pauline studies is first of all in filling this gap.
Notes (chap.1)
- ↑ R. Bultmann, Teologia del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 1992 (ultima edizione in originale del 1977) o E. Käsemann, Prospettive Paoline, Paideia, Brescia 2003.
- ↑ J.M.G. Barclay, Paolo e la grazia, Paideia, Brescia 2022.
- ↑ Paolo Ricca, “Gesù, la salvezza dei cristiani e dei non cristiani”, Esodo n.2 (apr-giu 2023) 39-45.
- ↑ Paul “is the genius of hatred, in the standpoint of hatred, and in the relentless logic of hatred” (gager 9)
- ↑ Christian Writers on Judaism.
Chapter 2 - PAUL WITHIN JUDAISM Paul “the Convert”?
A major tenant of the traditional interpretation of Paul is “a perception of Paul and his communities as something other than Judaism” (Nanos, p.15). As a “convert” Paul was transformed into “an ex- or even anti-Jew; indeed, into the founder of gentile Christianity”. (Paula Although downplaying the traditional derogatory view of Judaism, the New Perspective has not abandoned the supercessionist model, from E.P. Sanders (“this is what Paul finds wrong in Judaism; it is not Christianity, 552) to N.T. Wright (“Being a Jew was no longer Paul’s basic identity”, Paul and the Faithfulness of God, 1436).
“Paul lived his life entirely within his native Judaism.” Only in later Christian tradition “Paul will be transformed into a “convert”, an ex- or even anti-Jew; indeed, into the founder of gentile Christianity”. (Paula As in the case of Jesus, the problem of Paul is not whether he was a Jew or not, but what kind of Jew he was, because in the diverse world of Second Temple Judaism, there were many different ways of being a Jew.5 << “Paul had no sense of his being something other than a Jew… He had no sense that he was abandoning Judaism” (Sandmel, 21) From Paul’s own standpoint, he has remained completely within Judaism” (63). For Sandmel however this was simply Paul’s personal perception, since he did abandon Judaism. Paul did not intend to abandon Judaism, even though he did. Anything for Sandmel was a consequence of “Paul’s personal difficulties with the Law [which] antedate[d] his conversion, rather than follow it” (28)>>
The Pauline Letters and the Acts of Apostle offer some information about Paul's life before he joined the Jesus movement.
Paul was a Jew, "from the tribe of Benjamin" (Rom 11:1; Phil 3:5).
He lived in the Diaspora, as a native and citizen of Tarsus, the capital city in the Roman province of Cilicia (Acts 9:11; 21:39; 22:3). In the Acts, Paul repeatedly boasts his status of Roman citizen, which granted him privileges and the protection of the Roman Law (Acts 16; 22), and claims that he inherited Roman citizenship from his father ("I was born a citizen," Acts 22:28).
As usual among Jews in the Diaspora, Paul was known by his Hebrew name "Saul" (אוּלאוּל שָׁ) and his Greek name Paulos (Παῦλος; Lat. Paulus).
Born and raised into a Jewish family, since his childhood Paul was presumably a member of the local Jewish community and was instructed in the reading of the Bible in Greek (and Hebrew?). He was certainly fluent in both Hebrew/Aramaic and Greek. It seems likely from his writings that he also received some kind of Greek rhetorical education, but no specific reference to it is made in ancient sources.
In the diverse world of Second Temple Judaism, it is relevant to understand what kind of Jew Paul was, as there were many different ways of being a Jew. Paul calls himself "a Pharisee" (Phil 3:5) and so he does repeatedly in the Acts, where it is also claimed that he lived in Jerusalem and was a pupil of Gamaliel.
Philippians (3:4-6) provides a sort of resume of Paul's early life. Paul refers to himself as being "circumcised on the eighth day, a member of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew born of Hebrews; as to the law, a Pharisee; [6] as to zeal, a persecutor of the church; as to righteousness under the law, blameless." Acts abruptly introduces Paul as an enemy of the Church, in sharp contrast with the example of the first martyr Stephen. Paul "approved" the killing of Stephen and harassed members of the early Jesus movement, serving "out of zeal" the Sadducean high priests (Annas and Caiaphas?). Paul in particular is described as a protagonist of the persecution against the church in Jerusalem that led the Hellenists to be "scattered throughout the countryside of Judea and Samaria." The brief narrative also includes a reference to the Burial of Stephen. In several instances in his own letters Paul openly refers to his persecutory actions against the members of the Jesus movement before his "conversion".
Paul was a Pharisee (see Paul's Early Life). His claim that his persecution came "out of zeal", seems to indicate that Paul the Pharisee was attracted by the teachings of the Zealots and joined the High Priests, i.e. the Sadducees, in their campaign against the most radical members of the Jesus movement.
It should be noted, however, that the persecution by Paul did not target all members of the Jesus movement but only the Christian-Hellenistic party led by Stephen, which according to Acts 7 was charged of promoting radical views about the Jerusalem Temple and observance to the Torah. The "Hebrews" of the Jesus movement were exempted; Acts 5:34-39 claims that Gamaliel played an decisive role in protecting the apostles from the wrath of the Sadducees after the death of Jesus. Paul did not act in complete contrast with the position of his teacher Gamaliel.
Paul was then sent to Damascus to investigate the whereabouts of the Christians there. It was during his voyage to Damascus, that something happened to change radically his attitude toward the Jesus movement.
According to his own words, Paul was educated as a Pharisee. The idea that he abandoned Judaism when he “converted” to the Jesus movement is simply anachronistic. Conversion as an experience of radical abandonment of one’s religious and ethical identity was indeed known in antiquity (as attested in Joseph and Aseneth, and in the works of Philo).
In the ancient society, so much defined by ethnic boundaries conversion was a
“A proselyte offended patriotic pagans complained, turned his back on family, on ancestral customs, and on the gods” (Paula 68). Tacitus despises proselytes as the first lesson they receive is “to despise the gods, to disown their own country and to regard their parents, children, and brothers as of little account” (Hist V.5.1, 2). Joseph and Asenth shows that this is exactly what was expected from a convert. Resented by their own people, converts were not easily welcomed in their new family, either. as Philo shows:
In addition to examples of non-Jews who converted to Judaism, in ancient sources we have examples of Jews who "removed the marks of circumcision and abandoned the holy covenant. They joined with the Gentiles" (1 Mac 1:15). But this was not the experience of Paul. Christianity at his time was a Jewish messianic movement, not a separate religion. Paul, who was born and raised a Jew, remained such after his “conversion”; nothing changed in his religious, ethical and cultural identity. What changed, however, was his view of Judaism. “Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I” (2 Cor 11:22-23)
Nothing changed in Paul if not his awareness of the identity of the Messiah.
“believing that Jesus was the Messiah and affiliating with other Jews who shared that convinctiobn involved making a choice between different groups of Jews, but the choices were within Judaism, they did not signify leaving the practice of a Jewish way of life” (Nanos, 32)
A radical move
“The model of a conversion within a religious tradition is clearly more appropriate than any other” (Gager 25). In describing his experience not as a “prophetic call,” but as a “heavenly revelation,” Paul himself indicated the radicalness of the event. Paul did not abandon Judaism, but “moved” from one variety of Judaism to another. With Alan Segal, I would agree that “Paul was a Pharisaic Jew who converted to a new apocalyptic, Jewish sect.”6 In no way should we downplay the relevance of the event. It was a move within Judaism, and yet, a radical move that reoriented Paul’s entire life and worldview. If, today, a Reform Rabbi became an ultraorthodox Jew, or vice versa, we would also describe such an experience in terms of “conversion.” Likewise, Paul’s conversion should be understood not as a chapter in the parting of the ways between Christianity and Judaism, but as an occurrence in the context of the diversity of Second Temple Judaism.
Note: Replacing the conversion with a “call” to be the apostle of Gentiles however misses the point. Paul will become the apostle of Gentiles only many years later. The revelation he received made him not the apostle of gentiles but a follower of Jesus.
Christianity did not exist yet as a separate religion from Judaism. The Jesus movement however already existed as a distinctive group within Judaism.
The first (Jewish) members of the new movement came from other Jewish groups. In the Acts of the Apostle we notice the tendency to continue to identify members of the Jesus movement according to their former affiliation.
The Hellenists (like Stephen and his companions) as opposed to the Hebrews are those who came from Hellenistic-Jewish communities. Acts defines “Pharisees” those “followers of Jesus” who at the Council of Jerusalem. They interestingly Paul is not reckoned among them, but among their most strenuous opponents
It is true that both in his letters Paul and in Acts Paul refers to himself as a Pharisee especially in relation to the doctrine of resurrection. Modern scholars have then highlighted the Pharisaic elements in Paul’s theology. Paul was and remained a Jew, and should never be labeled as a former Jew. However, the Paul’s major commitment is with the Jesus movement. Which justifies his definition as a “former” Pharisee.
certainly Pharisees who had joined
Paul the Jesus Follower
Paul was a Pharisee who joined the early Jesus movement. Before being known as the apostle of the gentiles, Paul became a member of the Jesus movement, and then, characterized his apostolate within the Jesus movement as having a particular emphasis on the mission to gentiles. Before Paul the apostle of the gentiles, there was Paul “the Jesus follower.” Any inquiry about Paul cannot, therefore, avoid the question of what the early Jesus movement was about in the context of Second Temple Judaism and what it meant for a Jew like Paul to join the Jesus movement.
We all agree that, at its inception, Christianity was a Jewish messianic movement, but what does that mean exactly? It would be simplistic to reduce the early “Christian” message to a generic announcement about the imminent coming of the kingdom of God and about Jesus as the expected Messiah. And it would be simplistic to imagine Paul as simply a Pharisee to whom the name of the future Messiah was revealed and who now believed himself to be living at the end of times.
THE APOCALYPTIC PAUL Scholars of the “Paul within Judaism” perspective have focused their attention especially on the covenantal implications of Paul’s message for the inclusion of gentiles.
There is a growing attention among scholars on the apocalyptic framework of Paul’s thought. As Paula Fredriksen has said, Paul lived in “a Jewish world incandescent with apocalyptic hopes” (Fredriksen, p.xii). It was Paul’s firm belief that his times were history’s final hour. To the Thessalonians Paul repeats his belief that “we who are alive” will experience “the coming of the Lord” (1 Thess. 4:15-17). Every day that passes, the end is closer: “You know what hour it is, how it is full time now to awake from sleep. Our salvation is nearer now than when we first believed. The night is far gone; the day is at hand!” (Rom 13:11-12). Yet, the eschatological expectations about the end of time, the coming of the Messiah and the inclusion of non-Jews are not enough to explain all aspects of Paul’s apocalyptic thought. As all specialists (Collins, Nickelsburg, Sacchi, etc.) have highlighted, apocalypticism was a much more complex word-view in Second Temple Judaism. First of all, it had something to do with the idea of the superhuman origin of evil. Eschatology was a product of protology. We are unfortunately so much influenced by later Christian speculations on the “original sin” by Augustine and Luther that we may not willing to recognize the Second Temple Jewish roots of such a concept by fear of transferring back “Christian” ideas on ancient Jewish sources. From texts like 1 Enoch, Jubilees and 4 Ezra, however, we know that in Second Temple Jewish apocalyptic circles there was a heated debate about the origin of evil that some saw not as a consequence of God’s will or human transgressions but attributed to superhuman powers. <On Paul and The Devil: see Derek R. Brown. “The God of This Age: Satan in the Churches and Letters of the Apostle Paul,” PhD diss., University of Edinburgh, 2011.>
The letters of Paul are rife with references to evil powers and figures, including “principalities” (a)rxai/), “powers” (duna&meij), “authorities” (e0cousi/ai), angels (a!ggeloi), “rulers” (oi9 a!rxontej), “elemental spirits” (ta_ stoixei=a), demons (ta_ daimo&nia), and Satan (o( satana~j).
Paul mentioned Satan in several of his epistles [Rom 16:20; 1 Cor 5:5; 7:5; 2 Cor 2:11; 4:4; 6:15; 11:14; 12:7; 1 Thess 2:18; 3:5], often in the context of temptation (1 Cor 7:5; 2 Cor 2:11) and spiritual conflict (Rom 16:20; 1 Cor 5:5; 2 Cor 12:7; Eph 4:27; 6:11; 1 Thess 2:18). [He usually refer to the Devl as “Satanas” and in one occurrence as Beliar (2 Cor 6:15).] Paul call Satan “the god of this age” (2 Cor 4:4) and announce that “Soon the God of peace will crush Satan under your feet” (Rom 16:20). In view of 1 Thess 2:18–3:5 and 2 Cor 4:4, Paul’s notion of Satan apparently included his belief that Satan specifically opposed his work as a pioneer missionary and an apostle called to preach the gospel and establish communities of faith. Many scholars (starting from F.C. Bauer) have downplayed these references and the apocalyptic connection between Satan and sin, fail to take seriously the implications of Paul’s references to Satan for the apostle’s wider theology. Only a few scholars, from Otto Everling’s 1888 volume, Die paulinische Angelologie und Dämonologie to J. Christiaan Beker’s Paul the Apostle and Richard Bell’s Deliver us from Evil: Interpreting the Redemption from the Power of Satan in New Testament Theology [WUNT 216; Tübingen: Mohr Siebeck, 2007], have taken more seriously the Jewish apocalyptic worldview of Paul. one of Paul’s boldest appellations for Satan, “the god of this age” (2 Cor 4:4), reveals a strong dualistic framework similar to that of the Jewish apocalyptic tradition
The Devil and the Serpent: The clearest NT example of Satan’s identification with the serpent of Gen 3 is found in the book of Revelation (Rev 12:9; cf. 12:14, 15; 20:2). In Rom 16:20a Paul seems to allude to the eschatological defeat of Satan by echoing Gen 3:15: “the God of peace will shortly crush Satan under your feet.” Paul’s reference to the “crushing” of Satan, it is often claimed, echoes God’s cursing of the serpent and promise that Eve’s offspring will “bruise” (MT: Pw#$; LXX: thre/w) the serpent. See the Parables of Enoch. See also 2 Cor 11:3
Paul finds himself at the juncture of the two ages, a unique moment in history in which the powers of evil have, in one sense, already been defeated through the Christ event and thereby “disarmed” of their full power, but in another sense endure in the present age with residual, but deleterious power against the people of God. (p.75) Although, for Paul, Satan and evil powers have been judged in Jesus’ death and resurrection and will be ultimately defeated in the eschaton, such forces remain at work in the present age. (p79). Satan is still operating as a Tempter.
The idea of the Messiah as the forgiver on earth makes perfect sense as a development of the ancient Enochic apocalyptic tradition. The apocalyptic “counternarrative” of 1 Enoch centered on the collapse of the creative order by a cosmic rebellion (the oath and the actions of the fallen angels): “The whole earth has been corrupted by Azazel’s teaching of his [own] actions; and write upon him all sin” (1 En. 10:8). It was this cosmic rebellion that produced the catastrophe of the flood, but also the need for a new creation. The Enochic view of the origin of evil had profound implications in the development of Second Temple Jewish thought. The idea of the “end of times” is today so much ingrained in the Jewish and Christian traditions to make it difficult even to imagine a time when it was not, and to fully comprehend its revolutionary impact when it first emerged. In the words of Genesis, nothing is more perfect than the perfect world, which God himself saw and praised as “very good” (Gen. 1:31). Nobody would change something that “works,” unless something went terribly wrong. In apocalyptic thought, eschatology is always the product of protology. The problem of Enochic Judaism with the Mosaic law was also the product of protology. It did not come from a direct criticism of the law, but from the recognition that the angelic rebellion had made it difficult for people to follow any laws (including the Mosaic Torah) in a universe now disrupted by the presence of superhuman evil. The problem wasnot the Torah itself, but the incapability of human beings to do good deeds, which affects the human relationship with the Mosaic Torah. The shift of focus was not primarily from Moses to Enoch, but from the trust in human responsibility to the drama of human culpability. While at the center of the Mosaic Torah was the human responsibility to follow God’s laws, at the center of Enochic Judaism was now a paradigm of the victimization of all humankind. This is the reason it would be incorrect to talk of Enochic Judaism as a form of Judaism “against” or “without” the Torah. Enochic Judaism was not “competing wisdom,” but more properly, a “theology of complaint.” There was no alternative Enochic halakah for this world, no Enochic purity code, no Enochic Torah: every hope of redemption was postponed to the end of times. The Enochians were not competing with Moses—they were merely complaining. In the Enochic Book of Dreams, the chosen people of Israel are promised a future redemption in the world to come, but in this world, Israel is affected by the spread of evil with no divine protection, as are all other nations. The Enochic view had disturbing implications for the self- understanding of the Jewish people as the people of the covenant. It generated a heated debate within Judaism about the origin and nature of evil.7 Many (like the Pharisees and the Sadducees) rejected the very idea of the superhuman origin of evil; some explored other paths in order to save human freedom and God’s omnipotence—paths that led to alternative solutions, from the cor malignum of 4 Ezra to the rabbinic yetzer hara‘. Even within apocalyptic circles, there were competing theologies. In the mid-second century BCE, the book of Jubilees reacted against this demise of the covenantal relation with God by creating an effective synthesis between Enoch and Moses that most scholars see as the foundation of the Essene movement. While maintaining the Enochic frame of corruption and decay, Jubilees reinterpreted the covenant as the “medicine” provided by God to spare the chosen people from the power of evil. The merging of Mosaic and Enochic traditions redefined a space where the people of Israel could now live, protected from the evilness of the world under the boundaries of an alternative halakah as long as they remained faithful to the imposed rules. The covenant was restored as the prerequisite for salvation. In this respect, as Collins says, “Jubilees, which retells the stories of Genesis from a distinctly Mosaic perspective, with explicit halachic interests,” stood “in striking contrast” to Enochic tradition.8 Even more radically, the Community Rule would explore predestination as a way to neutralize God’s loss of control of the created world and restore God’s omnipotence.9 Enochic Judaism remained faithful to its own premises (Jews and gentiles are equally affected by evil), but was not insensitive to the criticism of having given too much power to evil, thereby dramatically reducing humanity’s chances of being saved. The later Enochic tradition tried to solve the problem by following a different path, a path that led them to address the problem of forgiveness of sins.
As a result of his “conversion,” Paul did not abandon Judaism, but switched his allegiance from one form to another of Second Temple Judaism. He fully embraced the apocalyptic worldview and the claim that Jesus the Messiah had already come (and would return at the end of times as the final judge). This included not only the believe that the Messiah had already come, but also and foremost the explanation of why the Messiah had come before the end. The early followers of Jesus had an answer: Jesus did not come simply to reveal his name and identity. Jesus came as “the Son of Man who has the authority on earth to forgive sins” (Mark 2 and parallels).
Chapter 3: FORGIVENESS OF SINS
(1) Forgiveness of Sins in the Enochic Tradition
Talking of “Forgiveness of sins” in the Enochic tradition may seem paradoxical. At the center of the Enochic “theology of complaint” is the apparently absolute rejection of God’s forgiveness of sins. In the introduction to his commentary Nickelsburgh devotes one of his shortest paragraphs to that he defines as “a minor issue in 1 Enoch” (p.54), and attributes this lack of interest in the subject to “its black-and-white distinction between the righteous and the sinners.” A reading of 1 Enoch seems to confirm Nichelsburg’s conclusion. The message of repentance and forgiveness is significantly missing in 1 Enoch. Enoch was chosen by God not as a preacher of forgiveness, but rather as a messenger of unforgiveness--to announce to the fallen angels that "there will be no forgiveness for them." (1 En 12). A compassionate Enoch indeed accepted to intercede on behalf of the fallen angels and "drew up a petition for them that they might find forgiveness, and to read their petition in the presence of the Lord of Heaven." (13: 4-5) but only to be lectured by God. Enoch had to report back to the fallen angels that such a petition “will not be accepted.” The last word of God leaves no room for any hope of forgiveness. "Say to them: You have no peace" (16:4).
Later Enochic texts, Both Dream Visions and the Epistle of Enoch draw a clear distinction between the righteous and the sinners and make no reference to forgiveness of sins. In the Animal Apocalypse there are white sheep who open their eyes but no black sheep becomes white. In the Epistle of Enoch the opposition between the righteous and the sinners is turned into a sociological conflict between the rich and the poor, the oppressors and the oppressed, the haves and the have nots.
Also the introductory chapters of the Book of Enoch attributes forgives for sins only to the <righteous> (Ch.5.
And yet, in spite of the consistency of the Enochic tradition on the rejection of forgiveness of sins, something substantially changes with the Parables of Enoch.
At first the Book of Parables seems to reiterates in its language of revenge and judgment the same attitude uncompromised opposition between the oppressed and the oppressors, the righteous and the sinners.
With a language that is reminiscent of the Book of the Watchers, it says that in the Last Judgment the destiny of the “kings and the mighty” will be like that of the fallen angels at the beginning of creation: “no one will seek mercy for them from the Lord of the Spirits” (38:1).
In heaven instead the “Holy ones” (who seem to include the deceded righteous) are petitioning and interceding for the sons of men.
CHAPTER 40:
The voice of the archangels:
And the third voice I heard petitioning and praying for those who dwell on the earth and interceding in the name of the Lord of the Spirits … The one who is in charge of the repentance to hope of those who inherit everlasting life, his name is Phanuel” (40:6, 9).
In 1 Enoch ch. 48 the emphasis is on the Last Judgment and the revelation of the Messiah Son of Man. The reference is explicitly to Daniel 7, but contrary to the source text, the Son of Man is not the recipient of God's judgment but is now the Judge, sitting on the throne of God.
We are repeated that at the Last Judgment the righteous will be saved in the name of God as they are filled with good works and have hated the world of unrighteousness
An opposite destiny awaits the sinners; they will not be saved "because of the works of their hands". (here are the kings and the Mighty.)
The denial have any reference to God’s forgiveness is one of the major obstacles in establishing a connection between the book of Parables and the Synoptics, where the idea of forgiveness of sins takes central stage. What does the Forgiving Jesus have to do with the unforgiving Enoch?
Then after a brief interlude (ch. 49) praising the justice of God and the Elect,
Then in chap. 50-51 the judgment is presented in his more universal way , as the days in which earth will give back what has been entrusted to it and Sheol will give back what it has received… (51:1).
As expected the righteous will be rewarded and the sinners punished. However, quite unexpectedly a third group ("the others") is singled out besides the righteous and the sinners--they are "those who repent and abandon the works of their hands."
"1 And in those days a change shall take place for the holy and chosen, and the light of days will dwell upon them, and glory and honor will return to the holy, 2 On the day of distress, evil will be stored up against the sinners. And the righteous will be victorious in the name of the Lord of Spirits: and He will cause the others to witness (this), so that they may repent and abandon the works of their hands. 3 They will have < no > honor in the presence of the Lord of Spirits, yet through His name they will be saved, and the Lord of Spirits will have mercy on them, for great is His mercy. 4 And He is righteous in His judgement, and in the presence of His glory unrighteousness will not stand: at His judgement the unrepentant will perish in His presence. 5 "And hereafter I will have no mercy on them," says the Lord of Spirits.
In the context of the Enochic tradition, the passage is extremely important as for the first time introduces the idea of repentance at the time of the Last Judgment, yet it has not received the attention it deserves and has been mistranslated and misinterpreted even in the most recent and comprehensive commentaries to the book of Parables by Sabino Chiala' (1997) and George Nickelsburg (2012).
With the majority of manuscripts and all previous translations, Chiala' correctly translates verse 3 as 'they will have no honor' (Eth. kebr)", in the sense that they will have no "merit" before God. In the commentary however Chiala understands the verse as referred to the "righteous": "they" (not the others) are the subject of the sentence. Chiala' takes then the verse as a general statement that God's judgment is based exclusively on God's Mercy even for the "righteous," who cannot claim any "honor" before God. But this contradicts what the Book of Parables had said in chapter 48; the righteous have good works, while the sinners do not. Besides, here the author refers to "the others" (the ones who repent and abandon the works of their hands) as it is proved by the fact that the following verses (4-5) continue the discussion about repentance not "righteousness", to the extent that "the sinners" are now denoted as "the unrepentant."
Nickelsburg correctly identifies the "others" as a distinctive group—an intermediate group between the righteous and the sinners, but understands them as a subgroup of "the righteous" who may not have the same merits but will share the same destiny. "Given the references to the righteous and their oppressors in vv. 1-2b, 'the others' mentioned in this action must be either the gentiles not included among the oppressors of the righteous or other Israelites not included among the righteous, the holy, and the chosen" (Nickelsburg, p. 182). To reinforce his own interpretation Nickelsburg quite arbitrarily "corrects" the text, based on the testimony of only two manuscripts against most mss. (and previous translations, like Charles and Chiala'), and suppress the negative ("they will have no honor"). Like the righteous, the others will have "honor" before God and will be saved in His Name. But "the others" are not defined in the text for who they are but for what they do (“they repent and abandon the works of their hands”). Nickelsburg's interpretation that the "works of their hands" is a reference to idolatry is contradicted by the fact that the text here repeats the same phrase used in 48:8 to denote the sinners ("the strong who possess the land because of the works of their hands… will not be saved"). "The others" are not "good gentiles" or "not-so-bad Israelites"; like the sinners they can claim no honor before God.
Both Chiala' and Nickelsburg miss the revolutionary importance of the text, which at the end of times envisions the emergence of a third group beside "the righteous" and "the sinners." The righteous have "honor" (merit, good works) and are saved in the name of God, while "the sinners" have no honor (no good works) and are not saved in the name of God. The others are not a subgroup of the righteous nor a less guilty group of sinners or gentiles, but as the text explicitly states, they are rather a subgroup of the sinners who will repent and abandon the works of their hands. Like the sinners (and unlike the righteous), the "others" have no "honor" (no merit or good works) before God, but because of their repentance they will be saved in the name of God, like the righteous (and unlike the sinners).
In other words, the text explores the relation between the Justice and Mercy of God, a theme that we would find at the center of the Jesus movement and broadly discuss also in the early rabbinic movement. According to the Book of Parables, the righteous are saved according to God's Justice and Mercy, and the sinners are condemned according to God's Justice and Mercy, but those who repent will be saved by God's Mercy even though they should not be saved according to God's Justice. Repentance makes God's Mercy prevail on God's Justice. No reference is made to the traditional means of atonement related to the Temple or good works; the Book of Parables refers to the time of the manifestation of God and the Messiah as a (short) time in which a last opportunity of repentance will be offered to the sinners. The time is limited: after the judgment absolutely no further chance of forgiveness will be offered to "the unrepentant." The ones who do not repent will be lost forever.
The interpretation of ch. 50 is consistent with the entire Book of Parables and allows to better undestasnd the develo
Having affirmed that at the end repentance is granted to the sinners who repent, the text must clarify that nonetheless this possibility is not given to everybody. It does not apply to the Fallen angels and does not apply to the kings and the landowners.
In cgh.53 we re told that the same angels of punishment who “are preparing all the instruments of Satan, are also preparing these for the Kings and the Mighty and the
and is not contradicted in chs 62-63, on the contrary it is reinforced as the goal of these chapters is to clarify that the kings and the mighty are excluded by this possibility of repentance.
In ch. 62-63 it is affirmed that the possibility of repentance does not apply to “the kings and the mighty and the exalted and those who possess the land”
The son of Man will overturn the kings from their thrones and their kingdoms,
Because they do not exalt him or praise him,
Or humbly acknowledge whence the kingdom was given to them (46:5)
The possibility of repentance granted to the sinners make(rhetorically) shine in stark contrast with the destiny the Kings. Now we better understand why they do what they do.
In what Nickelsburg describes as a “pitiful spectacle of role reversal” (p.266) at the moment of judgment all the kings and the mighty and the exalted and those who rule the land will fall on their faces in his presence; and they will worship and set their hope on that Son of Man, and they will supplicate and petition for mercy from him.”
Once again the language is reminiscent of the Book of Watchers. Like the fallen angels did with Enoch, the kings and the Mighty will petition to have mercy. They also think that they could take advantage of God’s mercy. But this is not the case: But the Lord of the Spirits will press them.. and he will deliver them to the angels for punishments…
In order the reinforce the point, the same scene repeats itself.
Even when in the hands of the angels of punishment, thay will implore them (They will even ‘Implore the angel of his punishment”) to give them “a little respite, that they might fall down and worship in the presence of the Lord of the Spirits, and the at they might confess their sin in his presence” (63:1)
The Parables then reiterate the same message of unforgiveness
Like the fallen angels in the Book of the Watcher, so the powerful will no have peace and forgiveness.
But once again there will not be peace for them.
The Book of Parables does not attribute any special power of forgiveness to the Messiah, who remains the judge and destroyer of evil.
The exception however confirms the rule.
Yet the text signals a radical turn in a tradition that had never paid attention to the problem of repentance or forgiveness of sin, if not in order to exclude such a possibility. Repentance is now a central theme in the book of Parables; and a central aspect i [[it is so important that it becomes now clear why one of the four archangels (besides Michael, Raphael and Gabriel) was said to be specifically entitled to this task--"Phanuel, who is set over the repentance unto hope of those who inherit eternal life" (1 En 40:9).]]
[[In the Parables of Enoch, we read that at the end of times in the last judgment, as expected, God and his Messiah Son of Man will save the righteous and condemn the unrighteous. The righteous have “honor” (merit, good works) and will be victorious in the name of God, while “the sinners” have no honor (no good works) and will not be saved in the name of God. But quite unexpectedly, in chapter 50, a third group emerges at the moment of the judgment. They are called “the others”: they are sinners who repent and abandon the works of their hands. “They will have no honor in the presence of the Lord of Spirits, yet through His name they will be saved, and the Lord of Spirits will have mercy on them, for great is His mercy.”10 In other words, the text explores the relation between the justice and the mercy of God and the role played by these two attributes of God in the judgment. According to the book of Parables, the righteous are saved according to God’s justice and mercy, the sinners are condemned according to God’s justice and mercy, but those who repent will be saved by God’s mercy even though they should not be saved according to God’s justice. Repentance makes God’s mercy prevail over God’s justice. ]]
THE MESSIAH’S MISSION TO THE “MANY”
The text does not further elaborate on these points, but if we read the Synoptics about the preaching of John the Baptist and Jesus, it is like reading a midrash of 1 Enoch 50. Regardless of the issue whether or not this interpretation reflects, "adjusts" or corrects what the historical John the Baptist and the historical Jesus "really" did or meant to do, from the view point of the Synoptics the time of the end has come and God's Messiah has been revealed in Jesus. The prophecy of 1 Enoch 50 does no longer belong to the future but has become true in the manifestation "on earth" of the Son of Man Jesus and his precursor John the Baptist. Their entire mission would be devoted to "the others."
The Christian idea of the first coming of the Messiah as forgiver is a radical, yet very logical, variant of the Enochic system. The concept of the existence of a time of repentance immediately before the judgment and the prophecy that, at that point, “the sinners” will be divided between “the repentant” (the others) and “the unrepentant,” is the necessary “premise” of the missions of John and Jesus, as narrated in the Synoptics.
The “historical” John the Baptist is certainly a complex figure with his emphasis of purity but the way in which the Synoptics reinterprets his preaching force him in the line opened by the Parables of Enoch,
The imminent coming of the last judgment, when the earth will be cleansed with fire, means urgent repentance and “forgiveness of sins” for those who in this world have “no honor.” “Be baptized with water; otherwise, you will be baptized with the fire of judgment by the Son of Man”: this seems to be, in essence, the message of John the Baptist as understood by the Synoptics, an interpretation that does not contradict the interest of the Christian authors to present it as a prophecy of Christian Baptism (by the Holy Spirit).
Similar ideas find an echo also in the Life of Adam and Eve—a text generally dated to the first century CE—where the sinner Adam does penance for forty days, immersed in the waters of the Jordan (and it is not by accident that John baptized in the living water of the Jordan). The first man (and first sinner) is driven by one steadfast hope: “Maybe God will have mercy on me” (L. A.E. 4:3). His plea to be allowed back in the Garden of Eden will not be accepted, but at the time of his death, his soul will not be handed over to the devil, as his crime deserved, but carried off to heaven; so, God decided in his mercy, despite the complaints of Satan.
In the Christian interpretation, John the Baptist, as the precursor, could only announce the urgency of repentance and express hope in God’s mercy. But with Jesus, it was another matter: he was the Son of Man who had authority on earth to forgive sins, who left to his disciples the power of forgiveness through Baptism “with the Holy Spirit,” and who will return with the angels to perform the judgment with fire. After all, who can have more authority to forgive than the one whom God has delegated as the eschatological judge?
As the forgiver, Jesus was not sent to “the righteous,” but to “sinners,” so that they might repent. There is no evidence in the Synoptics of a universal mission of Jesus to every person: Jesus was sent to “the lost sheep [of the house of Israel]” (Matt. 10:6; cf. 15:24); the righteous do not need the doctor. Jesus was the doctor sent to heal sinners (Mark 2:17; Matt. 9:13), as Luke makes explicit: “I have come to call not the righteous but sinners to repentance” (Luke 5:32).
Reading the Synoptics in light of the book of Parables of Enoch sheds light also on some parables that the Christian tradition attributed to Jesus. The parable of the lost sheep (Matt. 18:10–14; Luke 15:1–7) defines the relationship between God and “the others”; Luke’s parable of the prodigal son (15:11–32) reiterates the theme, but also adds a teaching about the relationship between “the righteous” and “the others”—between those who have honor and are saved because they have never abandoned the house of the Father and those who have no honor, and yet, are saved as well since they have repented and abandoned the works of their hands. The examples could be numerous, but no parable seems more enlightening to me than the one narrated by Matthew on the workers in the vineyard (Matt. 20:1–16). The householder who pays the same salary for different “measures” of work gives the full reward (salvation) to the “righteous” and to the “others,” just as chapter 50 of the Parables claim that God will do in the last judgment. God’s mercy (“Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity?”) bests God’s justice, or, as the letter of James will say, “Mercy triumphs over the judgment [κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως]” (James 2:13).
The contrast with the traditions developed in the rabbinic movement could not be stronger. The rabbis freely discuss the relation between the two middot—God’s measures of justice and mercy—providing flexible answers to the issue. Mishnah Sotah (1:7–9) sticks to the principle “with what measure a man metes it shall be measured to him again,” and affirms that “with the same measure,” God gives justice when punishing evil deeds and mercy when rewarding good deeds. On the contrary, the parallel text in Tosefta Sotah (3:1–4:19) claims that “the measure of Mercy is five hundred times greater than the measure of Justice.” But the two divine attributes are never opposed as in the book of Parables and in the early
10
Christian tradition; on the contrary, their necessarily complementary nature is emphasized. Not accidentally, the “rabbinic” version of the parables will end with different words in which God’s mercy is praised, but God’s justice is not denied: “This one did more work in two hours than the rest of you did working all day long” (y. Ber. 2:8).
Chapter 4: Paul the Apocalyptic Thinker / THE PROBLEM OF JUSTIFICATION
In the traditional Christian reading of Paul “justification by faith” is a central element, if not the central element of his thought. Endless discussion about it meaning The meaning if the term must be understood in the context of second temple Judaism as well as in the development of the early Jesus movement. The difficulty to find “parallels” in contemporary Jewish sources has led scholars to dismiss completely the “justification theory” as the imposition on Paul of a much later Christian paradigm. Other scholars instead like Stephen Westerholm have struggled to reaffirm the “traditional” understanding as the only plausible interpretation of Paul and evidence of his uniqueness. The difficulty to find the “Lutheran” concept of justification in the Christian literature outside of Paul led scholars to assume that the concept was “forgotten” in the post-Pauline tradition before being “rediscovered” by Augustine and Luther. The assumption was that Paul had been and as a reactions Christian authors went back to the idea of justification by works”. A book by Brian J. Arnold has recently revisited the problem, reaching the opposite conclusion that “justification by faith” remains indeed an important element in the post-Pauline tradition. Arnold fails to read Paul “within Judaism” however,
The discussion has reached a level of polarization, that seems to prevent from any dialogue. Either Augustine and Luther were totally right in their understanding of Paul or they were totally wrong. Each party seems to have good arguments in support of their thesis. Both parties have a weakness, which is not only the lack of listening to the other side but the tendency to create a totally unique Paul, who in order to be remain Jewish is completely isolated from the other members of the Jesus movement, or in order to remain “Christian” is totally isolated from his fellow Jews. But what if we read Paul in light of the Parables of Enoch and in line with the Synoptic tradition? What if we try to see him as a Second Temple Jew and a follower of Jesus messianic group. The problems of the origin of evil, the freedom of human will, and the forgiveness of sins are at the center of Paul’s thought. As we have seen, these were not Pauline problems, but Second Temple Jewish problems. The originality of Paul was not in the questions, but in the answers. The “Enochic” apocalyptic context and the emphasis on forgiveness of sins allows us the rethink the problem of justification in Paul.
Scholars have long noticed the existence or some tension in Paul between “justification by faith alone” and “judgment according to the deeds” The same Paul who claims that “a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ” (2:16) a few lines before had stated that God “will recompense everyone according to their works” (2:6).
Clement reminds fellow Christians to use “self-control” as we will be “justified by our works, and not our words” and then reiterate
Apocalyptic Jews and followers of Jesus did not see the things in contradiction to one other. We do. Obviously, the problem is ours not theirs.
Let us clothe ourselves with concord and humility, ever exercising self-control, standing far off from all whispering and evil-speaking, being justified by our works, and not our words. (Clement 30). [Here he is talking to Christians]]
“And we, too, being called by His will in Christ Jesus, are not justified by ourselves, nor by our own wisdom, or understanding, or godliness, or works which we have wrought in holiness of heart; but by that faith through which, from the beginning, Almighty God has justified all men; to whom be glory for ever and ever. Amen.” (1 Clement 32) [Here Clement is taking about eschatological renewal).
Clement is also referring to the blood of Christ in many passages.
redemption should flow through the blood of the Lord to all those who believe and hope in God. (Clement chap. 12)
Let us look steadfastly to the blood of Christ, and see how precious that blood is to God, which, having been shed for our salvation, has set the grace of repentance before the whole world. Let us turn to every age that has passed, and learn that, from generation to generation, the Lord has granted a place of repentance to all who would be converted to Him. Noah preached repentance, and as many as listened to him were saved. Jonah proclaimed destruction to the Ninevites; but they, repenting of their sins, propitiated God by prayer, and obtained salvation, although they were aliens [to the covenant] of God. (Clement. Chap. 7)
Letter to Diognetus: CHAPTER 9 9:1 Having thus planned everything already in His mind with His Son, He permitted us during the former time to be borne along by disorderly impulses as we desired, led astray by pleasures and lusts, not at all because He took delight in our sins, but because He bore with us, not because He approved of the past season of iniquity, but because He was creating the present season of righteousness, that, being convicted in the past time by our own deeds as unworthy of life, we might now be made deserving by the goodness of God, and having made clear our inability to enter into the kingdom of God of ourselves, might be enabled by the ability of God. 9:2 And when our iniquity had been fully accomplished, and it had been made perfectly manifest that punishment and death were expected as its recompense, and the season came which God had ordained, when henceforth He should manifest His goodness and power (O the exceeding great kindness and love of God), He hated us not, neither rejected us, nor bore us malice, but was long-suffering and patient, and in pity for us took upon Himself our sins, and Himself parted with His own Son as a ransom for us, the holy for the lawless, the guileless for the evil, _the just for the unjust,_ the incorruptible for the corruptible, the immortal for the mortal. 9:3 For what else but His righteousness would have covered our sins? 9:4 In whom was it possible for us lawless and ungodly men to have been justified, save only in the Son of God? 9:5 O the sweet exchange, O the inscrutable creation, O the unexpected benefits; that the iniquity of many should be concealed in One Righteous Man, and the righteousness of One should justify many that are iniquitous! 9:6 Having then in the former time demonstrated the inability of our nature to obtain life, and having now revealed a Saviour able to save even creatures which have no ability, He willed that for both reasons we should believe in His goodness and should regard Him as nurse, father, teacher, counsellor, physician, mind, light, honour, glory, strength and life. “The Epistle to Diognetus is the Locus classicus of justification by faith in the second century, Rooted in grace and mercy, justification equates to the forgiveness of sins and the imputation of Christ’s righteousness.” (Arnold, p.100) Arnold wants to defend to traditional idea of “forensic justification”
LETTER TO THE ROMANS
In the letter to the Romans, Paul wrote to the Jesus community of Rome: a community of people—Jews and non-Jews—who confessed Jesus as the Messiah and had received baptism. Why did they do it? They did it for the same reason why all first followers of Jesus (including Paul) had done, because they were told that the end of time had come and that this was the time in which God would grant forgiveness to the sinners who believe. Paul knew that he could count in Rome on some important connections, first of all Priscilla and Aquila, who were with him in Corinth and Ephesus. Yet he addressed a community he had not founded. He does not need This world is dominated by the Devil, but the time is approaching of the end of his power. “The God of peace will shortly crush Satan under your feet” (16:20). And above all, Paul reminds that the Lord has come and has delivered a message of salvation for “everyone who have faith, to the Jew first and also to the Greeks” (1:16). Paul believed that the time of judgment is close, the time of “God’s wrath against all ungodliness” (1:18). Non-Jews also will be judged (“they are without excuse” Using an argument frequently used by Hellenistic Jews
have joined were former sinners, but who believed that they had received forgiveness of sins through Jesus’ death.
First of all, Paul reminds his readers that according to God’s plan, the moral life of Jews is regulated by the Torah, while the moral life of gentiles is regulated by their own conscience (or the natural law of the universe—an idea that Paul borrowed from Hellenistic Judaism and its emphasis on the creative order as the main means of revelation of God’s will). Then, Paul repeats the undisputed Second Temple belief that on the day of judgment, God “will repay according to each one’s deeds” (Rom. 2:8). In no way did Paul dispute that if Jews and gentiles do “good deeds” (follow the Torah and their own conscience, respectively), they will obtain salvation. Evildoers will be punished and the righteous will be save with no distinction. “There will be anguish and distress for everyone who does evil, the Jews first and also the Greeks, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jews first and also the Greeks. For God shows no partiality” (Rom 2:9-10). Now Paul turns to his fellow Jews: having the Law does not automatically include all of them among the righteous. “for it is not the hearers of the Law who are righteous in God’s sight, but the doers of the Law who will be justified” in the last judgment” (2:13). Being a Jew is not in itself does not mean a special treatment. “Circumcision indeed is of value if you obey the law; but you break the law, your circumcision has become uncircumcision” (2:25). Paul does not deny that being a Jew has “an advantage”, as the Jews have receives “the oracles of God”, but this will not prevent God from applying his justice against the trangressors. This leads to Paul’s central argument: “all, both Jews and non-Jews, are under the power of sin” (3:9). In order to prove his point Paul quotes a series of “biblical” passages, or better crafts a composite quotation made of different biblical verses showing widespread evil.
Qohelet 7:20: “Surely there is no one on earth so righteous as to do good without ever sinning” Ps. 14:1-2: is no one who does good; no, not even one”] Ps. 52:3 [LXX]: “[God looked down to see if] there is there were any that understood, or sought after God. They have all gone out of the wayno one who does good; no, not even one”]; Ps. 5:9 [“Their tho; 140:3; 10:7; Isa. 59:7-8 [“The way of peace they do not know]; Ps. 36:1 (cf. Rom 3:18): “There is no fear of God before [his] eyes” This passage has been traditionally interpreted not as a simple recognition that all people commit sins but as a general statement asserting the human inability to do good. As a result, “The apostle thought along the same lines as Augustine, Luther and Calvin” (Westerholm, p.48): “sinners, incapable of doing good, can be justified only by God’s grace, through faith in Jesus Christ” (Westerholm, p.49). The quotation express the recognition by God of the presence of sinners; how pervasive evil is. In so doing the Christian interpretation has reversed the order of the discourse. The quotation has become the center of the discourse while in the text the emphasis is not on the quotation but on the statement that the quotation intends to prove. The point of Paul is not that all people are sinners as it is proved by the fact they are all under the power of sin, but that both Jews and Gentiles alike are affected by evil (“under the power of sin”) as it is proved by the fact that there are so many sinners among them. The goal is to show that sin is a common experience of Jews and non-Jews, and none can claim to be spared. Does the fact that all humans are “under the power of evil”, mean that all and each human being are so sinful that they will not pass judgement? Paul has just said that in the judgment God reserves “glory and honor and peace for everyone who does good, the Jews first A conviction that he is repeated in II Corinthians: “We must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive good and evil, according to what he has done in body (2 Cor 5:10). Scholars have long noticed the existence of some tension in Paul between the “Christian” idea of “justification by faith alone” and the “Jewish” idea of “judgment according to the deeds”
Some have concluded that Paul was “incoherent” in his doctrine of evil, and the statement about judgement according the deeds should be taken as a meaningless Jewish remaint superseded by the new Christian doctrine. Sanders has offered the most successful to harmonize the two ideas under the concept of “covenantal nomism”, showing that there is no conflict: both in Judaism and in Christianity salvation is by grace but requires “works” to “remain in”. “The distinction between being judged on the basis of deeds and punished anor rewarded at the judgment (or in this life), on the one hand, and being saved by God’s gracious election, on the other, was the general view in Rabbinic literature … Salvation by grace is not incompatible with punishment and reward for deeds” (Sanders, 517). Following Sanders, Kent L. Yinger also concluded that there is no contradiction as the judgment by works “will nor so much determine as reveal one’s character and status as righteous or wicked” (Yinger, p. 16). The assumption remains that “justification by faith” and “salvation by works” both deal with the final verdict of righteousness for eternal life. But the idea of “covenantal nomism” was complicated for some Jews by the superhuman power of evil. The Enochians would not have denied that salvation is ultimately an act of grace, but their doctrine of cosmic evil implied the expectation of an additional gift of grace to the sinners that could compensate the power of evil and restore the terms of the covenant. In light of their apocalyptic premises the early followers of Jesus believed that this additional gift of justification by faith had already offered to those who had accepted the authority of Jesus the Messiah, before the (future) Last Judgment according to the deeds”. Coherently, Paul invites the
Once again the apocalyptic context tells us that there is no contradiction. This is perfectly in line with the apocalyptic position that affirms the difficulty, not the impossibility, to do good.
The problem is another:
As an apocalyptic Jew, Paul knows that evil is not only a consequence of human transgression, has come from a rebellion in heaven, which was not a consequence of the human transgression of the covenant, and therefore was “apart from the law”. This makes difficult (not impossible) to do good as it does not depends only by human choice but people are victims of a cosmic evil. Some apocalyptic Jews had reacted by claiming that cosmic evil is a problem of Gentiles only as Jews are protectd by the covenant, but this is not the position of Paul. He sides uncompromisingly with Dream Visions against Jubilees, with the view that this cosmic evil is affecting all humans (including the Jews), vs. the view that the Jews are protected by the evil. The law can only give the Jews “the knowledge of sin”.
The good news for Paul is that in the imminence of the Judgment God has provided God must provide a gift of justification to compensates the power of cosmic evil. This gift is equally “apart from law” (as it does not depend of human obedience to the law) and is given to both Jews and Gentiles, with no distinction, as both are affected by evil. This gift of forgiveness is Christ Jesus, whom God put forward as a sacrifice of atonement by his blood, effective through faith” (3:25). The gift is offered “apart from works prescribed by the law, and as such is offered indistinctively to Jews and Gentiles, through the same requirement, “faith in Jesus”. Paul immediately clarifies that this is not a challenge to the law, on the contrary, it confirms what the law itself affirms, by presenting the case of Abraham as example that God has the power to forgive sins “by faith”. The gift of justification came through the death of Jesus Paul establish a close parallelism between the fall of Adam and the “free gift” of Jesus. The grace of God through Jesus has then counterbalance the power of cosmic evil, restoring the relation between God and humans.
The parallelism between Jesus and Adam is central in Paul. Jesus has a certain degree of divinity, but is not “theos” (God); He does not the term “son of man”, but he gives him the same status as a “man from heaven” (1 Cor 15:48).
The two “sons of God” were both were created with a divine status
The christology of Paul does not radically depart from the Enochic pattern. Like the Synoptic “Son of Man,” the Pauline Son-kyrios belongs to the heavenly sphere, and is separated from and subordinate to the Father-theos. After completing his mission of forgiveness through his self-sacrifice, “the Son, too, will be subjected to the One who put all things in subjection under him, so that God may be all in all” (1 Cor 15:28). If Paul does not use the term “Son of Man” (even in contexts such as 1 Thess 4:16–17, where the reference to Dan 7 would have made it obvious), it is because the title would have interfered with the parallelism he establishes between Adam and the new Adam, by suggesting the subordination of Jesus ben Adam to the first Adam. As the obedient son, Christ is compared to the disobedient son, Adam, with whom he shares the nature and dignity as the other “Son of God” (see Luke 3:38). Both were created in the image and likeness of God, taking upon himself the “form” of God; Adam and Jesus, however, are separated by a different fate, that is, one of guilt and transgression in the case of Adam, and the other of obedience and glory in the case of the new Adam. The lowering (kenosis) of Adam is a punishment caused by his disobedience, while in Jesus the lowering (kenosis) is a voluntary choice for accomplishing his mission of forgiveness and is followed by his elevation and glorification (Phil 2:5–11) to a “divine” status that is higher than he was before. The veneration of Jesus is evidence of Jesus’ “divine” status, not of his uncreated status; it is the veneration due to the Son of Man at the time once his name is manifested. As the Collins correctly point out, the prose hymn in Philippians “clearly speaks about the preexistence of Jesus … [but] does not imply that Jesus was God or equal to God before his birth as a human being.” In Ehrman’s words, “Paul understood Christ to be an angel who became a human.” Erhman’s definition of the Philippian hymn as an early example of “incarnation christology,” however, is misleading, and his rejection of the parallelism with Adam is unnecessary. Philippians' description of the lowering of the divine “Son” who became human as an act of obedience and was then exalted to an higher degree of divinity parallels the story of the “divine” Adam, the other “Son of God,” who also was created “immortal” like an angel but became “human” (i.e. mortal) as a punishment for his desire of acquiring a higher degree of divinity. Yes, Paul describes Jesus as “a preexistent divine being,” but there is no “incarnation” in Paul; in no place does Paul talk of Jesus as an uncreated being who became flesh. Yes, “Christ could be a divine being yet not be fully equal with God.” Paul is very careful; he never refers to Christ as the “theos,” the only uncreated Maker of All.
The problem is not the Mosaic law or the natural law; the problem is sin. With all Second Temple Jews, Paul acknowledges the presence of evil, and he quotes a passage of Scripture (Eccles. 7:20) to stress that evil is a universal problem. Every Second Temple Jew would have agreed. The problems are the implications and the remedies to this situation.
Paul sides with the apocalyptic tradition of a superhuman origin of evil. With the Enochic traditions, he shares a similar context of cosmic battle between the Prince of Light and the Prince of Darkness—“What fellowship is there between light and darkness? What agreement has Christ with Belial?” (2 Cor. 6:15)—as well as the hope for future redemption from the power of the devil: “The God of peace will soon crush Satan under your feet” (Rom. 16:20). What we can notice, however, is a certain—more pessimistic—view of the power of evil. In the Pauline system, the sin of Adam takes the place of the sin of the fallen angels: “Sin came into the world through one man [Adam], and death came through sin, and so death spread to all because all have sinned” (Rom. 5:12). Adam’s sin is counterbalanced by the obedience of the “new Adam,” Jesus. In order to create the conditions that made necessary the sacrifice of the heavenly Savior, Paul exploits the Enochic view of evil by radicalizing its power. While in Enoch, people (Jews and gentiles alike) are struggling against the influence of evil forces, Paul envisions a postwar scenario where “all, both Jews and Greeks, are under the power of sin” (Rom. 3:9). Adam and Eve have lost the battle against the devil, and as a result, all their descendants have been “enslaved to sin” (Rom. 6:6).
Slavery was an established social institution in the Roman Empire. When Paul was talking of people defeated and enslaved as a result of war, everybody knew exactly what the implications were for them and their children. Once the fight was over, the slaves were expected to resign themselves to their condition. Josephus voices the common sense of his time when he addresses the inhabitants of besieged Jerusalem and reminds them that:
. . . [F]ighting for liberty is a right thing, but ought to have been done at first . . . To pretend now to shake off the yoke [of the Romans] was the work of such as had a mind to die miserably, not of such as were lovers of liberty . . . It is a strong and fixed law, even among brute beasts, as well as among men, to yield to those that are too strong for them. (J. W. 5.365–67)
The Romans admired and honored those who fought bravely for liberty, but despised rebellious slaves and condemned them to the cross. No one could expect the devil to be weaker than the Romans. Freedom could be regained only through the payment of a ransom.
Does that mean that all “slaves” are evil? Not necessarily. Once again, this was a matter of common experience. Being a slave does not necessarily equate to being “unrighteous.” However, slaves are in a
12
very precarious situation since they are not free, and at any moment, they could be commanded by their master to do evil things. Paul never questions the holiness and effectiveness of the Mosaic Torah or implies its failure. On the contrary, he reiterates the “superiority” of the Mosaic Torah and the Jewish covenant that has given to Jews a “a full awareness of the fall” (Rom. 3:10) and the “prophecies” about the coming of the Messiah. It is sin that must be blamed, not the Torah:
The law is holy, and the commandment is holy and just and good. Did what is good, then, bring death to me? By no means! It was sin, working death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. For we know that the law is spiritual; but I am of the flesh, sold into slavery under sin. I do not understand my own actions. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now if I do what I do not want, I agree that the law is good. But in fact it is no longer I that do it, but sin that dwells within me. . . . For I delight in the law of God in my inmost self, but I see in my members another law at war with the law of my mind, making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am! Who will rescue me from this body of death? (Rom. 7:12–17, 22–24)
It is this situation of total enslavement, not an intrinsic weakness of the “good” Torah, that leads Paul to do what the book of the Parables of Enoch had already done: that is, to seek hope for sinners not only in an heroic attachment to the law (according to God’s justice), but also in an intervention of God’s mercy, a gracious offer of forgiveness of sins “apart from the Law” (and God’s justice). The power of cosmic sin determines that “no human being will be justified by deeds prescribed by the law” (Rom. 3:20), but only by a gracious act of “justification by God’s grace as gift, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a sacrifice of atonement by his blood” (Rom. 3:24–25). God had to react to an extreme situation of distress and counterbalance the action of the devil with an extreme act of mercy:
For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Indeed, rarely will anyone die for a righteous person—though perhaps for a good person someone might actually dare to die. But God proves his love for us in that while we still were sinners Christ died for us. Much more surely then, now that we have been justified by his blood, will we be saved through him from the wrath of God. (Rom. 5:6–9)
The entire debate about “justification” and “salvation” in Paul is still too much affected by the framework of Christian theology. As an apocalyptic Jew and a follower of Jesus, Paul claimed that forgiveness of sins was the major accomplishment of Jesus the Messiah for Jews and gentiles alike in the cosmic battle that Jesus fought (and won) against demonic forces. Justification provides to sinners (Jews and gentiles alike) an antidote, or at least, much-needed relief, to the overwhelming power of cosmic evil—a second chance given to people without hope. They were “enemies,” and yet, Christ died for them. In the language of the Parables of Enoch, those Jewish and gentile sinners who have received Baptism have put themselves among the “others” who are neither “righteous” nor “unrighteous,” but are now “repented sinners.” They have no merits to claim, according to God’s justice, but have received justification by the mercy of God.
Already Sanders had noticed that in Paul’s words, people “have been” justified by faith, but “will be” saved by works. (Sanders, 516) In the experience of the members of the Jesus-followers, “justification by faith” belongs to the past, while “judment according to the deeds” belongs to the future. But Sandrs intended this as an universal process through which all humans (jews and Gentiles alike) are saved by grace (as they are included in the new covenant) and their salvation will will be confirmed in the last judgment by the goody will “remain in”: “Paul’s principal view thus seems to be that Christians have been cleansed and established in the faith, and that they should remain so, so as to be found blameless on the day of the Lord” (Sanders, p.452). But “justification by faith” is not “salvation by grace”. For Paul, as for all the first followers of Jesus”, what has already been received through Baptism is forgiveness of sins for the sinners who repent and accept the authority of the Son of Man.
.
Paul is confident that all those who are “justified by faith” in Christ will also be “saved” in the judgment according to the deeds”. Their past sins have forgiven, they have been freed from the power of evil and now they live “in Christ” and are assisted by the Spirit. Paul expected them to produce plenty of good works and remain “blameless”. After all, they have received so much and the time to the end is so short, isn’t it?
but “justification by faith” does not equal salvation.11 Being forgiven of their sins and freed from the power of evil is, for the sinners, an important step on the way to salvation, but it is not a guarantee of future salvation at the judgment where only deeds will be assessed. Hence, Paul continually reminds his readers of the necessity of remaining “blameless” after receiving Baptism, i.e. forgiveness of their past sins. 22Note then the kindness and the severity of God: severity toward those who have fallen, but God's kindness toward you, provided you continue in his kindness; otherwise you also will be cut off. (Rom 11:22)
Paul cannot even sure about his own salvation:
“it is required of stewards that they be found trustworthy. 3 But with me it is a very small thing that I should be judged by you or by any human court. I do not even judge myself. 4 I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. 5 Therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive commendation from God. (1Cor 4:2-5)
[[When the idea of “justification by faith” is not unique to Paul: In the Synoptics Jesus heals (forgives) those who have faith. In Acts Peter repeats to Cornelius that “everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name” (Acts 10:43).]]
On this issue there is perfect agreement between Paul and the other writers of the early Jesus movement.
1 Peter - like the dogs.
“if, after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overpowered, the last state has become worse for them than the first. 21 For it would have been better for them never to have known the way of righteousness than, after knowing it, to turn back from the holy commandment that was passed on to them. 22 It has happened to them according to the true proverb, “The dog turns back to its own vomit,” and, “The sow is washed only to wallow in the mud.” (2 Peter 2:20-22).
Shepherd of Hermes
Conclusion Westerholm finds “inconceivable that [Paul] meant to distinguish an anticipatory justification based on faith … from a final justification based on a different criterion (performance of “works of the law”)” [p.84] This is however what the Book of Parables does 9and what the Synoptics do and what 1 Clement does. The idea of justification by faith and God’s Final Judgment by works harmoniously coexist in that document (and in the Synoptics as well). There is no reason why Paul (and Clement) would not do the same. On the contrary there is an absolute continuity between Enochic sources and early “Christian” sources. The “Enochic” apocalyptic Paul (unlike the “Lutheran” Paul) is perfectly at home within Judaism and within the early Jesus movement.
Having transformed a difficulty of people to be righteous into an impossibility
Having equated “justification by faith” (which Paul preached) with “(eternal) salvation by faith” (which Paul never preached) is one of the major distortions of the Christian reinterpretation of Paul.
Chapter 5: Paul the Controversial Christian vs. James and Peter
Paul was just one voice in a debate that involved and divided the many components of Second Temple Judaism, and his position reflects the general position of the early Jesus movement. We may understand why Paul was viewed with suspicion by other Jews who did not share the apocalyptic idea of the superhuman origin of evil and rejected his emphasis on the mission of forgiveness accomplished by Jesus the Messiah. So, why was Paul also a controversial figure within the early Jesus movement? The answer cannot be attributed only to a natural suspicion toward a person who was long regarded as an “enemy,” and, by his own admission, persecuted the church. For some time has been traditional to attribute
There is something in the theology of Paul that differentiated him from other leaders (such as Peter and James). While other members of the early Jesus movement seem more interested in a perspective of restoration of the twelve tribes of Israel (see the incipit of the letter of James), in Paul, there is a special emphasis on the inclusion of gentiles. It was not a new problem: long before Paul, Jewish-Hellenistic communities had already developed models of inclusion of gentiles into their communities as “God-fearers.”
In the Enochic Book of Dreams we read that, in the world to come, the “white sheep” (the righteous Jews) will be united with the “birds of the sky” (the righteous gentiles) to form the new people of God. In the Parables of Enoch, also, the Messiah Son of Man is indicated as the “light” of the nations.
At the beginning, the members of the Jesus movement do not seem to have been much interested in preaching to gentiles. The gift of eschatological forgiveness could be understood as a special gift reserved exclusively or primarily to the sinners among the children of Israel, without denying the presence of gentiles in the world to come: “I came to the lost sheep of the house of Israel”. The inclusion of some Gentiles could be understood as a possible exception to the rule without denying that the gift was offered to the “children”, as in the story of the meeting of Jesus with the Syrophoenician woman: “[Jesus] said to her: Let the children be fed first, for it is not fair to take the children’s food and throw it to the dogs. But she answered: Even the dogs under the table eat the children’s crumbs.” (Mk 7:28).
In the Synoptic tradition these is the only recorded meeting of Jesus with a gentile. The meeting with “a centurion” at Capernaum in Matthew (8:5-13) and Luke (7:1-10) seems to be more a wishful thought, as the parallel text in John (4:46-53) talks of “a royal official” who under Herod Antipas would have been Jewish. Matthew and Luke inherited a version of the story that had already updated it to the new experience of the church of The later Christian tradition longed for stories that could support their experience about the now pervasive presence of gentiles, and yet the Acts offers a narrative that shows the early community completely unprepared. “the goal of the earliest mission, after all, had been to bring the good news to Israel. And the positive pagan response to the movement’s apocalyptic message had most likely caught the early apostles off-guard: no plan for such a contingency was in place” (Paula Fredriksen, p.94) What is apparent is that Jesus himself left no instruction on the integration of gentiles. (Paula 30)
Not only the first followers of Jesus did not plan any campaign toward gentiles, but the initiative of baptizing gentiles came by gentiles themselves. The first baptism of a gentile was the work of Philip the Evangelist, an Hellenistic Jew and a companion of Stephen who had joined the movement after the death of Jesus and even in this case he did not approach the eunuch, presented as a “God-fearer” well acquainted with the scriptures of Israel, with the intention of baptizing him. It was the eunuch who abruptly confronted Philip with a direct question: “What is to prevent me from being baptized?” (Acts 8:37). The story of the centurion Cornelius follows the same pattern. For the apostles who “were presumably not accustomed to the mixed demography of synagogues in the Diaspora” (Paula, p.95), it must have been very hard indeed to embrace the new perspective. Only reluctantly Peter accepts the invitation by Cornelius (he even needed a dream vision to confirm his choice): “You yourselves know that it is unlawful for a Jew to associate with or to visit a Gentile” (10:28).
and then baptism occurred only as “the gift of the holy Spirit was poured out on the gentiles” ().
The decision of baptizing gentiles does not come from a positive and premeditate commitment, but by “Can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have?” (Acts 10:47) And yet Peter’s decision is meet with great criticism at Jerusalem by circumcised members. The conclusion is that both Jews and Gentile are receiving the same gift of eschatological forgiveness: “God has given even to the Gentiles the repentance that leads to life.” (10:18).
Paul was not the first Second Temple Jew to preach to Gentiles and was not the first Christ-follower to baptize gentile. The Acts 13:1 mentions him as the last in the list of the leaders of the community of Antioch. After Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manean a member of the the court of Heros the ruler”.
Paul joined Barnabas in a missionary trip that should be called Barnas ‘ First missionary journey as Paul was his helper and such he was perceived even by non-Jews. At the market of Lystra; Barnabas was Zeus and Paul Hermes (14:12)
Paul, instead, did it in an apocalyptic fashion, along the lines of texts such as Paul never claimed to have been the first to baptize gentiles. What is distinctive is the enthusiasm with which Paul devoted his life to preaching to gentiles. But there is something that is far more controversial. Paul seemed to have pushed for an equal status of gentiles within the new community.
LETTER TO THE GALATIANS
According to Acts of Apostles, a dispute arose in the early Church whether baptized Gentiles should "be circumcised and ordered to keep the law of Moses." The opinion is attributed to "some believers who belonged to the sect of the Pharisees"--a sign that the divisions within Judaism tended to be replicated within the early Church, as it had already happened with the coming of Hellenistic Jews (the Hellenists led by Stephen and Philip the Evangelist).
Barnabas and Paul led a delegation sent from Antioch to Jerusalem to discuss the matter "with the apostles and the elders." Both Peter and James agreed with Barnabas and Paul that "no further burden" should be imposed on the Gentile believers. They were only asked to "abstain from what has been sacrificed to idols and from blood and from what is strangled and from fornication." In other words, the leaders of the early church agreed on the solution already adopted with success by the Hellenistic-Jewish communities in their relation with the God-fearers.
“This meant no idols. But it also meant no circumcision: gentiles-in-Christ were to remain gentiles, up to and through the End “(see Rom 15:9-12; 16:26-27).
The apparent unanimity did not solve all problems, as attested by the Letter of Paul to the Galatians. Provided that baptized Gentiles were not required to be circumcised or to keep the law of Moses, the controversy exploded on the relation between Jews and Gentile within the community especially during communal meals. Should they sit into separate tables or might they join the same table--Jews and Gentiles, males and females, freepeople and slaves? The Incident at Antioch would soon reveal the profound divisions on this issue between Paul, on one side, and Peter, James, and Barnabas, on the other. James opposed the sharing of tables among Jews and Gentiles, while Paul favored it. Peter was caught in between. At the beginning he conformed with the practice of the Church of Antioch but after "certain people came from James" he "drew back." Barnabas also followed his example. Paul reacted vehemently, confronting Peter and accusing him (and Barnabas) of "hypocrisy." For Paul there is no distinction between Jewish and Gentile members, because they were equally sinners and were equally justified by the grace of God through Jesus. Concerning justification, Jews cannot claim any superiority, unless they deny the grace of God. "I do not nullify the grace of God; for if justification comes through the law, then Christ died for nothing." (2:21).
Contrary to a common interpretation, the incident of Antioch was not a rematch of the Council of Jerusalem. Paul is not addressing the problem of non-Jews who are required to become Jew in order to be baptized. Paul is writing to baptized non-Jews who were invited to become proselytes. [[Paula Fredriksen sees it as s possible reaction by some Christ-followers to the “delay of the end”: “they begun to insist that gentiles in the movement formally affiliate to Israel by receiving circumcision (Gal 2:4)” (Paula, p.103) It is in this context that Paul first talks of “justification by faith”. The gift of forgiveness that they have received in Christ is completely independent from the Mosaic Law. The Law does not have power against cosmic evil.
A gentile does not need to become a proselytes, and by becoming a proselytes would show that the justification he/she received is related to the Law, which is not. If the Law had power against cosmic evil, the sacrifice of the Christ would be pointless: “if justification comes through the law, then Christ died for nothing” (Gal. 2:21).
The second point that Paul makes in the letter is a fundamental distinction between “justification” and salvation. Being freed “by faith” from cosmic sin is an important step, but not sufficient. “I am warning you, a s I warned you before: those who do such things will not inherit the kingdom of God” (Gal. 5:21).
Paul exploited his pessimistic view about the sinfulness of human nature in order to affirm the “equality in sin” of Jews and gentiles within the church. The parting of Christianity from its Jewish apocalyptic roots would lead later Christian theology to wonder whether justification and forgiveness of sins are the same thing; but in the first-century apocalyptic worldview the two terms are synonymous. The most controversial aspect of Paul’s preaching was rather his statement that justification—that is, the gift of forgiveness of sins by the Christ—comes into effect “by faith only.”While most of the first Jewish followers of Jesus would talk of sin as a temptation (allowing a larger role to the freedom of human will), the metaphor of slavery leaves room only for a personal “yes” (and makes meaningless the idea of any prerequisites or any claim of “superiority” of the Jews over the gentiles, and therefore, any rationale for a distinction between the two groups within the new community). If only a “yes” is asked of the sinners, there is no room for “works” and justification is “by faith only.” If, instead, sin is a temptation and sinners maintain a certain degree of freedom, then they can, and should, be asked to “prove” their faith with some “works.” This is the move the letter of James makes by claiming that “a person is justified by works and not by faith alone,” and that “faith apart from works is dead” (James 2:19–26). Justification is the result of a synergy between humans and God:
[God] gives all the more grace; therefore it says, “God opposes the proud, but gives grace to the humble.” Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy into dejection. Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. (James 4:6–10)
Not accidentally, the letter of James does not even mention the death of Jesus; the preaching of Jesus, the “law of liberty” he taught, is the prerequisite for justification. For Paul, instead, the death and sacrifice of Jesus is the only thing that counts as a unilateral and gracious act of mercy: “I do not nullify the grace of God; for if justification comes through the law, then Christ died for nothing” (Gal. 2:21).
The theological dispute had profound practical implications in the life of the church. The incident at Antioch shows that Paul and James had different views of how Jews and gentiles should coexist in the church. James opposed the sharing of tables among Jews and gentiles, while Paul favored it. Peter was caught in between. At the beginning, Peter conformed to the practice of the church of Antioch, but after “certain people came from James,” he “drew back.” Paul reacted vehemently, confronting Peter and accusing him of “hypocrisy.” For Paul, in the communal meals, there is no distinction between Jewish and gentile church members because they were equally sinners and were equally justified by the grace of God through Jesus. Concerning justification, Jews cannot claim any superiority, unless they deny the grace of God: “I do not nullify the grace of God; for if justification comes through the law, then Christ died for nothing” (Gal. 2:21).
DID PAUL THE APOCALYPTIC JEW ABOLISH THE TORAH?
Does that mean that Paul “abolished” the distinction between Jews and gentiles in this world tout court? This
does not seem to be the case.
“Paul maintains, and nowhere erases, the distinction between Israel and the nations” (Paula, p.114)
At the same time they are not “God-fearers”, affiliated to Judaism, but full members, “engraved” as living branches on the olive tree of Israel. How can we make sense of these (apparently conflicting) statements?
Very interestingly, Paul’s famous saying about the equality between Jews and gentiles comes in a broader context that included “male and female” and “slave and free”: “There is no longer Jew or Greek, there is no longer slave or free, there is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus” (Gal. 3:28). The attitude of Paul toward Gentiles must be studied not in isolation but in parallel with his attitude toward women and slaves. In Paul’s view, these categories are somehow altered in this world; there is no longer enmity and opposition in Christ.
In the words of Nanos, “it is fundamental to the truth of the Gospel that difference remains, that social boundaries are acknowledge, but that discrimination should not.” (Nanos 40) There is no abolishment in this word,
Yet, none of these categories is abolished. Paul asks Philemon to welcome his fugitive slave Onesimus as a brother in Christ, and yet, does not tell Philemon to free all his slaves, using the argument that in Jesus Christ, there is no longer slave or free. Paul mentions Priscilla before her husband, Aquila, in the ministry of Christ (Rom. 16:3–4), and yet, reiterates that “the head of the woman is the man” (1 Cor. 11:3) when he could have claimed that in Jesus Christ, there is no longer male and female. Paul proclaims the end of any enmity between Jews and gentiles in Christ, and yet . . . Why should he have claimed only in this case that such a distinction is no longer valid? Ironically, traditional Christian theology has stressed the definitive “end” of the distinction between Jews and gentiles as a divine decree and has never taken an equally strong stance about the “abolishment” of any distinction of gender and social status. Either Paul abolished all three categories or he did not abolish any of them.
For the apocalyptic Paul there was no ambivalence • For Paul the distinctions between Jews and non-Jews, males and females and free and slaves belong to this world and will be abolished in the word to come. (In the Enochic Animal Apocalypse it is clearly stated that all different species will become one in the world to come) • The coming of the end modified radically the relations between Jews and non-Jews, male and female, free and a slave but does not abolish these distinctions, yet. They will be abolished only in the new creation. • The communal meals in which the new community is reunited, already anticipate this reality, Therefore Jews and non-Jews can sit at the same table, eating the same food (although Paul recommend to be respectful if somebody is not strong enough), women may prophesize and slaves are “brothers”. But outside of that mystical moment in which the members of the community partake with the angels in the world to come, in the everyday life these distinctions are not abolished. Scholars have noticed the same tension It I unlikely that Paul and the first followers of Jesus intended the egalitarian words of Galatians as a political manifesto (see . For Paul gender, ethnic , social distinction will not be abolished in this world, but in the world to come. Paul believed that they were abolished in the communal meals “before the angels” They wer not unaltered but transformed. The “cosmopolitan ideal” of Paul is not a philanthropic or philosophical move byt the resul between
Karin B. Neutel, A Cosmopolitan Ideal: Paul's Declaration 'Neither Jew Nor Greek, Neither Slave Nor Free, Nor Male and Female' in the Context of First-Century Thought (The Library of New Testament Studies) 2016.
Chapter 6: Summary and Conclusion
The analysis restores the image of Paul as a preacher of God’s love not as a preacher of hatred and intolerance. Paul was not a prophet of doom condemning to hell everybody (Jew or Gentile) who does not admit to be a sinner and does not believe in Jesus. Paul was an herald of God’s Mercy toward the sinners. You can now summarize the basic convictions which governed Paul, as follows: (1) God has called all humans to righteousness, having revealed them God’s will (what is good and what is evil)—the Jews according to the Torah, the Gentiles according to the natural law. There are no excuse nor favoritism: at the end each will be judged according to their deeds (2) because of the fall of Adam (seduced by the Devil) all humans are affected by the power of evil, This cosmic rebellion, which happened “apart for the law”, limits their capability to obey God’s will, making harder (not impossible) for the individual to be “righteous”. Humans are victims of evil no less than responsible for evil. (3) God however is not cruel. At the end he will compensate this act of rebellion with an act of grace “apart from the law”, by offering the sinners a possibility of justification “apart from the Law” so that the Law be restored. (4) This gracious act is for Paul the coming and death of Jesus the Messiah, who came as the forgiver, so that through his death God could provide for the justification of all sinners who have faith in him (Jews first and Gentiles alike), (5) Paul believed that he was called to be in particular as the messenger of this opportunity of justification to Gentile sinners, whereas other apostles concentrated on Jewish sinners. (6) Jesus will soon return as the final Judge “according to the deeds”, as the savior of the righteous (Jews and Gentile alike) as well as of the (former) sinners who, justified by faith, have remained “righteous” in Christ.
A Paul that is not isolated in totally unique but is equally at home in the Second Temple Judaism and in the early Jesus movement.
Time is ripe for a new synthesis (paradigm) that without disproving the achievements of the past will incorporate the new results of research.
WHERE THE TRADITIONALISTS HAVE FAILED The traditional has highlighted the centrality of “grace” in Paul justification by faith as a gracious act of God’s mercy, but has failed to understand properly the function and the limits that in its original apocalyptic context this special eschatological gift offered to the sinners had in order to counterbalance the power of evil. The individual’s Judgment remains “according to the deeds”.
By transforming the apocalyptic plea about the power of evil into an ontological impossibility to do good,
It is true that “sinners for whom Christ died are declared righteous by God when they place their faith in Jesus Christ” (Weserholm, 22).
But the message of Paul is that all human beings (Jews and gentiles) are “under the power of evil” not that they are “Paul’s message of justification … does not address a need peculiar to Gentiles, but the need of all human beings – Jews like Peter and Paul no less than Gentiles like the Galatians – inasmuch as all are sinners” (Westerholm, 15). The message of forgiveness is addressed to all (Jews and Gentiles) but is limited to the sinners, not to the righteous.
WHERE SANDERS HAS FAILED. Sanders has been a landmark, a masterpiece. It has redeemed Pauline studies from their most derogatory anti-Jewish elements. Disproving in particular the opposition between grace and law. Sanders’ conclusions however need to be revisited and updated Paul did not present, as Sanders concluded, “an essentially different type of religiousness from any found in Palestinian Jewish literature” (Sanders, 543) nor does he “explicitly denies that the Jewish covenant can be effective for salvation thus consciously denying the basis of Judaism” (Sanders, 551). On the contrary, Paul Justification is by faith, but judgment is according to works. It is true that “the main theme of Paul’s gospel was the saving action of God in Jesus Christ and how his hearers could participate in that action” (Sanders, 447) Paul never affirmed that “since salvation in only by Christ, the following of any other path is wrong. … Christ has put an end to the law and provides a different righteousness from that provided by Torah obedience” (Sanders, 550) Christ came for the sinners, not for the righteous. He offered not salvation but forgiveness of sins, before returning as the final judge of an universal judgment according to the deeds. The Christ-believers have been cleansed of their former sins. They are no longer under the power of sin. The y live in Christ. However, they are not saved yet.
Gager: Preached to Gentiles! No, Paul preached to Gentile sinners
Paul was a Second Temple Jew, a former Pharisee who became a member and a leader of the early Jesus movement. Like many Second Temple Jews (also outside the Jesus movement), as a result of his decision (which should not be call a “conversion,” but a move within Judaism) Paul embraced the apocalyptic view of the superhuman origin of evil and looked at the sinners not only as people responsible for their own actions, but also as victims of a supernatural evil. Like others, he wished for, and expected, some help from heaven to counterbalance the power of evil.
With the other members of the Christian group, Paul shared the idea that Jesus the Messiah had come to earth as the Son of Man to bring forgiveness to sinners, and he believed that Jesus would soon return to carry out a judgment. More than other members of the early Jesus movement, Paul strongly believed that this message of forgiveness included gentile sinners as well, and he decided to devote his life to preaching to the gentiles. Contrary to other members of the Jesus movement, he refused to accept that baptized gentiles had a different or inferior status within the church, as he could not see any distinction between a Jewish sinner and a gentile sinner: they had both been forgiven “by faith only.” This does not mean that he advocated the abolishment of the distinction between Jews and gentiles in this world; on the contrary, as in the case of gender and social distinctions, he accepted it as an inevitable (and perhaps, even providential) reality until the end of times, when these distinctions would eventually disappear.
Having received as a Jews the gift of eschatological forgiveness promised by Jesus to the “lost sheep” of the House of Israel, Paul decided to devote his life to the “lost sheep” among the nations
Paul believed that justification occurred “apart from the law” and was an eschatological gift to be received “by faith alone”, but never intended it as an exclusive path to salvation, as the universal final judgment will be according to the deeds.
As a Second Temple Jew, Paul never questioned the validity of the Torah; his only concern was the difficulty of people to obey the Torah. Paul was a Torah-observant Jew who believed that “justification by faith” was an eschatological gift offered through Jesus the Messiah to all “sinners” (not only to gentiles) in the imminence of the final judgment. Does that mean that he believed that Jews should abandon the obedience of the Torah and that no Jew could be saved without Baptism? Not at all. While repeating the common Jewish teaching that “all people are sinners,” Paul shared the apocalyptic idea that the judgment will be according to deeds and that humankind is divided between the “righteous” and the “unrighteous.” But now that the time of the end has come, the unrighteous have been offered the possibility to repent and receive justification through forgiveness. Paul preached to gentiles, but his message was neither addressed to gentiles only nor uniquely pertinent to them. Exactly the same gospel was announced to Jews and gentiles—the good news of the gift of forgiveness: “I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised” (Gal. 2:7). Paul had a more pessimistic view of the power of evil. He compared the situation of humankind to a population defeated and enslaved by the devil, but he would have shared the principle that only the sick need a doctor. The sick include Jews and gentiles alike, although not all of them. The righteous do not need a doctor. And he never intended ‘Justification by faith” as a substitute for “judgment according to the deeds”. He expected all those justified and now living in Christ to be saved because their past sins had been forgiven and their life was now filled with good deeds. But he did not take it for granted, not even for himself; Justification by faith was a way to restore (not annul) human responsibility and restore the covenant. To say that all humans must believe in Christ in order to be saved is a misrepresentation of Paul’s preaching. To say that the Jews have the Torah while the gentiles have Christ also does not faithfully represent the position of Paul. In Paul’s view, Christ is God’s gift not to gentiles, but to sinners. The righteous (Jews and gentiles) will be saved if they have done good deeds. But Paul is conscious of the fact that the power of evil makes it hard for all humankind to be righteous: for the Jews to follow the Torah and for the gentiles to follow their own conscience. He preaches the good news that, at the end of times, sinners (Jews and Gentiles alike) are offered the extraordinary possibility to repent and be justified in Christ by God’s mercy apart from God’s justice. Paul was not Lutheran: he never taught “salvation by faith only” to humankind, but announced to sinners, “justification (that is, forgiveness of past sins) by faith.” Paul did not preach only two ways of salvation, but rather three: righteous Jews have the Torah, righteous gentiles have their own conscience, and sinners—Jews and gentiles alike, who have fallen without hope under the power of evil—have Christ the forgiver.
BIBLIOGRAPHY
Barclay, John M.G.
- Paul and the Gift (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2015)
Arnold, Brian J.
. Justification in the Second Century (Minneapolis, MN: Fortress Pres, 2013)
Beker, J.C.
. Paul the Apostles: The Triumph of God in Life and Thought (Philadelphia: Fortress Press, 1980)
. Paul’s Apocalyptic Gospel: The Coming Triumph of God (Philadelphia: Fortress Press, 1982)
(online) Blackwell, Ben C., John K. Goodrich, and Jason Maston, eds.
. Paul and the Apocalyptic Imagination (Minneapolis: Fortress Press, 2016)
(OK) Boccaccini, Gabriele.
. Middle Judaism: Jewish Thought, 300 BCE to 200 CE (Minneapolis: Fortress Press, 1991)
. Roots of Rabbinic Judaism: An Intellectual History, from Ezekiel to Daniel (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002)
(OK) Boccaccini, Gabriele, and Carlos A. Segovia, eds. Paul the Jew: Rereading the Apostle as a Figure of Second Temple Judaism (Minneapolis: Fortress Press, 2016)
Boyarin, Daniel.
. A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity (Berkeley: University of California Press, 1994)
. The Jewish Gospels: The Story of the Jewish Christ (New York, NY: New Press, 2012)
(U-M) Campbell, Douglas A.
. The Deliverance of God: An Apocalyptic Rereading of Justification in Paul (Grand Rapids, MI: Eerdmands, 2009)
Chiala, Sabino.
. Libro delle Parabole di Enoc: testo e commento (Brescia: Paideia Editrice, 1997)
Collins, John J.
. The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature (2nd ed.; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998)
Davies, J.P.
. Paul Among the Apocalypses?: An Evaluation of the ‘Apocalyptic Paul’ in the Context of Jewish and Christian Apocalyptic Literature (London: Bloomsbury T&T Clark, 2016)
Eisenbaum, Pamela Michelle.
. Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle (New York, NY: HarperOne, 2009).
Fredriksen, Paula.
. Paul the Pagans’ Apostle (New Haven: Yale University Press, 2017)
Gager, John J.
. Reinventing Paul (Oxford: Oxford University Press, 2000)
Gaston, Lloyd.
. Paul and the Torah (Vancouver: University of British Columbia Press, 1987)
Matlock, R. Barry.
. Unveiling the Apocalyptic Paul: Paul’s Interpreters and the Rhetoric of Criticism (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996)
Nanos, Mark D.
. Reading Paul within Judaism (Eugene, OR: Cascade Books, 2017) <ok>
Neutel, Karin B.
. A Cosmopolitan Ideal: Paul's Declaration 'Neither Jew Nor Greek, Neither Slave Nor Free, Nor Male and Female' in the Context of First-Century Thought (The Library of New Testament Studies; London: Bloomsbury T&T Clark, 2016).
Nickelsburg, George W.E.
. 1 Enoch 1 (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress Press, 2001) <ok>
Nickelsburg, George W.E., and James C. VanderKam.
. 1 Enoch 2 (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress Press, 2012) <ok>
Patterson, Stephen J.
. Forgotten Creed: Christianity’s Original Struggle Against Bigotry, Slavery, and Sexism (Oxford: Oxford University Press, 2018)
Peppiatt, Lucy.
. Women And Worship at Corinth: Paul’s Rhetorical Argument in 1 Corinthians (Cambridge: James Clarke & Co., 2017) <online>
. Unveiling Paul's Women: Making Sense of 1 Corinthians 11:2-16 (Eugene, OR: Cascade Books, 2018)
Pesce, Mauro.
. Le due fasi della predicazione di Paolo (Bologna: Dehoniane, 1994)
Protho, James B.
. Both Judge and Justifier: Biblical Legal Language and the Act of Justifying in Paul (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018) <UM-ok>
Sacchi, Paolo.
. Jewish Apocalyptic and Its History (JSPSup 20; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997)
. The History of the Second Temple Period (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000)
Sanders, E.P.
. Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion (London: SCM Press, 1977) <UM-ok>
Segal, Alan F.
. Paul the Convert: The Apostolate and Apostacy of Saul the Pharisee (New Haven: Yale University Press, 1990)
Stendahl, Krister.
. “Paul and the Introspective Conscience of the West,” HTR 56 (1963): 199-215
. Paul among the Jews and Gentiles (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1976>
Stowers, Stanley K.
. A Rereading of Romans: Justice, Jews, and Gentiles (New Haven: Yale University Press, 1994)
Stuckenbruck, Loren T., and Gabriele Boccaccini, eds.
. Enoch and the Synoptic Gospels: Reminiscences, Allusions, Intertextuality (Atlanta, GA: SBL Press, 2016)
Thomas, Matthew J.
. Paul’s ‘Works of the Law’ in the Perspective of Second Century Reception (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018) <UM-ok>
VanLandingham, Chris.
. Judgment & Justification in Early Judaism and the Apostle Paul (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2006) <ILL-R>
Westerholm, Stephen.
. Perspectives Old and New on Paul: The “Lutheran” Paul and His Critics (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2004) <ILL-R>
. Justification Reconsidered: Rethinking a Pauline Theme (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2013) <ILL-OK>
Wright, N.T.
. Paul and the Faithfulness of God (Minneapolis: Fortress Press, 2013)
. The Paul Debate: and His Recent Interpreters (Minneapolis: Fortress Press, 2015) <R-ILL>
. Paul and His Recent Interpreters (Minneapolis: Fortress Press, 2015) <UM-OK>
Yinger, Kent L. Paul.
. Judaism and Judgment According to Deeds (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) <UM-OK>
Zetterholm, Magnus.
. Approaches to Paul: A Student’s Guide to Recent Scholarship (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2009) <UM>